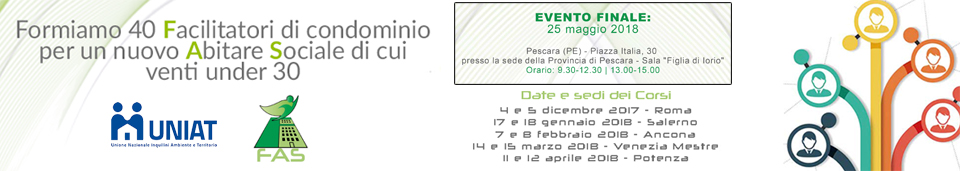Widgetized Section
Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone
Quando non è il Diavolo a fare paura
Autore : Maria C. Fogliaro
Pubblicato il : 15-12-2015
di Maria C. Fogliaro
«La mente è un intero universo», dice il dottor Raines (David Thewlis) al detective Kenner (Ethan Hawke) in Regression (Usa, 2015, 106’), l’ultimo film di Alejandro Amenábar.
È il 14 ottobre 1990, e a Hoyer − una cittadina di fantasia collocata nel Minnesota − Bruce Kenner sta indagando sul caso di Angela Gray (Emma Watson), una diciassettenne che − dopo aver trovato rifugio nella casa del reverendo Murray (Lothaire Bluteau), pastore di una Chiesa evangelica locale − denuncia il padre John (David Dencik) per molestie sessuali.
Già nei primi minuti del film emerge un particolare disorientante: John non ha memoria dei fatti di cui la figlia lo accusa, ammette di non ricordare, eppure assume su di sé la colpa. Perché? Le cose si complicano ulteriormente quando − anche a causa delle tecniche di ipnosi regressiva cui il signor Gray viene sottoposto dal dottor Raines e volte far riemergere i ricordi rimossi − la scena si popola di volti, di uomini e di donne, di giovani e di vecchi, incappucciati e dediti a riti sacrileghi. Questo è il nodo da sciogliere − l’intreccio infernale (in molti sensi) su cui Bruce Kenner dovrà far luce −.
Ispirandosi a fatti realmente accaduti, Amenábar cerca di tornare, con questo suo ultimo film, alle atmosfere cupe e inquietanti per le quali, in passato − per opere come Tesis (1996) o The Others (2001) − è stato acclamato dalla critica e dal pubblico, senza che tuttavia questa volta riesca pienamente nel suo intento.
Non tutto, infatti, convince in Regression − a partire dalla sceneggiatura −. Conosciamo subito la famiglia di Angela. I Gray vivono una situazione di estremo disagio: Rose (Dale Dickey), la nonna, è una donna triste e rassegnata; John, il padre, ex alcolista, ha cercato conforto nella Chiesa evangelica per sopportare il dolore per la perdita prematura della moglie; il fratello Roy (Devon Bostick) è scappato di casa ed è andato vivere in uno squat. Ma il racconto cinematografico nel suo procedere è insidiato da un intreccio narrativo che tende a spezzare il ritmo del film e rischia di confondere lo spettatore: sette sataniche, psicosi collettive, demoni interiori, l’intento di collocare i fatti all’interno di una visione scientifica, danno vita a un thriller psicologico che insegue il racconto poliziesco, che a tratti cede anche a influenze tipiche del genere horror (come testimoniano i molti omaggi al cinema americano degli anni Settanta), ma che alla fine si rivela incapace − nonostante lo scenario suggestivo, valorizzato dalla fotografia dai colori intensi e saturi − di dare vita a situazioni veramente drammatiche e cariche di suspense.
Se, tuttavia, si va oltre ciò che il film sembra essere − e cioè un thriller popolato da spaventose entità e incentrato sul paranormale −, allora la pellicola si trasforma in un altro racconto, più intenso ed avvincente. Il tema conduttore di Regression è una lettura di fatti realmente accaduti negli Stati Uniti, tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, e che hanno interessato il fenomeno delle sette sataniche. Qui sotto la lente di ingrandimento è quella sorta di allucinazione collettiva che ha finito per colpire un’intera comunità, anche a causa dell’azione nefasta dei mass-media. «Non si tratta di una leggenda − si sente infatti dire alla radio, durante il film −: i satanisti sono qui, vivono in mezzo a noi, e come ogni altro gruppo religioso adorano il loro Signore, in questo caso il Diavolo».
Man mano che il film procede il regista ci mostra il vero agente demoniaco, misterioso e malefico, al quale nessuno sembra potersi sottrarre: la manipolazione, in tutte le sue forme, che si serve degli affetti e si fa largo attraverso le miserie umane − la esercita Angela nei confronti del padre, il reverendo Murray sui propri fedeli, lo scienziato e i media sulla società, il detective quando, preda delle proprie ossessioni, mente a se stesso −. È un mondo privo di grandezza quello messo in scena da Amenábar, una realtà nella quale a dominare non è tanto lo scontro manicheo fra Bene e Male, quanto la volontà di dominio di narrazioni (apparentemente) opposte: scienza e fede, con la loro pretesa di risolvere − ciascuna a proprio modo − la precarietà dell’esistenza umana, manipolano l’uomo e lo assoggettano, proprio istillandogli l’illusione di essere il centro del mondo. Contro questo messaggio si ribella, forse, il giovane Roy, quando si scaglia contro il dottor Raines e contro il prete.
Il film si dimostra, quindi, capace di muoversi su piani di realtà differenti, mentre Ethan Hawke, sfiorando meccanismi profondi e mostrando i conflitti latenti nella profondità della psiche, offre un’interpretazione coinvolgente, dando vita a un personaggio nelle cui inquietudini è facile per lo spettatore arrivare a specchiarsi.
Posts
-
 Cartoline da un paese non ordinario di Marco Benni
by Tavanti - 507 Comments
Cartoline da un paese non ordinario di Marco Benni
by Tavanti - 507 Comments
- In rampa di lancio la Concorsi spa (da italiaoggi del 24/3/12) by riformalavoro - 370 Comments
-
 Bologna Lavoro, intervista all’assessore Frascaroli
by Redazione - 32 Comments
Bologna Lavoro, intervista all’assessore Frascaroli
by Redazione - 32 Comments
-
 Premi 2010, sgravi ?fermi? (da ilsole24ore del 31/3/12)
by riformalavoro - 28 Comments
Premi 2010, sgravi ?fermi? (da ilsole24ore del 31/3/12)
by riformalavoro - 28 Comments
-
 Giovedì 16 maggio 2013 ore 21 sala Marco Biagi – Baraccano – Quartiere – via Santo Stefano 119 – Bologna
by Redazione - 26 Comments
Giovedì 16 maggio 2013 ore 21 sala Marco Biagi – Baraccano – Quartiere – via Santo Stefano 119 – Bologna
by Redazione - 26 Comments
KarenAlcon: VITA DA SCHIAVI O LIBERI DI SCEGLIERE?
Michaelcog: VITA DA SCHIAVI O LIBERI DI SCEGLIERE?
nba중계: In ricordo di Vittorio Capecchi, un anno dopo
KarenAlcon: VITA DA SCHIAVI O LIBERI DI SCEGLIERE?
Michaelcog: VITA DA SCHIAVI O LIBERI DI SCEGLIERE?