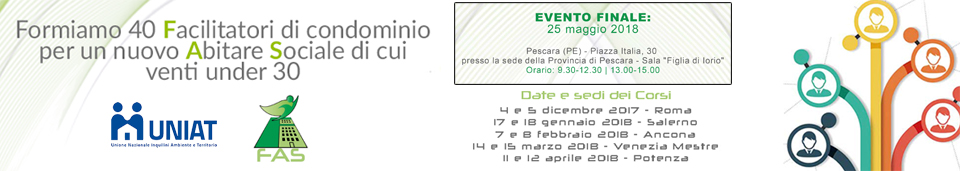Widgetized Section
Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone
Spotlight. Il giornalismo come missione
di Maria C. Fogliaro

«Io trovo che la città sia in buona salute quando le grandi istituzioni lavorano insieme» afferma Bernard Francis Law (Len Cariou), arcivescovo di Boston, rivolgendosi a Marty Baron (Liev Schreiber). Ma Baron, fresco di nomina alla direzione del «Boston Globe», non è d’accordo: «Personalmente ritengo che affinché un giornale svolga al meglio la sua funzione debba agire da solo». È in questo breve scambio di battute che possiamo trovare il centro intorno al quale ruota Il caso Spotlight (Spotlight, USA, 2015, 128’), l’ultimo film di Tom McCarthy scritto insieme a Josh Singer.
Siamo nel 2001, e al «Boston Globe» la sezione investigativa Spotlight − formata da Walter “Robby” Robinson (Michael Keaton), Mike Rezendes (uno straordinario Mark Ruffalo), Sacha Pfeiffer (Rachel McAdams) e Matt Carroll (Brian d’Arcy James), e che fa riferimento a Ben Bradlee Jr. (John Slattery), figlio di Ben Bradlee, giornalista di punta del «Washington Post» ai tempi del Watergate − viene incaricata dal nuovo direttore, appena arrivato da Miami, di investigare approfonditamente su un caso che lo stesso giornale aveva in precedenza derubricato a semplice fatto di cronaca: quello di Padre Gheoghen, un prete che aveva molestato numerosi bambini in sei diverse parrocchie della città negli ultimi trent’anni. Ma, a ben guardare, c’è molto di più. L’avvocato delle vittime, Mitch Garabedian (un eccellente Stanley Tucci), sostiene di poter provare che il cardinale Law sapeva tutto da quindici anni e non aveva fatto niente. È davvero così? I documenti sono secretati e Baron decide di impugnare l’ingiunzione protettiva nel caso Gheoghen: questo significa portare la Chiesa, nella cattolicissima Boston, in tribunale.
Basato su fatti realmente accaduti, Spotlight ricostruisce l’inizio della lunga e faticosa inchiesta giornalistica che portò alla condanna per reati di pedofilia, commessi a partire dagli anni Settanta, di quasi cento sacerdoti nella sola diocesi di Boston, aprì la strada ad analoghe rivelazioni in altre città degli Stati Uniti e fece ottenere al «Boston Globe» il premio Pulitzer nel 2003.
Per tutto il film, con caparbietà e tenacia, i quattro reporter scavano meticolosamente negli archivi, analizzano documenti, avvicinano − con pudore e rispetto − le vittime, intervistano avvocati e testimoni, e mentre scrutano pazientemente fra i dettagli portano alla luce scabrosità e zone d’ombra del mondo che essi stessi abitano. Emergono così gli abusi fisici e psicologici nei confronti di bambini appartenenti a famiglie povere e disagiate; il senso di vergogna e di umiliazione che ancora accompagna coloro che − ormai adulti − si sentono dei «sopravvissuti»; il silenzio colpevole di Law e la copertura assicurata (dentro e fuori l’istituzione ecclesiastica) ai carnefici, che invece di essere rimossi e denunciati venivano trasferiti da una parrocchia all’altra, mentre le vittime e le loro famiglie ottenevano miseri risarcimenti economici insieme alla “comprensione” da parte della Chiesa per quanto accaduto.
Ma l’elemento centrale della vicenda è il contesto sociale e civile in cui prende piede l’inchiesta: la «piccola città», dove i rapporti personali e il continuum fra le diverse istituzioni creano un sistema di relazioni, di amicizie, di convenienze e connivenze difficile da scalfire. Saranno infatti due “intrusi” − Marty Baron (un perfetto Liev Schreiber), appena arrivato in città e percepito con disappunto come «uno scapolo di religione ebraica che odia il baseball», e Mitch Garabedian, l’avvocato di origini armene − a non fermarsi alle apparenze e alle dichiarazioni ufficiali, e a spingere per la ricerca della verità.
Spotlight è un film avvincente, che cerca − senza inutili sentimentalismi o trionfalismi − il coinvolgimento emotivo dello spettatore; e ci riesce, grazie alla colonna sonora (capace di creare aspettative e tensione) e soprattutto alla bella prova interpretativa degli attori che danno vita ai reporter, i cui volti − catturati da attentissimi primi piani − parlano, e raccontano il duro lavoro e lo sforzo anche psicologico di una professione intesa come missione. Sulla falsariga del memorabile Tutti gli uomini del Presidente (il film di Alan J. Pakula del 1976 sull’inchiesta che portò al Watergate) − ma radicalmente differente per contesto, indagine e ritmo −, in Spotlight c’è su tutto l’esaltazione americana della responsabilità sociale della stampa (e quindi dell’opinione pubblica) come «cane da guardia della democrazia». Nonostante nella realtà ci sia spesso continuità fra potere mediatico e potere economico-politico, questo film conferma che gli USA − almeno nella loro autonarrazione − continuano ad avere come stella polare l’ideale della democrazia popolare, di cui la libera stampa − capace di combattere le disfunzioni del potere (sia esso politico, economico o religioso) e di informare i cittadini per promuovere il bene pubblico − è il simbolo più potente.