Widgetized Section
Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone
«Lo Svedese» di Ewan McGregor
di Maria C. Fogliaro
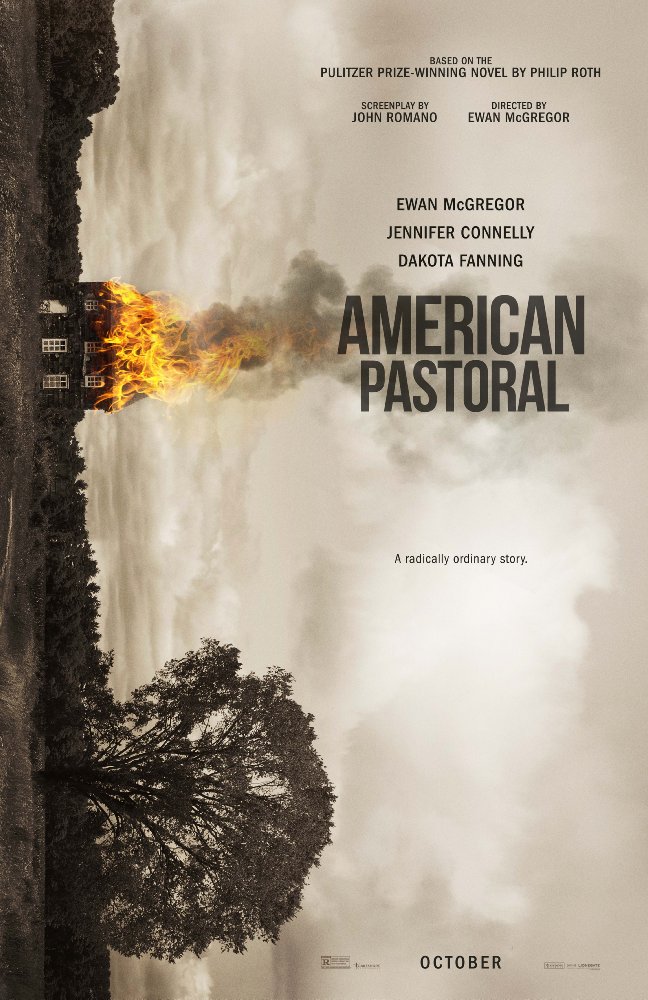
Per chi aveva frequentato la high school di Newark (New Jersey) negli anni Quaranta «lo Svedese» era stato un nome magico. Occhi azzurri e capelli biondi; bello e carismatico; gloria del football e del baseball a scuola; volontario nei marines nel Quarantaquattro; businessman di successo dopo la guerra; figlio, marito e padre impeccabile: Seymour Irving Levov (Ewan McGregor) − questo il suo vero nome − per la comunità ebraica di Newark era l’incarnazione del sogno americano, e un mito per generazioni di studenti. Così, almeno, lo ricordava Nathan Zuckerman (David Strathairn), affermato scrittore sessantaduenne, che in gioventù era stato il migliore amico di Jerry Levov (Rupert Evans), il fratello minore di Seymour. E così, effettivamente, era stato lo Svedese: prima del diluvio.
Di nuovo a Newark, dopo tanti anni all’estero, per partecipare a una riunione con i suoi vecchi compagni del college, Zuckerman incontra inaspettatamente Jerry, anche lui appena rientrato in città dalla Florida, ma non per festeggiare: suo fratello, lo Svedese, è morto, ed egli è tornato per il suo funerale. È in questa circostanza che Nathan apprende dal suo vecchio amico che Seymour Levov – «il migliore di tutti», «il nostro eroe», «il nostro Kennedy», il «giovane uomo dal quale ci saremmo aspettati solo successi» – ha visto la sua vita andare in frantumi. «Avrei dovuto immaginarlo – afferma Jerry –: il famoso scrittore è l’ultimo a conoscere la grande storia».
Inizia così American Pastoral (USA, 2016, 126’), il film che segna l’esordio alla regia di Ewan McGregor. La vicenda, frutto dell’adattamento di John Romano dell’omonimo romanzo di Philip Roth, si sviluppa da un lungo flashback − che la musica di Alexandre Desplat accompagna con coerente adattabilità, sostenuta dal montaggio di Melissa Kent − sulla vita di Seymour Levov, dalla fine degli anni Quaranta al giorno della sua morte. Terminata la Seconda guerra mondiale, lo Svedese va a vivere nella ricca Old Rimrock insieme a Dawn Dwyer (Jennifer Connelly) − ex Miss New Jersey −, che ha sposato dopo aver superato le resistenze del padre Lou (Peter Riegert), inizialmente restio, in virtù dell’origine ebraica dei Levov, a vedere il figlio legarsi per la vita a una donna cattolica. Mentre Seymour si reca ogni giorno a Newark per dirigere la fiorente azienda di guanti ereditata dal padre, Dawn si occupa delle sue mucche e dell’amatissima figlia Merry (a otto anni interpretata da Ocean James e a dodici da Hannah Nordberg), una bambina sveglia e sensibile, con un problema di balbuzie non troppo penalizzante, che induce però i due attenti genitori a rivolgersi a una psicologa (Molly Parker). Tutto sembra andare a gonfie vele per la giovane famiglia Levov, ma la felicità piena raramente dura a lungo.
È con l’adolescenza di Merry – che coincide con la presidenza di Lyndon B. Johnson (1963-1969) – che quel quadro perfetto si rompe. Fin da bambina capace di sentire come propria la sofferenza degli altri, Merry appena sedicenne (interpretata da Dakota Fanning) entra attivamente nella storia di quegli anni elettrizzanti e terribili, rifiutando il razzismo, l’ingiustizia, l’ipocrisia che vede reggere la società americana. Matura così un odio profondo per il governo, e la sua «sporca guerra» in Vietnam. Ma anche per la propria famiglia – per la madre soprattutto –, sebbene in realtà i suoi genitori avversino la stessa guerra e rifiutino le medesime ingiustizie che tormentano la giovane, in nome di una condotta di vita e di ideali progressisti e democratici. Entrata in contatto con un gruppo estremista che predica la lotta armata, Merry – forse prendendo alla lettera una frase pronunciata con amore dal padre – finisce col «portare la guerra in casa». Una bomba esplode all’ufficio postale di Newark e un uomo perde la vita. E Merry, che sembra coinvolta nell’attentato, sparisce.
Per i Levov è la fine del sogno e della vita felice. A questo punto, la regia – pur rimanendo aderente per tutto il film all’opera dello scrittore americano – si preoccupa di portare in primo piano il dramma, la solitudine, e la sconfitta senza pace di Seymour Levov. E lo fa con garbo e serietà, senza gesti plateali, con inquadrature che mirano a scrutare volto, atteggiamenti, azioni e reazioni del protagonista, per catturarne l’intimo tormento. Il film è una rappresentazione della catastrofe morale e spirituale che si abbatte sullo Svedese, la figura centrale attorno alla quale si muovono altre vite in rovina: quella della figlia Merry, che per il padre è «soltanto una ragazzina ribelle con dei grandi ideali non elaborati bene» − affidata (aggiungiamo noi) alle cure di una discutibile psicologa −, cui la violenza che vuole combattere, e alla quale invece si dà, toglie tutta l’originaria purezza; e quella della moglie Dawn, che la depressione, che la porta sull’orlo della pazzia, trasforma in apparenza (un muto dolore l’accompagnerà, in realtà, per sempre) in ciò che era sempre stata accusata di essere, ma che in fondo non era mai stata: solo «un bel dipinto», la reginetta di bellezza.
Lasciata sullo sfondo la dimensione sociale e politica che spicca nel libro, e che pure il film incrocia − con i continui riferimenti alle ingiustizie, ai disordini razziali e all’impazzimento di frange giovanili che rimasticano parole d’ordine di cui non comprendono la portata −, vediamo lo Svedese trasformarsi definitivamente in un altro uomo a causa di una scelta non sua − come per l’azione di un parassita che, in segreto, svuota dall’interno un baco, che così non diventerà mai farfalla −. Indifeso di fronte all’insensatezza della vita e tormentato dal senso di colpa, il suo percorso va dalla superficie lineare, senza increspature, di una vita quasi mitica (Levov prima della caduta ricorda in alcuni tratti Edward Bloom, il personaggio interpretato da McGregor in Big Fish di Tim Burton) − simbolo dell’ottimismo degli anni Cinquanta, quando l’America era il regno delle infinite possibilità − alla profondità abissale di una notte dell’anima che non ha fine e che gli impedisce, per tutto il tempo che gli rimane da vivere, di sentire il mondo come casa propria.
McGregor − a dispetto delle critiche che lo accusano di incapacità di portare in scena la grandezza che dal libro di Roth emana −, da attore esperto, sa che infinite sono le possibilità di rappresentazione di un dramma (senza considerare il fatto che un film non si esaurisce nella sola trama), e si prende la responsabilità di dire quello che vuole e di dare al suo personaggio la propria voce. E così ha creato il suo Seymour Levov, un uomo frantumato, un vinto, impreparato ad affrontare il tragico che della vita è parte e quindi ad accettare «il gioco del mondo con se stesso», ma che tuttavia non riusciamo a non sentire nostro per il rigore morale e per l’umana dignità che lo accompagnano, da vero eroe, fino alla fine.






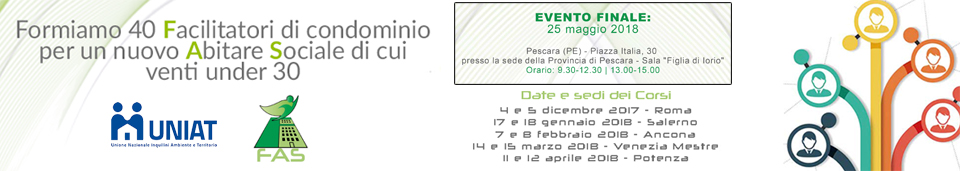
8 Responses to «Lo Svedese» di Ewan McGregor