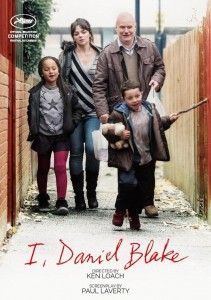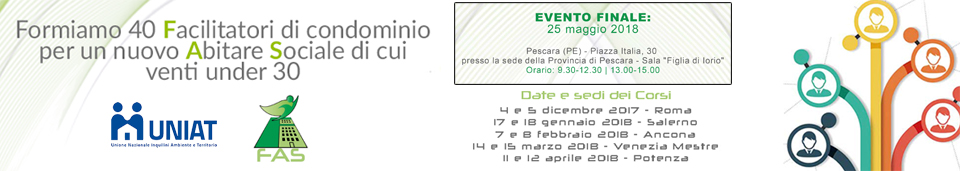Widgetized Section
Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone
Thank you, Mr. Loach
di Maria C. Fogliaro
Della caduta di uomini e donne sotto i colpi di un’impresa di dominio la cui ferocia appare ogni giorno più brutale; di una macchina burocratico-amministrativa deliberatamente pensata per esasperare e annichilire chi a essa fa ricorso; di una civiltà alla rovescia che trasforma i diritti sociali da valore in costo; di un sistema economico-politico che produce disoccupazione di massa, spietata concorrenza fra lavoratori, povertà generalizzata, regresso culturale e sociale, depressione psicologica, fame vera in una delle società più avanzate dell’Europa occidentale del XXI secolo: di questo, ovvero dell’irrazionalità della ragione (il neoliberismo) che da oltre trent’anni governa il mondo, tratta I, Daniel Blake (Gran Bretagna, Francia, Belgio, 2016, 100’), l’ultimo capolavoro di Ken Loach, premiato quest’anno al Festival di Cannes con la Palma d’Oro, e che ha ottenuto ben sette nominations ai BIFAs 2016 (British Independent Film Awards).
Con una sequenza che si può solo udire il regista e lo sceneggiatore, Paul Laverty, sdipanano fin da subito, e senza incertezze, i fatti. Mentre sullo schermo nero scorrono i titoli di testa, un uomo, il cui nome è Daniel Blake (Dave Johns), è impegnato in una telefonata dai toni surreali e grotteschi con una donna incaricata dal Department for Work & Pensions di valutare se egli possiede i requisiti per l’indennità di malattia che sta ricevendo. La sedicente «professionista della sanità», priva in realtà di qualsiasi preparazione medica, assegna alle risposte ottenute un punteggio, attenendosi al rigido protocollo previsto dalla legge. Poco tempo dopo, una lettera comunica a un Blake sgomento la perdita del sussidio.
A quasi sessant’anni Daniel, che ha fatto il carpentiere per tutta la vita, è stato colpito da un infarto che ha compromesso seriamente le sue condizioni di salute. Tornare al lavoro per lui è impossibile, almeno per il momento: il suo medico su questo punto è stato chiaro. Egli decide pertanto di impugnare quella che è, sotto tutti i punti di vista, una decisione arbitraria e irragionevole, e di presentare ricorso. Questa scelta catapulta di colpo l’operaio inglese all’interno dei rituali deliranti di una burocrazia kafkiana, fatta anche di interminabili, e spesso vane, attese al telefono alla ricerca di informazioni, che consentono alla regia di introdurre il mondo che Blake abita. Una realtà, alla periferia di Newcastle (nord-est dell’Inghilterra), dove alberga un’insicurezza sociale profonda e dove la convivenza non sempre è facile, mentre, tuttavia, sembrano ancora possibili rapporti umani schietti e non troppo interessati.
Dopo molte telefonate, Daniel comprende la paradossalità della propria situazione: pur essendo gravemente ammalato, per via della valutazione negativa non può ricevere l’indennità di malattia che gli spetterebbe, ma non può nemmeno fare ricorso, fino alla conclusione ufficiale del procedimento di «riconsiderazione obbligatoria». L’unica via che gli rimane, se non vuole morire di fame, è fare domanda per il sussidio di disoccupazione, che può sperare di ottenere soltanto se dimostra di cercare continuativamente lavoro per trentacinque ore la settimana. Inizia per l’uomo un peregrinare smarrito fra l’ufficio di collocamento, un corso inutile sulla compilazione dei curricula, e la ricerca quotidiana e faticosa di un lavoro che non potrà mai accettare, appunto perché ammalato. Il tutto mentre prova, senza successo, a compilare moduli che è obbligato a cercare su internet − lui che non ha mai acceso un computer in vita sua −, quando invece sarebbe stato semplice per qualsiasi impiegato stampare le copie a lui necessarie. Ma il regolamento vieta di aiutare «l’utente» − come, in una scena, viene ricordato a una gentile impiegata da una solerte capoufficio −.
Presto il destino di Blake incrocia quello di Katie, (Hayley Squires), da poco arrivata da Londra insieme ai due figli − Daisy (una bravissima Briana Shann) e il piccolo Dylan (Dylan McKiernan) −, la quale per un banale ritardo all’appuntamento fissatele dall’ufficio del lavoro rischia di perdere il sussidio, e con esso anche la direzione della propria vita. Daniel prende immediatamente a cuore la giovane famiglia, che aiuta come può − facendo, ad esempio, piccoli lavori di ristrutturazione nella casa popolare in cui i tre vivono, e prendendosi cura dei bambini mentre la madre è fuori a cercare lavoro −, diventando presto una presenza importante nella vita della giovane donna e dei suoi figli, l’unico vero affetto sul quale essi possono contare. E Katie, Daisy e Dylan non mancheranno, a loro volta, di sostenere Daniel nel momento del bisogno.
Come in altri suoi film-simbolo − su tutti Kes (1969) e Piovono pietre (1993) −, lo sguardo di Loach penetra nei fatti, illuminandoli dal di dentro. E costruisce un film intenso e potente, mai retorico o melodrammatico, nel quale i fatti, anche se duri, acquistano spesso una poetica bellezza (come quando la macchina da presa si sofferma sulla perizia con cui Blake usa le sgorbie per intagliare il legno). Un’immersione nella realtà, sostenuta dalla grande recitazione di Dave Johns (che proviene dalla tradizione del cabaret britannico) e di Hayley Squires. Come vediamo, ad esempio, nella sequenza lucida e spietata della food bank (la banca del cibo), dove la macchina da presa mostra Katie (in medio piano) che, provata da giorni di digiuno forzato, apre un barattolo di pelati e li mangia, per poi crollare sfinita e in lacrime per la vergogna e ci restituisce così la realtà di una società ridotta in macerie, polarizzata tra pochi ricchi e molti poveri, immiserita dalla disuguaglianza, piegata dalla sofferenza e da un’infelicità generalizzata, nella quale gli impulsi più elementari si scatenano.
La drastica discriminazione sociale che Loach e Laverty mostrano corre parallela alle umiliazioni che il sistema della previdenza infligge a chi da quell’organizzazione dovrebbe, invece, trarre beneficio. Lo sa bene China (Kema Sikazwe), il giovane vicino di casa di Daniel, quando avverte il suo vecchio amico dicendogli: «Te la faranno il più umiliante possibile. Non è un caso: è una strategia. Sai quanti ne conosco che hanno mollato e basta?». Lo afferma apertamente quell’uomo, probabilmente un disoccupato, che quasi alla fine del film − mentre Daniel inscena la sua protesta sul muro esterno del palazzo dell’ufficio di collocamento − inveisce contro quelli che il sistema lo hanno inventato, contro «i tories» e «gli stronzetti snob di Eton», mentre tutti gli altri − a cominciare dagli impiegati e dai burocrati − non sono che pedine irrilevanti.
Facendosi carico dello «scarto» escluso dal progetto neoliberista − attraverso l’ultimo appello di Daniel, che pretende il rispetto che si deve a ogni essere umano in quanto tale, e il riconoscimento del diritto di essere considerato sempre un cittadino (e non un cane, o un consumatore, o un parassita) −, Loach dà vita a un racconto senza idillio, che va al cuore delle nostre società, svelandone forma e sostanza. Viene da chiedersi se oggi in Italia sarebbe possibile − posto che qualcuno avesse voglia di farlo − dare vita a una denuncia analoga, lucida, potente, angosciante, graffiante, e soprattutto senza lieto fine − proprio come spesso è la realtà −. Sono queste le caratteristiche che fanno di I, Daniel Blake un film terribile e bellissimo, e assolutamente necessario a fronte dell’urgenza di rovesciare la narrazione imperante e creare una nuova egemonia che abbia come stella polare la giustizia sociale e il «diritto alla felicità» per tutti. Anche per questo, quindi, ancora una volta, thank you, Mr. Loach.