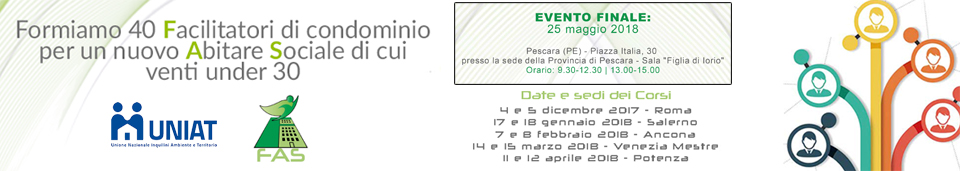Widgetized Section
Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone
Massimo Canella:”Ricchi/poveri, storia della diseguaglianza” di Pierluigi Ciocca
(in collaborazione con www.inchiestaonline.it )

*
Massimo Canella: Invito alla lettura 11. Pierluigi Ciocca: “Ricchi/poveri. Storia della diseguaglianza”. Giulio Einaudi editore, Torino, 2021.
“Negli ultimi due secoli l’economia di mercato capitalistica ha unito al formidabile sviluppo della produzione iniquità, instabilità e inquinamento. Questi tre connotati negativi – queste tre i – minacciano gli equilibri di fondo del sistema, le stesse basi democratiche” (Pierluigi Ciocca, “Ricchi e poveri. Teoria della diseguaglianza”, Torino 2021, p. 5). “Keynes pensava che in una economia di mercato capitalistica ‘una giustificazione sociale e psicologica possa darsi per diseguaglianze nei redditi e nei patrimoni anche significative, ma non per disparità ampie quali quelle odierne’. In realtà, l’obiettivo primo della redistribuzione degli averi è il concreto superamento della povertà estrema. Subito dopo è assolutamente necessario “potare” le punte della ricchezza smodata. Minore urgenza e maggiore cautela politica si richiedono nel correggere i livelli delle risorse a cui attinge la borghesia medio-piccola. Quando tutti i redditi, a cominciare dai più bassi, beneficiano della crescita dell’economia e i redditi altissimi vengono ridimensionati le tensioni sociali si attenuano, l’erba del vicino è meno verde e l’avversione nei confronti di chi ha di più è tenuta a freno” (ibidem, p. 163).
Con questa ulteriore pubblicazione, nella collana editoriale Einaudi Stile Libero, Pierluigi Ciocca, accreditato studioso a lungo vicedirettore di Bankitalia, divulga in forma chiara e sintetica, didatticamente attenta a non lasciare al lettore inesperto lacune sul senso dei termini e sulle basi di partenza dei ragionamenti, alcune conclusioni politicamente rilevanti dei suoi studi. Essi presuppongono sia la perfetta conoscenza dei modelli teorici che illustrano l’interazione fra le variabili economiche, sia quella delle istituzioni e del funzionamento effettivo dei mercati finanziari, come ci si può aspettare e comunque si auspica in una personalità col suo curriculum. L’attenzione dello studioso è volta prevalentemente ad avvicinarsi alla realtà effettuale cercando di far sintesi fra queste conoscenze e quelle derivanti dallo studio senza pregiudizi ideologici della storia delle dottrine economiche, della storia economica, della storia tout court e anche dell’antropologia, avvalendosi ampiamente dei risultati di indagini statistiche ed econometriche. Al nostro autore non manca la parresìa, la capacità di parlare francamente e di schierarsi. Nette le preferenze fra i maestri del pensiero economico. Sir John Maynard Keynes è citato in quattordici delle centosessantaquattro pagine del volumetto, ma il suo spirito sembra pervadere tutto il testo; Marx viene citato, senza adesione ma con attenzione, otto volte esplicitamente, e forse anche per allusione; restando fra i classici, Adam Smith otto volte e David Ricardo sei; tre citazioni non di dissenso anche per un marxista radicale come Paul M. Sweezy. D’altro canto, dei maestri del marginalismo Walras compare in una citazione in nota, in cui qualcuno asserisce che “le più grandi espansioni del commercio mondiale hanno avuto la tendenza a non provenire dal tatonnement incruento di alcuni banditori alla Walras, ma dalla mitragliatrice Maxim, dal filo di una scimitarra o dalla ferocia dei cavalieri nomadi” (p. 104 in nota). Di Marshall si riferisce un aneddoto sul suo interesse per i problemi della povertà; quanto a Milton Friedman, viene solo citato nella testimonianza di Richard Posner “ di essere stato per anni sconsigliato dallo studiare Keynes dai suoi colleghi economisti dell’università di Chicago, liberisti e premi Nobel come Milton Friedman” (p. 37 in nota). Nette, d’altro canto, le prese di distanza non solo dal socialismo reale (“il capitalismo è relativamente efficiente, certo più del socialismo quale è stato realizzato”, p. 154), ma anche da certe ipotesi di “socialismo partecipativo” da realizzare mediante ipertassazioni e l’indebolimento dell’istituto della proprietà, avanzate da Thomas Piketty, i cui studi peraltro Ciocca utilizza in modo importante: “ si può non amare il capitalismo, ma metterlo a rischio quando non ci sono alternative…” (p.152). I punti di riferimento ideali sembrano restare il riformismo e lo sviluppo ulteriore di un welfare del tipo di quelli realizzati in Europa soprattutto nel trentennio successivo alla seconda guerra mondiale. Un “progresso senza avventure”, avrebbe detto Fanfani, che in sé non comporta addolcimenti nella presa d’atto delle contraddizioni della realtà: si può essere benissimo radicali nelle diagnosi, che dovrebbero puntare solo alla veridicità, e realisti e disincantati negli obiettivi e nelle proposte.
D’altra parte Ciocca ha conservato la sua indipendenza spirituale restando pur sempre organico al mondo della finanza internazionale e contiguo al mondo del grande capitale, cui alcuni manager si avvicinano a volte nei redditi pur restandone in genere distanti nelle consistenze patrimoniali. Ed è chiaro, fra le motivazioni del suo riformismo, il suo interesse alla conservazione della stabilità: obiettivo di buon senso condiviso da ogni piccolo borghese economicamente e psicologicamente tranquillo, che presuppone la modica soddisfazione dei bisogni espressi da ogni gruppo sociale. Gli è chiaro quanto Piketty ha sostenuto e cercato di documentare, che se l’attenzione generale è attirata dagli imprenditori innovativi, molto spesso self made, che pur poco citati contribuiscono molto a fare la storia, la grande parte dei grandi patrimoni nel mondo è ereditata, e spesso è passata di generazione in generazione da prima dell’età industriale. Quando dedica, pertanto, un paragrafo ai “meriti dell’opulenza”, distingue i meriti imprenditoriali o professionali dei singoli, a volte notevoli, dai vantaggi potenzialmente realizzabili anche da una maggioranza che ha solo meriti patrimoniali, chiaramente su scala diversa in ragione della loro consistenza: un maggior contributo alla fiscalità generale a causa della progressività, una più elevata propensione a risparmiare il proprio reddito, la possibile filantropia, il possibile mecenatismo; la possibile considerazione solidale degli interessi di dipendenti fornitori e risparmiatori (avvertendo che “anche questi richiami possono essere meramente strumentali ad avvalorare le grandi fortune agli occhi dell’opinione pubblica”, p. 26). Un fastidio significativo viene invece dimostrato per i “costosissimi oggetti come la Ferrari di Scaglietti – smodato lusso o investimento speculativo?” (p. 23) Più convinta l’enumerazione dei modi in cui la ricchezza assicura anche potere: quello “enorme” su estese maestranze; il sostegno agli sport popolari, volano di varie forme di consenso; le attività di lobbismo; la pervasiva influenza esercitata tramite i media, con le note conseguenze sul piano della democrazia e della concorrenza; la disponibilità dei mezzi per scendere direttamente, all’occorrenza, nell’agone politico, per difendere i propri ideali e incidentalmente anche i propri interessi. Rilevante, forse più un tempo che nel mondo globalizzato, la possibilità di condizionare il territorio con le opportunità offerte dall’occupazione diretta e dall’indotto. Ciocca ricorda di aver chiesto a Gianni Agnelli, che passerà alla storia se non altro per le sue battute, se avrebbe barattato la Fiat con un titolo di stato che offrisse un rendimenti sicuro e più elevato. Gianni Agnelli rispose di no, “il proprio ruolo nella società italiana si legava non tanto al denaro, quanto all’essere ‘produttore di automobili in Torino’” (p. 27). Si tratta comunque di fattispecie in cui è il “denaro” che fa acquistare potere, che permette fra l’altro di accrescerlo; può avvenire anche il contrario – nel lontano passato, avveniva quasi sempre.
Per evidenziare questo rapporto variabile fra ricchezza e potere Ciocca traccia in una settantina di pagine una sorta di storia economica dell’umanità dalla preistoria ai giorni nostri, supportata da accessibili riferimenti di teoria. Da un primitivo stato in cui i cacciatori- raccoglitori erano tutti poveri si passa, attraverso gli stadi definiti in campo antropologico, a una società più complessa e alla nascita di vistose disuguaglianze. Sulla natura della trasformazione esistono due “archetipi”, uno di tipo funzionale e uno di tipo strutturale: nel primo lo Stato sorge a beneficio della comunità, che per produrre, riprodursi e difendersi ha bisogno di riconoscere delle gerarchie; nel secondo sono i gruppi che conquistano il potere che se ne servono a fini personali, opprimendo e sfruttando le proprie comunità e servendosene per saccheggiare o annientare quelle degli altri. (A prima vista le due interpretazioni sembrano compatibili, per allora come per oggi, ma la prima vista non può fare dottrina.) In ambedue le interpretazioni è lo Stato che compie opera di redistribuzione della maggiore ricchezza a favore delle aristocrazie, dei militari, dei burocrati e del clero: “se fra i cacciatori e raccoglitori la ripartizione delle risorse era livellata, attraverso la Rivoluzione neolitica lo scarto negli averi, la diade fra i pochi abbienti e i tanti meno abbienti, diventava secca e bipolare. Il limite al prelievo, alla “estrazione”, delle risorse da parte dei ricchi attraverso l’esercizio del potere era dato solo dalla irriducibilità delle risorse dei poveri al di sotto dei livelli di sussistenza” (p. 47-48). A Roma “gli arricchimenti scaturivano dall’esercizio del potere militare, politico e amministrativo. Il potere consentiva lo sfruttamento dei meno abbienti sottraendo loro ampia parte delle risorse eccedenti il minimo vitale. Le attività lucrose andavano dal bottino di guerra all’esazione di tributi, agli appalti, ai commerci, ai prestiti usurari, alla pratica della corruzione. La base solida della ricchezza – tutelata dal fondamentale diritto di proprietà sulla terra – restavano i “latifundia” nella penisola e nelle province, principalmente lavorati da schiavi” (p. 60). Nel Tardoantico “la sperequazione distributiva si ridusse drasticamente e drammaticamente, compressa da eventi epocali. Il surplus di risorse di cui la popolazione disponeva rispetto ai minimi vitali scemò fin quasi ad annullarsi. Si restrinsero così le possibilità e i margini di estrarlo da parte della classe dirigente” (p. 61), senza che molti potessero apprezzare i vantaggi di una maggiore equità così ottenuta. La situazione naturalmente si aggravò nella seconda metà del primo millennio dell’era cristiana, che ha conosciuto momenti di grande disorganizzazione. In generale, data l’irriducibilità dei bisogni di sostentamento dei produttori, la minore prosperità si traduce in una malinconica riduzione della sperequazione sociale.
Uno dei fili conduttori dell’esposizione consiste nell’esame delle variazioni del coefficiente di Gini, usato come indice di concentrazione per misurare la diseguaglianza nella distribuzione del reddito o della ricchezza. Esso è dato “a metà della differenza media in valore assoluto di reddito o patrimonio tra coppie d’individui scelti a caso, rapportata al reddito medio della popolazione” (p. 57 n.): valori bassi del coefficiente indicano una distribuzione abbastanza omogenea, con il valore 0 che corrisponde alla pura equidistribuzione e il valore 1 che corrisponde alla situazione teorica in cui una sola persona percepisce tutto il reddito del paese. La convergenza di tante competenze può dare fiducia nella delicata valutazione che viene effettuata della significatività dei dati disponibili relativi al passato, cui applicare tale procedimento matematico. Dalle elaborazioni disponibili risulta che il coefficiente p es nel passaggio dell’Inghilterra dall’Impero all’era post-romana sia sceso effettivamente dallo 0,6 allo 0,4. Risalito con la rivoluzione economica del basso Medio evo (0,7 a Londra e Parigi a cavallo del 1300), subì poi gli effetti della fase delle grandi pesti, che diede paradossalmente potere di mercato ai lavoratori sopravvissuti. Nelle fastose città del Rinascimento italiano si era risaliti allo 0,7 – 0,8. Nei tre secoli successivi la popolazione europea si è triplicata e il prodotto pro capite è stagnato, a seguito di una dinamica demografica simile a quella teorizzata da Malthus: molto stimolanti le discussioni in merito ricordate nel capitolo “Lavoro senza crescita”. E’ lecito quindi supporre che in condizioni di stagnazione i miglioramenti dello stato delle classi abbienti avvenga a discapito dei subalterni, malgrado i crescenti spazi occupati in quei secoli dal mercato; a ciò correlati nei secoli in questione repressione e irregimentamento della diffusissima miseria. Un intervento organico per il sostegno della povertà assoluta si ha nell’Inghilterra elisabettiana con i provvedimenti culminati poi con la Poor Law del 1601, rimasti isolati in Europa per duecento anni: con una attenzione che mi sembra avere un’eco nel Re Lear di Shakespeare. Dal 1800, con il passaggio dalla “produzione mercantile pre-capitalistica” (Sweezy) all’economia di mercato capitalistica, si avvia il processo a macchia d’olio di quel che Ciocca chiama il passaggio “dal potere al profitto”, tutt’altro che lineare peraltro: cioè al mondo in cui siamo abituati a vivere.
Va premesso per amore di verità che il libero mercato dipende comunque molto più di quanto si propaganda dal rapporto con le istituzioni pubbliche, in quanto p es, ma si potrebbe dire molto di più, “collide con l’evidenza storica l’idea che l’affermazione del commercio internazionale nell’ultimo millennio sia meramente dovuta alle forze del mercato […] Traffici e potere si sono troppo spesso saldati nel generare attraverso gli scambi l’arricchimento delle nazioni politicamente e militarmente più forti e più propense a usare la forza a scapito delle altre” (p. 104 n.) Ciò premesso, va sottolineato il forte ruolo delle istituzioni pubbliche anche nel procedere a una redistribuzione e perequazione dei redditi in varie fasi della storia contemporanea, a correzione delle tendenze spontanee di un mercato immaginato talvolta libero da una loro presenza che non fosse di servizio. Questo ruolo è stato esercitato molto debolmente nel corso dell’Ottocento: “La spinta alla concentrazione impressa dal meccanismo del profitto capitalistico […] ha per più di un secolo prevalso sulla controspinta esercitata dalla dinamica complessiva dei salari, dall’organizzarsi del movimenti dei lavoratori, dal configurarsi della progressività della tassazione, dai nascenti sistemi di assistenza e previdenza sociale” (p. 111). (Interessante la notizia che nell’Italietta del 1864, ministero Minghetti di Destra storica, la legge sull’imposta sulla ricchezza mobile contenesse elementi di progressività rimasti per vari anni all’avanguardia.) Una forte influenza hanno avuto invece i flussi migratori in partenza e in arrivo. Dal 1914 al 1947 il periodo di forti perturbazioni ha coinciso con una netta discesa della concentrazione di redditi e patrimoni, con perdite patrimoniali per scelte politiche, soprattutto di guerra, e bassi rendimenti superiori a quelle delle devastazioni fisiche (che in genere non si accanivano sui beni strumentali). Sono seguiti i trenta anni migliori per le classi lavoratrici che mai si siano vissuti, con un progresso costante e una capacità contrattuale delle diverse forze sociali che ha consentito una generale riduzione del coefficiente di Gini mediante l’incremento del monte salari, delle provvidenze sociali, del risparmio dei ceti medi e bassi. E’ poi cominciata, ma è storia ancora attuale, “la rivincita del mercato”, per vari fattori di cui molto si parla e che non staremo a ripetere. Un faro forse merita “una tecnologia informatica – ICT, big data, robotica, smart working – che, pur non accrescendo la produttività totale dei fattori nemmeno nei Paesi dove quella tecnologia maggiormente si diffondeva, premiava sia il lavoro specializzato, domandato in misura eccedente l’offerta, sia l’investimento in capitale umano che lo esprime” (p. 114). Su scala mondiale l’indice di Gini dei patrimoni dal 2008 al 2019 è salito da 0,80 a 0,89, livelli di sperequazione inediti nella storia. Quello dei redditi è naturalmente più alto nei paesi meno sviluppati, con punte sopra lo 0,60 in Sudafrica, si aggira attorno allo 0,40 negli Stati Uniti e un po’ sopra lo 0,30 nella civile Europa (0,33 in Italia, sotto lo 0,30 nei paesi nordici).
Degli altri punti va almeno citato il raffronto fra le giustificazioni dell’equità e della diseguaglianza. L’equità: politicamente, non esistendo nel tempo presente alternative reali al sistema capitalistico, le eccessive diseguaglianze ne minano la coesione sociale e le prospettive di buon funzionamento; eticamente, è tanto abituale quanto indigeribile sapere che un norvegese per diritto di nascita. ha un reddito cento volte superiore a un nigeriano, un dirigente di azienda newyorkese gode di uno stipendio trecento volte superiore a quello di un normale impiegato e nei paesi più ricchi esistono milioni di persone in condizioni di povertà assoluta; economicamente, le diseguaglianze impediscono alle persone svantaggiate di sviluppare e esprimere le proprie capacità, anche al servizio degli altri. Le ragioni della diseguaglianza: 1) l’incentivo per i dirigenti a fare il bene dell’azienda (ma non può essere meritocratico l’aumento in pochi anni, in America, del rapporto fra retribuzione dell’amministratore delegato e salario da 20:1 a 354:1); 2) la creazione delle condizioni del risparmio in vista dell’accumulazione di capitale (sì, ma Keynes come è noto osservava che l’accumulazione dal lato della domanda è frenata se la propensione ad accumulare è bassa, e poi lo sviluppo tecnico incide ormai più dell’investimento, la finanza facilita gli investimenti esteri e nelle migliorate condizioni economiche esiste un notevolissimo risparmio generato dai ceti medi e bassi); 3) la convinzione che le retribuzioni riflettano la domanda del servizio recato alla produzione, legato a sua volta alla produttività marginale di chi offre il servizio. Il parere in merito di Pierluigi Ciocca su quest’ultimo punto è il seguente: “Sebbene tuttora prevalente fra gli economisti tanto da essere definito mainstream, se non ortodosso, il marginalismo “neoclassico” fondato sull’individualismo metodologico e sull’uomo economico razionalmente egoista è stato sin dall’origine ottocentesca molto dibattuto. […] Specialmente deboli, davvero lontani dalla realtà, sono gli assunti di concorrenza nei mercati e di razionalità dei soggetti economici. Quindi non sorprende che la teoria marginalistica stenti a dare ragione, da sola, delle differenze osservate nella distribuzione personale dei redditi” (p.123). Segue un
a discussione sul rapporto fra crescita e diseguaglianze, inclinando l’autore a ritenere che le diseguaglianze possano frenare la crescita e una maggiore equità favorirla.
Il profano può decidere quale interpretazione dei fatti economici gli sembri più verosimile e quale gli sia più simpatica, ma non ha gli strumenti per addentrarsi nelle dispute degli scienziati. Può comunque capire benissimo perché a quanto si dice Carlo Azeglio Ciampi, in procinto di lasciare Bankitalia, sostenesse che professionalmente Pierluigi Ciocca sarebbe stato il suo successore più adeguato, ma Silvio Berlusconi non ne avrebbe mai firmato la nomina.