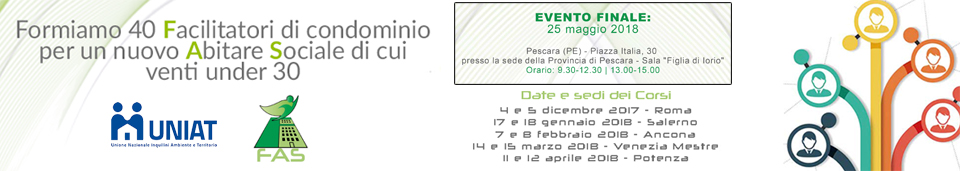Widgetized Section
Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone
Come si pensa la Cina? La dimensione storica contro i comparatismi astratti
Amina Crisma esamina schemi e pregiudizi eurocentrici tuttora predominanti nelle rappresentazioni della Cina, e indica una prospettiva storica e critica da inscrivere nel dibattito pubblico e nella cultura condivisa (Inchiesta n. 185, luglio/settembre 2014, pp. 36-41)
- Un curioso paradosso.
E’ un curioso paradosso, quello che si può oggi constatare a proposito delle comuni percezioni della Cina al di fuori dell’ambito degli studi specialistici. Se da una parte essa sembra essersi avvicinata negli scenari della globalizzazione, e suscita curiosità e interessi crescenti da parte di un vasto pubblico, dall’altra appare per molti versi rimasta un’area vaga, indeterminata e remota: la figura per eccellenza di un’Alterità che si ama soprattutto configurare in chiave di esotica stranezza, e che si descrive prevalentemente attraverso schemi precostituiti. [1] Sovente si rinvia a una presunta “Essenza Profonda della Sinità”, che spiegherebbe ogni cosa, e a cui si attribuisce lo statuto autoevidente di un dogma indiscutibile, non bisognoso di essere in alcun modo dimostrato. Questo genere di discorsi finisce per mettere inevitabilmente in scena un teatrino alquanto scontato, fondato su un modello di opposizione dualistica che mobilita, in solenni evocazioni, le Grandi Entità sub specie aeternitatis – Occidente/Oriente, Grecia/Cina, Filosofia/Saggezza…insomma, le Civiltà e le Culture, la loro Perennità e i loro metafisici e metastorici Destini.[2]
Questi grandiosi scenari sono indubbiamente suggestivi, ma è alquanto dubbio che tali astratte e magniloquenti generalizzazioni possano apportare contributi davvero significativi alla nostra conoscenza e alla nostra comprensione del mondo. E’ quanto rileva, ad esempio, nella sua Lezione inaugurale della Cattedra di Storia intellettuale della Cina al Collège de France Anne Cheng, nota in Italia soprattutto come autrice della Storia del pensiero cinese:[3]
Attualmente è considerato di bon ton riempirsi la bocca di “dialogo fra le culture”, senza dubbio con l’intento di contrastare i discorsi bellicosi sullo “scontro di civiltà” evocato dal noto e controverso libro di Samuel Huntington.[4] Ma in fatto di dialogo, si assiste talora a un dialogo fra sordi, come nota il ricercatore cinese in scienze sociali Zheng Jiadong: “Per molto tempo – egli osserva – l’idea per cui solo i pensatori dell’antichità pre-imperiale cinese potevano essere qualificati come filosofi è prevalsa fra i sinologi occidentali (e i mutamenti di mentalità in proposito sono solo recenti). Tali pensatori erano allora accostati ai saggi della Grecia antica. Quest’attrazione dei sinologi occidentali per il pensiero cinese antico contrastava fortemente con la seduzione esercitata sugli intellettuali cinesi dalla filosofia occidentale moderna. Mentre la Cina si innamorava di un Occidente post-illuministico, l’Occidente vagheggiava una Cina antica, non ancora entrata nell’età medievale, separata dall’evoluzione moderna e dai suoi problemi.”[5]
Ciò che qui viene messo in causa è un tipo di comparatismo tuttora molto in voga, che fra l’altro si è imposto come tema di ricerca prioritario a livello accademico, e che è indubbiamente benintenzionato nel suo proposito di uscire dall’eurocentrismo. Ma esso continua di fatto a inscriversi in una prospettiva di tipo “orientalistico”, nella misura in cui tende a “museificare” il pensiero cinese e a ridurlo al ruolo dell’”Altro” come termine di paragone per affidargli la risposta a domande che non gli appartengono. Si ha qui un’insistenza sul registro dell’alterità che irrigidisce le opposizioni al di fuori del tempo e dello spazio, e che non permette di riconoscere la pluralità e la diversità delle differenze là dove realmente si trovano. Ne consegue il rischio di cadere in una qualche forma di essenzialismo e di finire per suffragare, anche involontariamente, delle idee preconcette già fin troppo diffuse.[6]
Le pacate considerazioni di Anne Cheng, studiosa che ha il privilegio di essere partecipe di una duplice cultura, cinese ed europea, mi sembra meritino attenzione anche al di fuori delle prestigiose sedi accademiche in cui sono state enunciate. Esse propongono una riflessione non scontata su problemi che non riguardano unicamente un settoriale ambito disciplinare, e neppure soltanto le specifiche e controverse questioni inerenti allo statuto della comparazione, che in anni recenti è stata fra l’altro addirittura dichiarata, provocatoriamente, defunta,[7] ma chiamano in causa la capacità stessa della nostra cultura nel suo insieme di riferirsi autenticamente, e non solo sul piano di conclamate buone intenzioni dialogiche, a un diverso orizzonte di linguaggio e di pensiero.
Siamo davvero capaci di accostarci alle espressioni di una diversa cultura, e di metterci al loro ascolto, o preferiamo soverchiarle con il fragore di retoriche dichiarazioni d’intenti interculturali?
Uso deliberatamente il plurale – “le espressioni di una cultura”, e non “la cultura” – perché non è, mi pare, con un’entità astratta e generica quale la Cultura Cinese che noi ci rapportiamo, ma con delle individualità concrete e circostanziate: sono singole persone, singoli testi, singole parole, che non sono atomi isolati, ma punti di convergenza di insiemi di relazioni. E’ attraverso di loro che entriamo in rapporto con i vasti ambiti di cui essi sono tramiti – una lingua, una tradizione… – e il compito arduo e paziente di chi li traduce e li interpreta non è quello di ridurli all’univocità e all’uniformità di un paradigma già noto e scontato in partenza, di irreggimentarli dentro una collettività totalizzante, ma tentare di coglierne le peculiari, diverse, creative riformulazioni di quanto li accomuna. I loro stili caratteristici, di linguaggio e di pensiero, si giocano precisamente in questa dialettica fra langue e parole. La mia ricerca non si indirizza né sul versante dell’uniformità astratta né su quello, altrettanto astratto, di un atomismo irrelato, ma su quello del rapporto fra uno sfondo comune e condiviso – una lingua, una tradizione, una tendenza di pensiero – e un’irriducibile pluralità:[8] quella pluralità che è “legge della Terra”, come ben ci rammentava Hannah Arendt.[9]
Se davvero ci interessa tentare di instaurare un rapporto con le voci che ci giungono dalla Cina, e non limitarci a sovrapporvi i nostri pregiudizi, i nostri preconcetti, tutto l’armamentario greve del nostro prêt-à-penser, quali possono essere le modalità più adeguate per conseguire tale risultato?
Sono queste le domande che propongo all’attenzione del lettore. Su questo tema si sono avuti negli anni recenti, soprattutto in Francia ma non solo, dibattiti alquanto vivaci di cui in Italia sono giunte, in sostanza, solamente echi deformate e parziali, se si eccettuano alcuni seminari di filosofia interculturale[10] e i convegni dell’Associazione Italiana Studi Cinesi, ai cui atti rinvio chi fosse interessato a conoscerli nei dettagli.[11]
Quello che qui mi importa non è ripercorrere discussioni di cui si sono già più volte offerti circostanziati resoconti, ma la questione cruciale che esse pongono, e che Paul Ricoeur, ad esempio, formulava con grande nettezza già diversi anni fa: la cultura dell’Occidente è davvero capace di rendere giustizia alle grandi esperienze della Cina?[12]
- La Cina perenne: fascino di un’immagine persistente.
Da sempre la Cina ha suscitato in Occidente una fertile attività mitopoietica che volta a volta l’ha celebrata o demonizzata, e che negli scenari d’oggi conosce fasti rinnovati. E’ un atteggiamento che si può sinteticamente evocare nei suoi tratti essenziali ricorrendo, ancora una volta, alle parole di Anne Cheng, stavolta tratte dalla sua Storia del pensiero cinese:
Che cosa percepiamo oggi della Cina? Un confuso frastuono, in cui si mescolano informazioni mirabolanti sulla sua economia, notizie allarmanti sulla sua politica, e interpretazioni più o meno fondate sulla sua cultura. La Cina è quella grande porzione di umanità e di civiltà che resta ancora essenzialmente sconosciuta al mondo occidentale, senza aver cessato di suscitarne la curiosità, i sogni, gli appetiti – dai missionari cristiani del XVII secolo agli uomini d’affari di oggi, passando per i filosofi dei Lumi e gli zelatori del maoismo.[13]
Non è il caso di soffermarsi qui nei dettagli sui miti e gli stereotipi che si sono via via proiettati sulla Cina, materia su cui sussiste un’ampia letteratura, dai fondamentali lavori di Heiner Roetz[14] alle ricerche di Lionel Jensen,[15] e al cui proposito rinvio, ad esempio, al bel volume di Stefano Cammelli, Ombre cinesi (2006), che ne offre sinteticamente un vasto repertorio, dal Seicento fino ai giorni nostri.[16] Mi interessa qui in particolare sottolineare un aspetto cruciale che sovente è dato riscontrare nelle immagini stereotipate della Cina: l’idea di una sua plurimillenaria immobilità e di una sua perpetua univocità. Un’idea che ha avuto una molteplice genealogia e che si è codificata in una sorta di paradigma interpretativo, di consensus view a cui hanno concorso – e concorrono tuttora – tanti autorevoli protagonisti,[17] ma la cui matrice fondamentale si può riconoscere essenzialmente nelle hegeliane Lezioni sulla filosofia della storia, la cui icastica e memorabile rappresentazione della Cina come “immobile Uno, quanto v’è di più estraneo all’Europa”, da allora sembra essersi prepotentemente impressa nell’immaginario collettivo.[18]
“E’ difficile uscire da Hegel”, ha significativamente dichiarato una volta François Jullien, e non si può davvero dargli torto in proposito.[19] Come osserva Anne Cheng in un saggio significativamente intitolato Pour en finir avec le mythe de l’alterité (2007), quell’immagine risulta tuttora così seducente nonostante ogni smentita perché gratifica il narcisismo occidentale sul piano di quello che Edward Slingerland definisce un “orientalismo rovesciato”,[20] ossia l’attribuzione di valore positivo a uno stereotipo che inizialmente aveva una connotazione accentuatamente denigratoria, senza peraltro modificarne la natura essenziale. Se la Cina appariva a Hegel il torpido e inerte contraltare orientale al dinamico Occidente, oggi quella medesima immagine stereotipata offre a un Occidente stanco un confortevole divano esotico su cui riposare. [21]
E’ la Cina perenne, insomma, la rappresentazione che continuamente si riaffaccia in questo gioco di specchi, in declinazioni diverse, orientate talora alla celebrazione talaltra alla denigrazione, ma la cui sostanza permane identica e immutata; che si tratti del Dispotismo Orientale da deprecare o della Perenne Armonia da esaltare, è in ogni caso in questione la “Cina sempre eguale” alla quale si negano le dimensioni della pluralità, dei conflitti, delle disarmonie, dei mutamenti e delle trasformazioni: alla quale, in una parola, si nega la dimensione costitutiva della storia. [22]
Non credo occorrano molte argomentazioni per mostrare la totale infondatezza di questo assunto, che già molti anni fa Etienne Balasz in un suo libro famoso, La burocrazia celeste (1968), definiva senza mezzi termini “uno sciocco cliché di cattivo gusto”,[23] e di cui Jack Goody ne Il furto della storia (2006) denuncia vigorosamente l’arroganza eurocentrica.[24] Gli sviluppi delle ricerche degli ultimi decenni ne hanno offerto abbondanti e puntuali smentite, rivelando quanto siano dinamiche e multiformi, complesse e articolate le vicende remote e recenti del Paese di Mezzo, e quanto siano segnate da drammatiche cesure e profonde lacerazioni.[25] Chiunque voglia farsene un’idea può ricorrere, ad esempio, all’opera collettanea di un team internazionale di studiosi che si intitola Cina (2009-2013) diretta da Maurizio Scarpari, polifonico affresco dell’economia, della società, della politica, della cultura cinesi dalla preistoria ai giorni nostri ispirato al modello della Cambridge History of China.[26]
Fra i tanti esempi che si potrebbero in questo senso addurre, mi limito a richiamare una confutazione di speciale pregnanza del dogma dell’unità e della continuità della storia cinese attinta al volume di Kai Vogelsang, Cina, una storia millenaria di cui appare ora l’edizione italiana.[27] Vi si evocano cinque scene emblematiche, assunte a simboleggiare altrettante fasi irriducibilmente diverse: nella prima si rappresenta una divinazione dell’epoca della dinastia Shang (1200 a.C.), accompagnata da un sacrificio cruento, nella seconda (510 a.C.) si evoca l’umanesimo confuciano con il suo culto per la letteratura e per le antiche norme rituali, nella terza (873 d.C.) si raffigura il fervore entusiastico di una processione buddhista al tempo della dinastia Tang, nella quarta (1852) si evocano gli esami imperiali per il reclutamento dei funzionari sotto la dinastia Qing, nella quinta (1966) vi è una manifestazione di massa della Rivoluzione Culturale in piazza Tian Anmen. Come l’autore sottolinea, ognuna di queste scene segnala una radicale discontinuità:
Più volte, nel corso della loro storia, i cinesi sono stati estranei a se stessi. Confucio non conosceva più i riti degli Shang, e se vi avesse assistito ne avrebbe avuto orrore. Interi mondi, poi, separavano i cinesi del IX secolo dalla civiltà di Confucio: i saggi del mondo antico erano caduti nell’oblio, e perfino la loro lingua era divenuta incomprensibile. A loro volta, gli eruditi libreschi della tarda età imperiale avrebbero senz’altro condannato la sregolata baraonda della processione buddista: essi cercavano la salvezza negli “esami confuciani”, esami che però Confucio stesso non sarebbe mai stato in grado di superare. Infine, alcuni intellettuali del XX secolo trascinano al macello tutta quanta la vecchia società, e le Guardie Rosse si mettono in marcia per estirpare definitivamente tutte le antiche consuetudini.[28]
Nondimeno, la Cina stessa ha amato sovente offrire di sé una narrazione monolitica e compatta, sulla quale oggi in particolare enfaticamente insiste la sua classe dirigente, e sulle cui ambivalenze e contraddizioni ha, fra l’altro, di recente proposto una riflessione a più voci il dossier “Passato e presente nella Cina d’oggi” di Inchiesta (n. 181, dicembre 2013; www.inchiestaonline.it). Significativamente, come ci mostra Marina Miranda ne La Cina dopo il 2012, oggi più che mai nella RPC gli orientamenti storiografici prevalenti sono volti alla costruzione di un’identità nazionale più vasta dello Stato socialista, e tale da includere tutta l’area sinica, superando la separazione fra le due Cine, RPC e Taiwan, che si è consumata nel secolo scorso: in questa chiave hanno avuto luogo le solenni commemorazioni della rivoluzione del 1911.[29] Ma se da un lato si celebra e si rivaluta del passato tutto ciò che è funzionale al progetto di una Greater China, dall’altra è tuttora vigente quella che Simon Leys chiama “la grande amnesia”: la censura su tutti i capitoli tragici della storia recente, dalle purghe degli anni Cinquanta alla Rivoluzione Culturale al massacro di Tian Anmen:
Questi quarant’anni di tragedie storiche – dal 1949 al 1989 – sono stati inghiottiti in un “buco di memoria” orwelliano: i cinesi che oggi hanno vent’anni non dispongono di alcun accesso a tali informazioni, ed è più facile per loro scoprire la storia dell’Europa o dell’America di quella del loro Paese.[30]
- Ineludibilità del confronto con la dimensione storica.
Con queste considerazioni, per quanto brevi, spero di aver sufficientemente motivato l’ineludibilità del confronto con la dimensione della storia per chiunque voglia tentare di conoscere e di comprendere il mondo cinese – o meglio: i molteplici mondi cinesi. Non si tratta di un accessorio superfluo, come in tanti sembrano ritenere. Fra gli innumerevoli esempi di quest’atteggiamento che potrei in proposito citare, mi limito a un episodio: qualche tempo fa, in uno studio Rai dove si svolgeva un dibattito sulla condizione femminile in Cina a cui ero stata invitata, mi sono sentita rivolgere un cortese ma fermo avvertimento preliminare: “Soprattutto le raccomandiamo: niente nomi, niente date…”.
Confrontarsi con la storia non è la bizzarra esigenza di stolidi e stravaganti eruditi, dediti a rovistare in mezzo ad ammuffiti reperti alla ricerca di minuti e irrilevanti dettagli. E’ confrontarsi con la corposa complessità, irriducibile a esangui e disincarnate astrazioni, delle vicissitudini degli esseri umani nel tianxia, sotto il cielo.[31] E’ confrontarsi con la molteplicità e la pluralità di soggetti diversi, in ruoli diversi, con diverse e molteplici costruzioni, distruzioni, narrazioni. E’ confrontarsi con memorie e rimozioni, e tanto altro ancora.[32]
Ma soprattutto, confrontarsi con la storia significa non eludere il nodo denso del confronto con la violenza che, in varie modalità, la attraversa da cima a fondo.[33] Ce lo rammenta un celebre detto di uno dei più grandi scrittori del Novecento, Lu Xun, che nel 1925 scriveva: “La nostra storia tanto celebrata non è che un susseguirsi di banchetti di carne umana”.[34] Oggi in Cina non sono pochi a storcere il naso di fronte a espressioni di questo tipo, ritenendole frutto di un “estremismo radicale” reputato obsoleto, e a prenderne le distanze in nome di una conclamata volontà di conciliazione fra modernità e tradizione che oggi appare una tendenza diffusa, ancorché non priva di ambiguità.[35] Certo, quella di Lu Xun è un’estremizzazione deliberata, dal dichiarato intento provocatorio, polemicamente volta contro le monocordi celebrazioni di fasti sempiterni: essa contiene comunque un’esortazione, che penso convenga tenere tuttora in debito conto, a non distogliere lo sguardo da tutto ciò che non corrisponde alle rappresentazioni oleografiche delle “magnifiche sorti e progressive” della Grande Armonia.
Si è avuta forse un po’ troppa fretta, in un recente passato, di dichiarare definitivamente tramontate le grandi narrazioni; in questa fase, mi sembra, c’è una grande partita che si gioca precisamente sul terreno della storiografia, nella Cina post-maoista: essa non ha più come fulcro il tema della rivoluzione, come è avvenuto fino alla morte del Grande Timoniere, ma ha al suo centro il rafforzamento e la celebrazione della zhonghuaxing, ossia della sinità.[36] La ricostruzione attuale del passato appare in larga misura orientata alla definizione e alla rielaborazione dell’identità nazionale, le cui peculiarità sono peraltro argomento quanto mai controverso,[37] e di cui si riformulano i miti fondativi, in un atteggiamento che ben si presta ad esser letto nella chiave interpretativa a suo tempo suggerita da Benedict Anderson in Imagined Communities (1991).[38]
Tale grandiosa narrazione equivale a tutt’altro che a un esercizio antiquario, all’esplorazione di cimiteri o al disseppellimento di fossili inerti e inanimati: è un agire a cui inerisce un’energica carica progettuale e politica, che riscrive, reinterpreta e rianima il passato secondo un disegno volto al presente e al futuro di una grande potenza.[39] Il comparatismo astratto, che a quanto pare si occupa soltanto dell’iperuranio ed è totalmente disinteressato a quanto avviene nel mondo sublunare, rifiutando di misurarsi con tale spessa dimensione inconsciamente o meno svolge l’implicita apologia di un disegno imperiale.
Di tale progettualità politica occorre essere consapevoli per poter far spazio a narrazioni plurali, che non coincidano con una forzata e dogmatica reductio ad unum. E in questo senso, credo sia importante riattingere oggi alle fonti di quelle che sono state in Cina le fertili stagioni di liberi dibattiti, di un passato recente – come quel primo Novecento, in cui erano presenti le idee più varie e diverse,[40] e c’era ad esempio un grande scrittore, Ba Jin, che nel proprio nome d’arte si richiamava a Bakunin e Kropotkin, e John Dewey veniva celebrato dai giovani innovatori come grande maestro, come “nuovo Confucio”, e Sun Yat-Sen leggeva Mazzini…[41] – o di un passato remoto, come quell’epoca degli Stati Combattenti in cui apertamente contendevano i fautori di diverse ricette di governo – i disputers of the Tao, come li chiama Angus C. Graham nello splendido libro che vi ha dedicato[42] – e dalle loro dispute emergeva un problema antico e sempre attuale ad ogni latitudine nel tianxia, sotto il cielo: che cos’è che legittima l’esercizio del potere sovrano?[43]
[1] Per un esame critico di questo tipo di rappresentazioni, cfr. Giacomo Marramao, Passaggio a Occidente. Filosofia e globalizzazione, Bollati Boringhieri, Torino 2003; Amina Crisma, Conflitto e armonia nel pensiero cinese dell’età classica, Padova, Unipress 2004.
[2] Amina Crisma, “Pensare la Cina in un orizzonte interculturale: prossimità e distanza di un Altrove”, in Giangiorgio Pasqualotto (a cura di), Per una filosofia interculturale, Mimesis, Milano 2008, pp. 179-212; Ead., “L’indifferenza alla felicità nel pensiero della Cina antica. Dialogo con François Jullien,” Cosmopolis, 2, 2006, pp. 87-97 ( www.cosmopolisonline.it ).
[3] Anne Cheng, Storia del pensiero cinese, tr. e cura di Amina Crisma, Einaudi, Torino 2000.
[4] Samuel Huntington, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, Garzanti, Milano 1997.
[5] Zheng Jiadong, « De l’écriture d’une histoire de la philosophie chinoise », Extrême Orient- Extrême Occident,n. 27, 2007, p. 129.
[6] Anne Cheng, La Chine pense-t-elle? Collège de France/Fayard, Paris 2009, pp. 35-37 (traduzione di Amina Crisma).
[7] Cfr. Giovanna Lelli, “Comparatismi”, Parol-online 2000; Gayatri Chakravorty Spivak, Morte di una disciplina, Meltemi, Milano 2003.
[8] Il metodo di ricerca di cui cerco qui di descrivere gli orientamenti essenziali si è definito e concretizzato nelle mie ormai più che ventennali frequentazioni delle fonti cinesi classiche e delle loro reinterpretazioni contemporanee: cfr. Amina Crisma, “Il Trattato sul Cielo di Xunzi”, in Massimo Ferrante, Paolo Frasson (a cura di), Forme di fedeltà, Panda, Padova 1996, pp. 147-163; Amina Crisma, Il Cielo, gli uomini. Percorso attraverso i testi confuciani dell’età classica, Cafoscarina, Venezia 2000; Ead., Conflitto e armonia, cit.
[9] Hannah Arendt, La vita della mente, Il Mulino, Bologna 1978. I
[10] Tali incontri sono stati promossi al Dipartimento di Filosofia dell’Università di Padova da Giangiorgio Pasqualotto e Marcello Ghilardi, che colgo qui l’occasione per ringraziare per tutte le preziose occasioni di confronto interdisciplinare da loro realizzate (cfr. Amina Crisma, “Dao, ossia cammino. Note in margine al percorso di riflessione di Giangiorgio Pasqualotto”, in Marcello Ghilardi, Emanuela Magno (a cura di), Sentieri di mezzo tra Occidente e Oriente, Mimesis, Milano 2006, pp. 15-32.
[11] Poiché qui mi interessa unicamente mettere in luce quella che mi pare la sostanza di tale discussione, mi astengo deliberatamente dal rievocarne gli svolgimenti, che ho già più volte rappresentato con dovizia di particolari: cfr. Amina Crisma, “Per una reconnaissance de l’autre: prospettive ermeneutiche su pensiero della Cina antica nel dibattito filosofico contemporaneo”, in Guido Samarani, Laura De Giorgi (a cura di), Percorsi della civiltà cinese, Cafoscarina, Venezia 2007, pp. 181-200; Ead., “E’ possibile pensare la relazione con il pensiero cinese al di fuori della dicotomia Oriente/Occidente?”, in Paolo De Troia (a cura di), La Cina e il mondo, Nuova Cultura, Roma 2010, pp. 396-410.
[12] Paul Ricoeur, Finitudine e colpa, Il Mulino, Bologna 1970, pp. 26-29.
[13] Cheng, Storia, cit., p. 5.
[14] Heiner Roetz, Mensch und Natur im Alten China, Peter Lang, Frankfurt am Main 1984; Id., Confucian Ethics of the Axial Age, SUNY, Albany 1993.
[15] Lionel Jensen, Manufacturing Confucianism, Duke University Press, Durham and London 1997. Cfr. Amina Crisma, “Il confucianesimo: essenza della sinità o costruzione interculturale?”, Prometeo, anno 30 n. 119, 2012, pp. 68-85.
[16] Stefano Cammelli, Ombre cinesi, Einaudi, Torino 2006.
[17] Fra questi va annoverato un grandissimo quale Marcel Granet, Il pensiero cinese (1934), Adelphi, Milano 1971, che ci offre una splendida e ammirata raffigurazione di una Cina ieratica, immersa in una dimensione atemporale.
[18] G.W.F.Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia,La Nuova Italia, Firenze 1947, vol. II, pp. 4-16, 32, 46-54.
[19] François Jullien, Il saggio è senza idee o l’altro della filosofia, Einaudi, Torino 2002. Cfr. Amina Crisma, recensione a Il saggio è senza idee, Asiatica Venetiana, 6/7, 2001/2002, pp. 293-297.
[20] Edward Slingerland, « Reverse Orientalism », lecture al Collège de France, 1 giugno 2010.
[21] Anne Cheng, « Pour en finir avec le mythe de l’alterité », in Ead., (a cura di), La pensée en Chine aujourd’hui, Gallimard, Paris 2007, pp. 7-18.
[22] Amina Crisma, “Fra miti e stereotipi: la costruzione dell’immagine occidentale del pensiero cinese”, in Giusi Tamburello (a cura di), L’invenzione della Cina, Congedo, Lecce 2004, pp. 101-111.
[23] Etienne Balasz, La burocrazia celeste, Il Saggiatore, Milano 1971.
[24] Jack Goody, Il furto della storia, Feltrinelli, Milano 2008.
[25] Cfr. Amina Crisma, “Studi sulle tradizioni del pensiero cinese”, in Alberto Melloni (a cura di), Dizionario del sapere storico-religioso del Novecento, Il Mulino, Bologna 2010, pp. 1705-1729.
[26] Maurizio Scarpari (a cura di), Cina, Einaudi, Torino 2009-2013.
[27] Kai Vogelsang, Cina, una storia millenaria, Einaudi, Torino 2014. Per una recensione di quest’opera, cfr. Amina Crisma, “Cinesi stranieri a se stessi”, alias, suppl. de il manifesto, 24 agosto 2014, p. 3 (anche in www.inchiestaonline.it)
[28] Vogelsang, op. cit., pp. XV-XVII.
[29] Marina Miranda, “La rivoluzione del 1911 cent’anni dopo: le implicazioni politiche”, in Ead. (a cura di), La Cina dopo il 2012. Dal centenario della prima repubblica al XVIII Congresso del Partito Comunista, L’asino d’oro, Roma 2013, pp. 32-50.
[30] Simon Leys, Le Studio de l’inutilité. Essais, Flammarion, Paris 2012, p. 219 (trad. di Amina Crisma).
[31] Edward Slingerland, What Science Offers the Humanities. Integrating Body and Culture, Cambridge University Press, 2008.
[32] Paul Ricoeur, La memoria, la storia, l’oblio, Raffaello Cortina, Milano 2003.
[33] Mark Edward Lewis, Sanctioned Violence in Early China, SUNY, Albany 1990.
[34] Lu Xun, Note sotto la lampada, in La falsa libertà, tr. e cura di Edoarda Masi, Quodlibet, Macerata 2006, pp. 62-71. All’immagine cruda del cannibalismo per denunciare la violenta prevaricazione esercitata sugli oppressi Lu Xun fa ricorso già in Diario di un pazzo, del 1918 (cfr. James Reeve Pusey, Lu Xun and Evolution, SUNY, Albany 1998). Mi sembra non privo di interesse notare che l’uso di questa metafora come dura denuncia di una feroce oppressione si riscontra nella letteratura pre-imperiale: l’espressione “divorare carne umana pur di conquistare nuove terre è un crimine” si trova, ad esempio, nell’opera di Mencio, grande pensatore confuciano del IV secolo a.C. (Mengzi 4 A 14, in Maurizio Scarpari, a cura di, Mencio e l’arte di governo, Marsilio, Venezia 2013, pp. 306-307).
[35] Chen Lai, Tradition and Modernity, Brill, Leiden 2009.
[36] Zhang Yinde, “La sinité: l’identité chinoise en question”, in Anne Cheng (a cura di), La pensée.., cit., pp. 300-322; Amina Crisma, “Zhongguo, Cina: molteplicità del Paese di Mezzo”; Ead., “Fra sinità e global philosophy: voci di un dibattito, dalla Cina e sulla Cina”, Cosmopolis 3, 1, 2008, pp. 1-4, 44-57 ( www.cosmopolisonline.it )
[37] Wang Hui, Impero o Stato-nazione? La modernità intellettuale in Cina, Academia Universa Press, Milano 2009;
[38] Benedict Anderson, Comunità immaginate, Manifestolibri, Roma 1996.
[39] Amina Crisma, “Idee di futuro nelle tradizioni di pensiero cinesi”, Giornale critico di storia delle idee, anno 2, n. 3, gennaio/giugno 2010 ( www.giornalecritico.it )
[40] Guido Samarani, La Cina del Novecento, Einaudi, Torino, 2008.
[41] Amina Crisma, “Interazioni intellettuali tra Cina e Occidente dal 1860 a oggi”, in Guido Samarani, Maurizio Scarpari (a cura di), Cina. Verso la modernità, Einaudi, Torino 2009, pp. 859-881.
[42] Angus C. Graham, La ricerca del Tao. Il dibattito filosofico nella Cina classica, tr. e cura di Riccardo Fracasso, Neri Pozza, Vicenza 1999.
[43] Cfr. Scarpari, Mencio e l’arte di governo, cit.; Amina Crisma, “Attualità di Mencio”, www.inchiestaonline.it (5 luglio 2013).