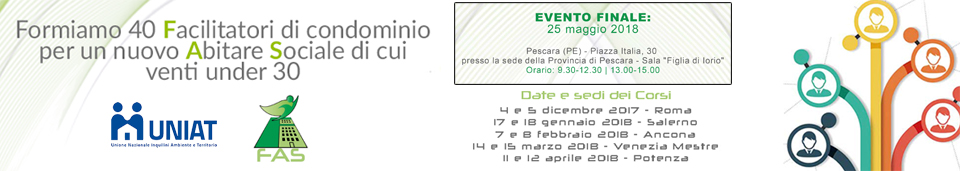Widgetized Section
Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone
Vergine giurata
«Siete nate storte» – afferma la madre di Hana e Lila, nelle poche righe che stentatamente riesce a scrivere alle figlie prima di morire –.
Hana – la protagonista del film, interpretata da Alba Rohrwacher – non è ancora adolescente quando, dopo aver perso i genitori naturali, viene accolta in casa come propria figlia da suo zio Gjergj (Bruno Shllaku), il padre di Lila (Flonja Kodheli) – un uomo roccioso come le montagne che abita –, e dalla moglie Katrina (Ilire Celaj).
Siamo nel nord dell’Albania, in un territorio aspro e freddo, dove il perno delle relazioni sociali è incentrato sulla famiglia allargata, all’interno di un ordine fortemente patriarcale, dove, quindi, non è un caso che una donna si senta prigioniera e in catene. Fra queste montagne, infatti, la vita è regolata in modo ferreo da tradizioni antiche, riunite – dal XV secolo – in un codice consuetudinario, chiamato Kanun di Dukagjini, che fu trasmesso oralmente fino all’inizio del XX secolo, quando venne definitivamente codificato in forma scritta.
All’interno di un ordine siffatto un’esistenza durissima attende le donne, un destino fatto di dipendenza, asservimento e riduzione alla mera funzione biologica della riproduzione: «un otre che sopporta pesi e fatiche». Per sottrarsi a questa sorte, Lila si ribella e fugge via per amore; Hana, invece, per lealtà incrollabile all’uomo che l’ha salvata e di cui è diventata figlia, decide di rimanere. E tuttavia, per conquistare la propria indipendenza, sceglie – proprio appellandosi alle regole del Kanun – di sacrificare se stessa diventando una «vergine giurata» e di assumere un’identità maschile: sottomettendosi ai valori patriarcali e riconoscendo la legittimità del potere maschile, muore al mondo come donna e rinasce come uomo.
Vergine giurata (Italia, Germania, Svizzera, Albania, Kosovo, 2015, 90’) – primo lungometraggio di Laura Bispuri, liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Elvira Dones (Feltrinelli, 2007), in concorso alla sessantacinquesima edizione della Berlinale, il Festival internazionale del cinema di Berlino, che si è svolto dal 5 al 15 febbraio del 2015 – è la storia della mortificazione di un corpo e dello smembramento di un’anima, della negazione e della successiva costruzione di un’identità, in un percorso di discesa e risalita che investe tanto il corpo quanto la psiche. Pur di non avere un uomo che regni su di lei, Hana decide di morire a se stessa e di rinascere come Mark, rinunciando a sperimentare la passione, i desideri, le pene e le gioie dell’istinto. A questa scelta radicale, segue un periodo confuso, fatto di solitudine e disperazione: si trasforma fisicamente, si abbrutisce volontariamente, beve raki, veste, cammina e si comporta come un uomo delle montagne. Alla fine Hana, vincendo le proprie oscure resistenze, rifiuta l’identità che ha costruito accettando i valori androcentrici, e parte alla ricerca di Lila e della propria femminilità perduta.
In questo suo primo film, Laura Bispuri – assistita nell’adattamento cinematografico da Francesca Manieri – racconta tutto questo abbandonando spesso il mondo della parola ed entrando nello spazio sconfinato dei gesti, dei silenzi, dei corpi, sovente ripresi immersi nell’acqua – altra fondamentale protagonista intorno a cui il film ruota –. I dialoghi, qui, sono scarni e le parole più importanti sono quelle non dette, e tuttavia, o forse proprio per questo, – pur potendo contare sull’impeccabile interpretazione di Alba Rohrwacher – la narrazione risulta a tratti ingenua (soprattutto nel finale), rinunciando – forse volutamente, nell’intenzione di evitare qualsiasi giudizio di valore sul mondo raccontato – a un’analisi rigorosa dei meccanismi che intervengono nella produzione della soggettività, da una parte, e a un’opera di profonda penetrazione psicologica della protagonista, dall’altra.
Il richiamo al quale risponde Hana, in tutte le sue scelte, è quello che la porta – in un continuo processo di decostruzione/costruzione della propria identità – verso un’autonoma creazione del proprio sé, che passa attraverso il recupero della propria femminilità, mai interamente posseduta, per arrivare – è questa la sfida – a essere «vergine» secondo il significato antico della parola, e cioè essenzialmente «una-con-se-stessa» – per usare l’efficace espressione di Esther Harding –, con un ruolo da interpretare che è suo e solo suo, anche rivendicando – come dice Hana – il diritto di essere «libera di non essere per forza qualcosa». Dunque, pur a volte esitante davanti al compito di scavare fino in fondo l’assenza e la presenza che si danno nel viaggio che l’eroina compie, Vergine giurata narra, attraverso sequenze anche intense, la storia di un passaggio, segnato da contraddizioni e impossibilità, in cui libertà e potere si implicano a vicenda, e l’uguaglianza è violenza contro la differenza.
La regista, che – pur essendo al suo primo lungometraggio – ha alle spalle tre cortometraggi di spessore (Passing time – con il quale ha vinto il premio David di Donatello nel 2010 –, Salve regina, sempre del 2010, e Biondina, del 2011), mostra una grande capacità nel tenere insieme i due diversi livelli narrativi e temporali del racconto, che si alternano lungo tutto il film: un passato in Albania e un presente in nord Italia. La fotografia spettacolare, densa e satura, affidata alla direzione di Vladan Radovic – già impegnato in film importanti come Anime nere (2014) e Isole (2011) –, l’uso della m.d.p. (macchina da presa) – prediletta nella narrativa di taglio documentaristico –, l’attenzione per le differenze linguistiche e il rigore nella scelta dei luoghi in cui il racconto è ambientato avvicina Vergine giurata a una certa tradizione del cinema italiano, attento a rappresentare quanto più fedelmente possibile il reale, non mancando per questo di slanci poetici e di orizzonti evocativi.
Bologna, 21 marzo 2015