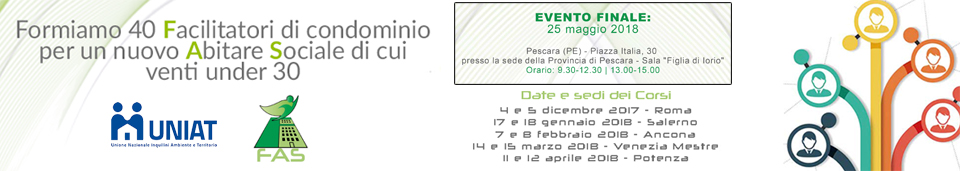Widgetized Section
Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone
Irrational Man, e il trionfo della middle class americana
di Maria C. Fogliaro
«La vita ha il significato che voi scegliete di darle», è quello che Woody Allen fa dire ad Abe Lucas (Joaquin Phoenix), nella seconda parte del suo ultimo film, Irrational Man (USA, 2015, 96’). Ma siamo certi che, per il regista newyorkese, la libertà di scelta sia assoluta? Che tutto − dal fare niente al fare qualunque cosa − sia permesso?
Nella prima parte della pellicola Abe Lucas è un professore di filosofia stanco della Vita e della sua vita, in particolare. Pur essendo un intellettuale brillante e radicale, che ha insegnato nelle più prestigiose Università del Paese, con un importante passato di impegno politico e civile alle spalle, Abe è un uomo disilluso, incapace di amare sia fisicamente sia affettivamente. Inoltre, non riesce più a scrivere ed è bloccato da anni sulla stesura di un libro su Heidegger e il nazismo.
Nichilista e autodistruttivo, tormentato − come i personaggi di Dostoevskij, che tanto ama −, con una preoccupante dipendenza dall’alcol e sull’orlo di un esaurimento nervoso, Abe va a insegnare al Braylin College − un piccolo istituto universitario collocato idealmente nel Rhode Island −. Preceduto da una fama di tombeur de femmes, il professor Lucas attrae subito le attenzioni di studenti, colleghi e di due donne in particolare, con le quali intreccerà due relazioni intime, ma diverse per intensità: la professoressa Rita Richards (Parker Posey) − una donna insoddisfatta della propria vita, dalla quale si illude di poter fuggire rifugiandosi in un amore irreale e inconsistente per Abe −, e Jill Pollard (Emma Stone), studentessa carina e compita, iscritta al suo corso di Strategia etica. Concordemente con quanto il professor Lucas ama dire ai suoi studenti, citando gli esistenzialisti, e cioè che «non succede niente finché non si tocca il fondo», Abe − aprendosi molto con Jill − prende coscienza di essere un uomo malato di disperazione. E proprio allora, grazie all’incontro fortuito con una sconosciuta, la sua situazione personale è destinata a rovesciarsi: tutto a un tratto, la vita di Abe Lucas inizia ad avere uno scopo, per quanto controverso.
In questo suo ultimo film ritroviamo molti dei temi ai quali, nella sua ricca produzione cinematografia, Woody Allen ci ha abituato: la questione della Giustizia e il dilemma esistenziale incentrato sulla «cosa giusta da fare»; la creazione di personaggi smarriti, portatori delle contraddizioni della vita moderna; il tema dell’aderenza fra teoria e realtà, fra il mondo pensato dai filosofi e la vita vera. E, soprattutto, l’idea che è il Caso a regnare sulle vicende umane. Tuttavia, a differenza dei suoi lavori precedenti, come Crimini e misfatti (1989) − dove Dio aveva problemi di vista − o Mariti e mogli (1992) − dove Dio si divertiva a giocare a rimpiattino −, qui invece il Caso ha il ruolo provvidenziale di far trionfare il Bene sul Male.
Lo sguardo di Allen, in questo film, è moralistico. Innanzitutto, lo vediamo seguire − anche attraverso continue citazioni filosofiche e letterarie − le evoluzioni dei suoi personaggi e giudicarne le azioni. E alla fine − sia pure per l’intervento del Caso − al delitto fa necessariamente seguire il castigo. L’esistenzialismo, inoltre, è presentato come intrinsecamente nichilista, e può solo condurre l’uomo o all’indifferenza nei confronti della vita e all’autodistruzione, o − al contrario − può alimentare fuorviate intenzioni di compiere atti eroici, a prescindere da qualsiasi considerazione morale. Ma neppure un mondo morale di ispirazione kantiana viene salvato: è un universo difficile da comprendere − come viene più volte sottolineato nel film −, la cui perfezione crea un’abissale distanza con la vita vera. Meglio affidarsi, allora, al buon senso dei rassicuranti e solidi valori della middle class americana.
Alla febbre di vita stuzzicata dall’idea del rischio estremo che improvvisamente colpisce Abe Lucas − e che ricorda tanto quella di Il giocatore di Dostoevskij, soprattutto nel punto in cui afferma: «Ero anch’io un giocatore: lo capii in quel preciso istante. Le gambe e le braccia mi tremavano, sentii come un colpo alla testa» −, Allen contrappone i valori piccolo-borghesi di Jill, del suo affettuoso e affettato fidanzato Roy (Jamie Blackley), e della sua famiglia di intellettuali benpensanti e radical chic, che abitano un mondo in cui le idee “romantiche” «sono difettose», e le uniche trasgressioni socialmente ammesse sono fare sesso fuori dal matrimonio e fumare erba con l’amante di turno − come manifesta esplicitamente la provocante ma spenta professoressa Richards −.
Il Woody Allen graffiante, irridente, decostruttivo, imprevedibile, che abbiamo tanto amato è ormai un lontano ricordo. Irrational Man risulta privo dello spessore, della lucidità seria e divertita, che hanno reso Allen uno dei più grandi cineasti mondiali e un mito per più di una generazione. Bella, invece, la fotografia dai toni caldi e morbidi di Darius Khondji. Del film, alla fine, resta la splendida colonna sonora, un omaggio al Ramsey Lewis Trio che, con The “In” Crowd (1965), avvolge lo spettatore per tutto il tempo, quasi a volerlo accompagnare − insieme ad Abe Lucas − fuori, On the Road, in tutta un’altra storia.