Widgetized Section
Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone
Filologia e demistificazione. Ritorno a Confucio/7
Prosegue con questo intervento di Attilio Andreini (Professore di Lingua cinese classica all’Università Ca’ Foscari di Venezia), il dibattito a cura di Amina Crisma sul libro di Maurizio Scarpari, Ritorno a Confucio. I precedenti interventi di Giangiorgio Pasqualotto, Paola Paderni, Luigi Moccia, Ignazio Musu e Guido Samarani sono stati pubblicati nella rubrica “Osservatorio Cina” di questa rivista . Il prossimo intervento è di Ester Bianchi. Nella foto l’autore con il figlio Cosimo che ha frequentato per due anni la scuola materna a Pechino.
Tra le pubblicazioni di carattere sinologico affacciatesi sul panorama italiano, Ritorno a Confucio. La Cina di oggi fra tradizione e mercato (Bologna, il Mulino, 2015) di Maurizio Scarpari ha destato un interesse senza precedenti e un simile dato offre spunti di riflessione ricchissimi sull’impatto che questo libro esercita e, sono convinto, continuerà a esercitare sul dibattito relativo al modo in cui la Cina si pone nel contesto culturale e politico-economico contemporaneo. Nessun’altra pubblicazione sinologica era riuscita a catturare così tanta attenzione presso giornalisti, politologi e politici, storici, filosofi, giuristi e anche imprenditori, studiosi del settore e semplici curiosi. Ritengo che la ragione prima di tanto clamore derivi proprio dal fatto che a Ritorno a Confucio sia stato riconosciuto un elemento di raro pregio: la capacità di parlare a chi sta dentro e a chi sta fuori della crescente, ma pur sempre circoscritta, comunità di sinologi. A ciò si aggiungono coraggio e “personalità” nell’affrontare temi di scottante attualità adottando, però, una chiave di lettura che ruota sull’imprescindibilità di un approccio filologico nell’analisi dei fenomeni storici e politici della Cina di oggi. “Filologia, lucidità e accessibilità”: queste ritengo siano le caratterizzazioni che meglio riflettono il taglio di Ritorno a Confucio.
Il grado di consapevolezza della centralità della Cina sta certamente crescendo in Italia; tuttavia, non poche difficoltà emergono quando la comunità sinologica cerca di sensibilizzare e coinvolgere istituzioni, società civile e anche lo stesso mondo universitario per un confronto sui temi cruciali e strutturali del “pianeta Cina”. Inutile nasconderlo: noi che ci riteniamo “specialisti” siamo, in molte sedi, marginali. Non è raro, allora, che voci estranee alla dimensione sinologico-accademica riescano a catalizzare l’attenzione del pubblico, che spesso riconosce quali interlocutori più idonei e “accessibili” economisti, politologi, filosofi e giuristi di formazione “tradizionale”, ma anche imprenditori, ovvero figure ritenute maggiormente qualificate ad esprimersi su ciò che la Cina è oppure diventerà in un futuro più o meno prossimo. “Presente” e “futuro” sono, ovviamente, gli scenari che destano interesse maggiore, sia presso il pubblico non specializzato sia tra gli studiosi, proprio perché si è ormai rafforzata la convinzione che solo il recente affermarsi sullo scenario internazionale della Cina motivi un interesse profondo verso questo paese. Il passato, invece, è passato. Se non proprio “morto”, “moribondo”.
Ritengo che il volume di Scarpari dimostri, finalmente, l’esistenza di uno spazio (e, quindi, di un’effettiva necessità, di un bisogno culturale, visto l’interesse riscosso) dove profondità di analisi e accessibilità si conciliano per dare vita, come nel caso di Ritorno a Confucio, a un caso letterario capace di sollecitare un ampio dibattito sulla Cina che vada al di là di un coinvolgimento limitato agli addetti ai lavori. Sono convinto che una delle motivazioni più solide che hanno determinato l’interesse verso il lavoro di Scarpari dipenda, guarda caso, proprio dall’aver dilatato l’orizzonte d’indagine oltre le dimensioni del presente e del futuro per rivolgere uno sguardo attento verso il passato: un passato cui riconoscere il significato di “origine”, di “fondamento”, talora anche di “pretesto” o “fardello”, ma comunque necessario perché potessero scaturire le condizioni attuali; un passato ineludibile perché, altrimenti, la lettura dei fatti porterebbe a fraintendere dinamiche storiche che hanno, in molti casi, radici lontanissime. Consiglio la lettura del volume Confucianesimo. I fondamenti e i testi (Torino, Einaudi, 2010) dello stesso Scarpari, che magistralmente fissa i cardini del Confucianesimo delle origini e che, assieme a Ritorno a Confucio, contribuisce a definire un quadro chiarissimo di come è nato, si è consolidato e dei profili che ha assunto, nei secoli, una forma di pensiero tanto complessa e rilevante da identificarsi, secondo alcuni, con il nucleo stesso della sinicità. Ma… sarà vero?
Rispondere a questa domanda non è semplice, ma è innegabile che un approccio filologico sia essenziale in tutta la sua forza dissacratoria per capire cosa sia il Confucianesimo e per cogliere pienamente il senso di una canonicità perennemente in bilico tra derive strumentali, ibridazioni e tradimenti capaci di rendere questa dottrina un collante proteiforme che, per millenni, ha tenuto legato uno dei più duraturi e potenti imperi della storia (e che oggi è chiamata a rafforzare il potere di una leadership socialista con velleità di superpotenza economica, politica e culturale). Più avanti spiegherò meglio cosa intendo con “forza dissacratoria”. Per adesso mi limito a ribadire come, con Ritorno a Confucio, Scarpari non si sia discostato di un millimetro dalla propria vocazione di classicista e filologo per avventurarsi sul terreno sdrucciolevole della contemporaneità. Nessuno scivolone: il rigore, la lucidità analitica, l’accanimento nella raccolta dei dati e la simmetria della sintesi hanno garantito solidità all’impianto argomentativo e perfetta tenuta di strada. Rispetto alle sue opere precedenti, l’autore ha solo (si fa per dire…) voluto dimostrare che un approccio filologico per lo studio della Cina odierna fornisce uno strumento di approfondimento ulteriore dell’analisi critica e che il possesso di competenze robuste sulla civiltà antica, più che “utile”, risulta, pertanto, “essenziale”.
Qualcuno ha definito la filologia il processo di “disvelamento delle dinamiche dell’imperfezione”. I testi, essendo opere umane, non possono che essere imperfetti, ragion per cui la ricerca filologica tende non tanto al ripristino di condizioni di purezza assoluta, ma all’avvicinamento asintotico di verità già contraffatte e violate in partenza. Ecco, dunque, in cosa risiede la forza dissacratoria della filologia: sottrarre legittimità delle fonti “alla fonte”, evidenziare le zone grigie di frammentazione di messaggi che, come fenomeni carsici, compaiono e scompaiono rivelando, nel tempo, tracce di continuità e discontinuità simultanee. A tal proposito ricordo che Scarpari ha scritto un seminale e influente articolo intitolato «‘The Master said’…or Didn’t He?» (in A. Rigopoulus, a cura di, Guru. The Spiritual Master in Eastern and Western Traditions: Authority and Charisma, Venezia, Cafoscarina, 2004, pp. 437-470) in cui l’autorità della figura di Confucio veniva prima smontata pezzo per pezzo e poi ricomposta all’interno di una cornice ideologica che imponeva la creazione posticcia di un’ortodossia a uso e consumo del potere. Non c’è da scandalizzarsi: per secoli e secoli la leadership politica cinese (e non solo…) ha avvertito, nelle fasi storiche cruciali in cui era necessario ridefinire i valori identitari e, quindi, legittimanti per l’esercizio dell’autorità, il bisogno di guardare al proprio passato e di dotarsi di strumenti (pseudo) filologici per orientarsi tra posizioni antagoniste che rivendicavano, ognuna, una propria consacrazione. Non c’è impero senza ortodossia e questa, in molti casi, viene costruita attraverso dinamiche (para/pseudo)filologiche per addomesticare uno dei tanti “passati” su cui si pretende che il presente debba trovare piena legittimazione. Si pensi all’impatto del processo di canonizzazione del sapere sulla politica della dinastia Han (in particolare a partire dalla metà del II secolo a.C.), così come alla ri-fondazione di una nuova classicità sotto i Tang (VI-X secolo), alla rilettura delle fonti antiche sotto i Song (960-1279) che portò all’arricchimento del messaggio “tradizionale” confuciano esposto alla contaminazione delle speculazioni cosmologico-metafisiche daoiste e buddiste – che dette vita al “Neoconfucianesimo”, meglio alla “Dottrina del Principio” – e che stabilì nuovi criteri di arruolamento del personale burocratico perché era sulla base della conoscenza di quelle interpretazioni dei testi classici che dipendeva l’accesso alle più alte cariche della burocrazia. Come dimenticare, infine, gli eruditi del tardo periodo imperiale (XVII-inizio XX secolo) che, in opposizione all’esegesi neoconfuciana, promuovevano gli Hanxue “Studi Han” (ovvero “Studi classici” o “Studi tradizionali-nazionali”), che miravano a una riappropriazione del senso più autentico delle opere antiche, svelandone spesso la natura spuria e contraddittoria grazie all’adozione di un approccio filologico volto alla “verifica”, al “riscontro” testuale (kaozheng)…
Alla luce di questo sbrigativo excursus, non s’intravede, forse, uno schema sostanzialmente omogeneo nel suo dipanarsi? Sta accadendo qualcosa di simile, oggi, in Cina? In che modo la legittimazione del potere passa attraverso l’adesione della leadership politica a una tradizione gloriosa e longeva che va risuscitata attraverso pillole di antica saggezza debitamente decontestualizzate da esibire sui muri delle città? E cosa significano quei muri tappezzati da immagini edificanti accompagnate da citazioni magari non sempre comprensibili ai più, ma comunque fortemente evocative nel loro richiamo a dettami morali che solo pochi anni fa erano ritenuti dal Partito Comunista la vera causa dell’arretratezza e della miseria della Cina? Cosa è cambiato in un lasso temporale così breve? Davvero è cambiato qualcosa?
Le domande che Scarpari si pone e la densità dei temi che affronta in Ritorno a Confucio sollevano questioni così cruciali da proiettare automaticamente il volume in una dimensione “calda”, caldissima: in altri termini, direttamente nel cuore del dibattito internazionale sul senso autentico del Confucianesimo, della tradizione, dell’ortodossia, del potere. E, perdonate l’insistenza, anche della filologia.
La lettura del libro di Scarpari mi induce automaticamente a tracciare due connessioni che esprimono, da sole, la statura del volume che ispira il mio intervento nell’appassionante discussione promossa da Inchiesta.
La prima connessione lega Ritorno a Confucio all’opera di Li Ling, docente presso l’Università di Pechino e, guarda caso, filologo. Tra il 2007 e il 2008 Li Ling ha pubblicato due libri su Confucio e sul rinnovato interesse da parte dell’establishment nei confronti del Confucianesimo; la prima monografia, in particolare, ha sollevato un dibattito estesissimo, fuori e dentro la Cina, polarizzando su posizioni contrapposte accaniti detrattori e ferventi sostenitori delle posizioni espresse dell’intellettuale cinese. Entrambi i testi, si noti bene, furono pubblicati prima dell’avvento di Xi Jinping. Nell’ormai celebre Sanjiagou: Wo du Lunyu (Un cane senza dimora: La mia lettura dei Lunyu, i.e. dei Dialoghi di Confucio, Taiyuan, Shanxi renmin chubanshe, 2007), Li Ling tenta – come il summenzionato «‘The Master said’…or Didn’t He?» di Scarpari – di rivolgersi agli insegnamenti originari del Maestro, rimuovendo le sedimentazioni ideologiche posteriori che ne hanno deturpato il senso. Proprio per questo Li Ling manifesta forte preoccupazione e disagio verso quanti rivendicavano, già più di dieci anni fa, la necessità d’ispirarsi a Confucio per guarire i mali della Cina, dato che quel Confucio cui le leadership politiche si sono, nel tempo, ispirate, in realtà non è mai esistito. Li Ling tenta di riportare alla luce con strumenti filologici il “vero” Confucio che, sepolto sotto una glorificazione costruita a tavolino, è stato, al contrario, un “perdente”, un “cane senza dimora”, un reietto, incapace d’incidere profondamente nella vita dei propri contemporanei. La metafora del “cane senza dimora”, badate bene, deriva direttamente dalle fonti di epoca Han, che già nel II secolo a.C. dipingevano Confucio come un intellettuale apolide, radicalmente dissociato dal proprio habitat storico-culturale perché mosso da ideali etici troppo elevati per poter essere accolti. Ovviamente, “cane senza dimora” è lo stesso Li Ling, intellettuale iconoclasta che si sottrae al clamore roboante prodotto da slogan confuciani plastificati, devitalizzati, massificati ma, a ben vedere, anche la peculiarità di Ritorno a Confucio fa del suo autore un “cane senza dimora” nel panorama italiano (e non solo). L’altro volume di Li Ling, Qu sheng nai de zen Kongzi: Lunyu zongheng du (Apparirà il vero Confucio solo quando lo si priverà della saggezza. Una lettura trasversale dei Lunyu, Beijing, Sanlian), uscito nel 2008, si attesta sul medesimo livello di lucidità e disincanto. In buona sostanza, l’interpretazione di Li Ling si contrappone a quella dei nuovi apologeti del Confucianesimo, tra cui spicca Yu Dan, professore di Scienze della Comunicazione della Beijing Normal University e autrice di una fortunata serie di lezioni televisive su Confucio, poi condensate nel volume Yu Dan «Lunyu» xinde (L’essenza dei Dialoghi [di Confucio] secondo Yu Dan, Beijing, Zhonghua shuju, 2006; in italiano La vita felice secondo Confucio, traduzione di Valentina Potì, Milano, Longanesi, 2009).
Ribadisco che il disvelamento del senso politico e ideologico di un’operazione di travestimento (o “rinascimento”) del Confucianesimo classico può avvenire solo grazie all’adozione di strumenti filologici. Su questo punto, anche i contemporaneisti non possono non sentirsi chiamati in causa…
Concludo tracciando la seconda connessione: meno di un anno fa usciva World Philology, volume curato da Sheldon Pollock, Benjamin A. Elman e Ku-ming Kevin Chang (Cambridge and London, Harvard University Press, 2015). Si tratta di un contributo scientifico fondamentale nel processo di ridefinizione del senso della filologia e della sua capacità (o “volontà”) di includere tradizioni intellettuali extra-europee. Il senso dell’ambizioso e necessario progetto dei tre studiosi è racchiuso in queste parole: “How coherent in fact is philology as a conceptual category across time and space, or is it impossible to unify without introducing serious distortion in any given tradition? How do we assess philology’s relation to other forms of thought, such as scientific or legal thought, and explain the changes in its intellectual status? And— what is perhaps most important, if most elusive— how far may a reconstruction of philological practices in the past relate to a reconstruction of philological practices in the future?” (World Philology, cit., p. 2)
L’approccio filologico, dunque, definisce dimensioni concettuali e pratiche che legano indissolubilmente passato e futuro. Manca il “presente”. In ciò, però, risiede la centralità dell’etica filologica: nell’assenza di “presente”, nell’accanita aderenza a un principio di inattualità, ovvero un principio di demistificazione.
Non mi stupisce, dopo quanto esposto, che ci sia voluto un filologo e classicista come Maurizio Scarpari per convincere i numerosi e attenti osservatori della Cina del XXI secolo a concentrarsi su un tema apparentemente “inutile” – che parola meravigliosa! – ovvero il “passato” visto (o “intravisto”) attraverso l’intricata dimensione sociale cinese odierna.






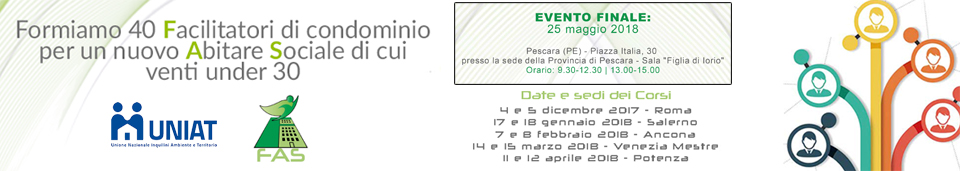
1 Responses to Filologia e demistificazione. Ritorno a Confucio/7