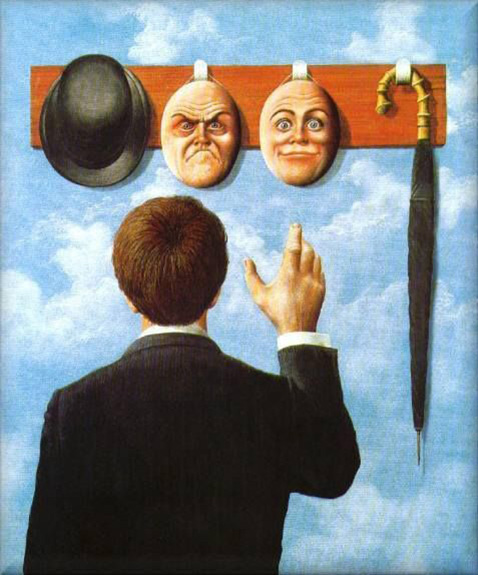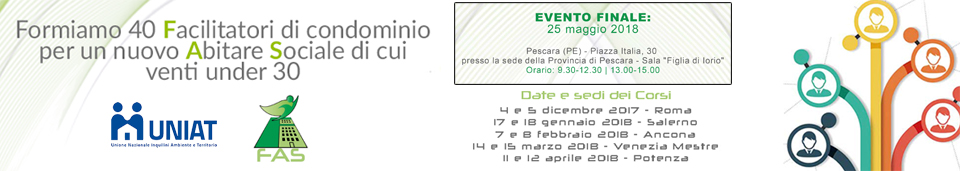Widgetized Section
Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone
Tertium non datur
Lo scorso 11 gennaio, la Corte Costituzionale si è espressa sulla legittimità dei tre quesiti referendari abrogativi proposti dalla CGIL ma sono stati ammessi solo due dei referendum proposti.
In sintesi, i tre quesiti si proponevano di abolire alcune norme inserite nel disegno complessivo del “Jobs Act”, la riforma del mondo del lavoro varata dal governo Renzi tra il 2014 ed il 2015, e sono stati, inoltre, accompagnati da una proposta di legge d’iniziativa popolare: l’introduzione della carta dei diritti universali del lavoro, un nuovo statuto delle lavoratrici e dei lavoratori.
Non si può non rispettare l’impegno da parte del sindacato che ha depositato, nel luglio 2016, circa 3,3 milioni di firme; sarà, tuttavia, ora indispensabile una efficace campagna informativa dei contenuti delle norme oggetto di abrogazione, l’utilizzo dei voucher lavoro ed il ripristino della responsabilità in solido negli appalti in caso di violazioni subite dai lavoratori, e una seria autocritica, poiché la CGIL ha mancato il quesito sull’articolo 18, che era politicamente il vero fulcro dell’iniziativa.
Il quesito è stato ritenuto inammissibile e tale posizione era, comunque, ampiamente prevista e prevedibile. La proposizione del referendum intendeva, infatti, non solo abrogare le modifiche apportate dal Jobs Act allo Statuto dei lavoratori e reintrodurre i limiti per i licenziamenti senza giusta causa, ripristinando la tutela reale del posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, ma anche estendere tale tutela reintegrativa a tutte le aziende con più di cinque dipendenti, contro il tetto dei 15 dipendenti del vecchio articolo 18 Legge 300/70.
Si trattava, in sintesi, non di una istanza abrogativa bensì di forzatura propositiva, non di pertinenza di un referendum abrogativo; è vero che la Suprema Corte, appena qualche mese prima, aveva trasformato di fatto una legge elettorale, come l’Italicum, in una legge proporzionale corretta da un ampio premio di maggioranza, specificando che la legge avrebbe potuto essere immediatamente applicabile ma quella sentenza è stata una decisione anomala in un contesto politico controverso.
Il Jobs Act è figlio di un percorso di “svuotamento dello Statuto dei Lavoratori”, iniziato con la Riforma Biagi (Legge 30/2003: co.co.pro, jobs on call, job sharing), il Decreto Salva Italia (art. 8 DL 138/2011: libertà di contrattazione territoriale e aziendale) e la Riforma Fornero (Legge 92/2012: lavoro e pensioni). Avrebbe dovuto essere emanazione diretta del Parlamento che, con la Legge Delega 183/2014, aveva dato mandato al Governo di redigere una norma in materia di “riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”.
La riforma renziana ha, di fatto, però superato l’articolo 18 ed il meccanismo delle “tutele crescenti”, sostituendo il diritto al reintegro con un indennizzo economico anche in caso di licenziamento senza giusta causa; molti commentatori parlano di contratto di tutele crescenti come se si trattasse di una nuova forma contrattuale, dimenticando che il provvedimento legislativo incide unicamente sul regime di tutela spettante ai lavoratori neoassunti nelle ipotesi di licenziamento intimato illegittimamente.
Non siamo davanti ad un nuovo contratto di lavoro, ma ad diversa forma di tutela riservata agli assunti dopo il 7 marzo 2015 (o in alcuni casi riservata anche ai lavoratori già occupati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina), poiché il nuovo art. 18 riguarda solo gli aspetti legati alla fine del rapporto di lavoro, definendo specifiche sanzioni parametrate all’anzianità di servizio del singolo lavoratore licenziato.
Non era questo l’obiettivo originario della delega: nella prima stesura del disegno di legge delega (DDL n. 1428/2014) si prevedeva una mera possibilità (ed eventualmente anche in via sperimentale) di introdurre “ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti dei lavoratori coinvolti” mentre la Commissione Lavoro al Senato ha scritto l’emendamento all’art. 4 DDL n. 1428/2014 con l’introduzione del contratto a tempo indeterminato a tutele progressive, arrivando alla formulazione dell’attuale art. 1, comma 7, lett. c) della L. 183/2014.

In sintesi, quindi, l’ambito di applicazione della disciplina include non solo i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 07/03/2015 (entrata in vigore del decreto), ma anche i dipendenti già in forza a tale data il cui datore di lavoro abbia occupati più di 15 dipendenti in seguito ad assunzioni verificatesi dopo l’entrata in vigore del decreto (ovvero, ancora, i dipendenti il cui contratto di apprendistato o contratto a tempo determinato sia stato convertito, dopo tale data, in contratto a tempo indeterminato, anche quale conseguenza di un regime sanzionatorio, o con contratto): ciò che è evidente è che l’incentivazione delle assunzioni, obiettivo principe della riforma del lavoro, comporta necessariamente un’inevitabile discriminazione in ordine alla tutela applicabile in caso di licenziamento illegittimo per la tipologia di lavoratori assunti post Jobs Act rispetto ai “vecchi” assunti che si trovavano, invece, già occupati in aziende con più di 15 dipendenti, in quanto questa tipologia di dipendenti è ancora tutelata dall’art. 18 della L. 300/1970.
In un contesto così articolato, gli attori politici, ed anche quelli sindacali, hanno dimenticato, o non condividono, il principio previsto dall’articolo 3 della Costituzione:
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
La violazione di questo principio dovrebbe essere ragione sufficiente per ritenere illegittima la norma.
Bologna, 4 marzo 2017
Mirella Di Lonardo