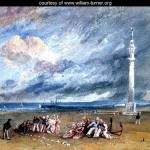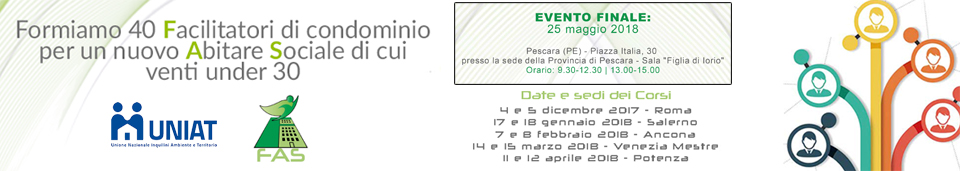Widgetized Section
Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone
Impoverimento e pandemia: contrastare i rischi di esclusione
La pandemia che continua a sconvolgere le nostre vite ha determinato un aggravarsi dei rischi di impoverimento di grande portata e complessità. La crisi sanitaria, che non riguarda solo le persone colpite dal virus ma anche chi soffre di altre gravi patologie, ha infatti provocato un intenso e prolungato deterioramento di molti aspetti fondamentali delle condizioni sociali ed economiche di parti rilevanti della popolazione. Analizzare i processi di impoverimento richiede quindi una visione di ampio respiro, che vada oltre la sequenza negativa dei dati congiunturali e tenti di cogliere gli effetti di medio e lungo periodo della rottura d’epoca provocata dal diffondersi del virus Sars-CoV-2 e dalla correlata patologia Covid-19.
La prima fondamentale dimensione del capitale umano che viene messa in pericolo dalla pandemia è naturalmente quella della salute. In Italia le persone decedute con sintomi di Covid-19 si avvicinano alle 77.000 unità, di cui più di 8.000 in Emilia-Romagna. I dati disponibili evidenziano una forte concentrazione dei decessi nella fascia più anziana della popolazione: circa l’86% delle morti ha infatti colpito persone con più di 69 anni. Se allarghiamo lo sguardo alla condizione sanitaria complessiva iniziano a emergere i rischi di ritardata presa in carico o di insufficienti cure nei confronti di individui colpiti da altre gravi patologie; anche in questo caso è molto probabile riscontrare un’elevata presenza di donne e uomini in età avanzata.
Queste evidenze giustificano la scelta di inserire le persone più anziane (a partire da quelle ricoverate nelle strutture assistenziali) fra le categorie a cui proporre in via prioritaria la vaccinazione contro il virus. Una volta superata questa emergenza bisognerà però affrontare in modo permanente e lungimirante quella che si può definire la sfida della longevità avanzata. Le previsioni demografiche di medio e lungo periodo individuano infatti come una tendenza fondamentale il forte incremento assoluto e relativo delle persone in età superiore a 79 anni, che al momento attuale vedono una presenza femminile largamente maggioritaria. La pandemia ci ha rivelato crudelmente che molto spesso al sensibile allungamento della durata della vita si associa una condizione di salute precaria, caratterizzata dalla presenza di una pluralità di patologie e in alcuni casi da pesanti condizioni di solitudine. Il nostro sistema sanitario e più in generale l’organizzazione delle relazioni sociali e della vita economica dovranno confrontarsi nei prossimi decenni con questo accentuato invecchiamento della popolazione, che richiederà nuove politiche e ingenti risorse economiche, relazionali e tecnologiche.
Una dimensione essenziale della risposta alla sfida della longevità avanzata dovrà essere garantire pienamente anche a questa fascia di popolazione il diritto alla connessione. La pandemia ha rivelato l’importanza decisiva delle tecnologie per continuare la vita economica e mantenere le relazioni sociali; ha purtroppo reso evidente anche la sostanziale esclusione dalle risorse e dai legami offerti dalla Rete di una parte dei bambini e dei ragazzi e soprattutto di un’ampia quota delle persone più anziane. Affrontare questo problema significa intervenire con urgenza su tre dimensioni: diffondere possibilità adeguate di connessione in tutti i territori; sostenere economicamente le famiglie più fragili per affrontare i costi legati all’utilizzo degli strumenti digitali; realizzare un grande piano di formazione e assistenza all’utilizzo delle nuove tecnologie rivolto alle fasce di popolazione oggi escluse. In questa prospettiva avrebbe un importante significato simbolico di un nuovo patto generazionale il lancio di un progetto di servizio civile di inclusione digitale, che veda decine di migliaia di giovani accompagnare nella Rete i ragazzi e le persone in età più avanzata.
Il tema delle connessioni digitali richiama immediatamente l’esperienza della didattica a distanza, che ha segnato l’esperienza di milioni di docenti e studenti per una parte significativa dei due ultimi anni scolastici. Tutte le ricerche disponibili segnalano il rischio di un forte aggravamento delle povertà e delle disuguaglianze educative presenti prima della pandemia. L’Istat ha recentemente documentato l’esclusione di una quota significativa degli studenti con disabilità dalla vita scolastica; più in generale il rischio di abbandono totale o parziale coinvolge una parte significativa dei ragazzi e dei giovani. Non possiamo rassegnarci a questa grave perdita di capacità cognitive e di relazioni sociali; bisogna quindi immaginare in una prospettiva di medio e lungo periodo azioni che si potrebbero definire di “ristoro educativo”, che abbiano la stessa intensità e centralità delle misure giustamente messe in campo in questi mesi per sostenere la condizione economica delle famiglie e gli equilibri delle imprese.
La pandemia ha quindi colpito in modo grave due fondamentali dimensioni del capitale umano e della nostra civiltà: la salute e l’istruzione. Ha anche determinato uno sconvolgimento delle relazioni umane, dove tutti i gesti che prima erano desiderabili e auspicabili (incontrarsi, abbracciarsi, conversare) sono diventati all’improvviso pericolosi individualmente e socialmente. Le conseguenze di questa radicale inversione delle preferenze e dei comportamenti sulle condizioni psicologiche e sugli atteggiamenti futuri di tutti noi sono difficili da ipotizzare. Nel programma di ricostruzione e rinnovata ripartenza della vita sociale ed economica bisognerà dedicare attenzione e risorse a questo aspetto di graduale ripresa delle relazioni sociali, oltre gli schermi dei nostri telefoni cellulari e computer. Anche in questo caso la pandemia non ha colpito tutti nello stesso modo e i danni più pesanti sono stati subiti dalle persone più fragili.
Veniamo ora, in conclusione, al tema che normalmente assorbe la maggiore attenzione nell’analisi dei processi di impoverimento: la condizione economica degli individui e delle famiglie e le prospettive delle imprese e delle altre organizzazioni economiche. Il carattere asimmetrico dei danni inferti dalla pandemia è apparso immediatamente con grande evidenza: alla forte concentrazione del rischio sanitario nella popolazione più anziana si è infatti associato un deterioramento della condizione economica più marcato nella fascia giovanile della popolazione. Tutte le analisi disponibili mostrano che la perdita delle possibilità occupazionali ha interessato i dipendenti con contratti a tempo determinato e i lavoratori autonomi impegnati nei settori più colpiti dalle restrizioni imposte dalla pandemia (quali, ad esempio, il commercio, la ristorazione, il turismo e in generale tutte le attività economiche dove la dimensione del contatto umano è prevalente). Per comprendere l’intensità e la durata dei danni apportati dalla pandemia alla condizione economica delle persone e delle imprese è necessario attendere: i dati attuali sono infatti condizionati dal ricorso eccezionale a diverse forme di ammortizzatori sociali, dalla cassa integrazione al blocco dei licenziamenti, che contengono la gravità del deterioramento della condizione occupazionale.
Oltre il succedersi dei dati congiunturali appare comunque consolidato un aspetto, che deve essere valutato con estrema preoccupazione: i danni più pesanti nelle prospettive di vita sociale ed economica futura vengono subiti dai giovani e dalle donne, aggravando la situazione di un Paese come l’Italia che già era caratterizzato da livelli di partecipazione al mondo del lavoro di queste persone nettamente inferiori in molte regioni alla media europea. La condivisione di questa analisi deve portare tutti coloro che hanno responsabilità nel disegno di rinnovata ripartenza dell’Italia a un obbligo di coerenza: ogni provvedimento finanziato da fondi europei o nazionali deve porsi come obiettivo prioritario riaprire possibilità di protagonismo economico e sociale alle persone più colpite dalla crisi, che sono appunto i giovani e le donne.
Se questa deve essere la bussola che guida e conferisce senso e una direzione di marcia ai diversi interventi emergono alcuni rischi. Ne evidenzio uno: i provvedimenti, che ritengo giusti e necessari, di forte incentivazione dell’attività edilizia attraverso il Superbonus del 110% rilanciano un settore con una forte dominanza dell’occupazione maschile. Bisogna quindi accompagnare a questa priorità un intervento di analogo rilievo simbolico ed economico finalizzato alla promozione e innovazione delle fondamentali reti di welfare, che vedono una maggiore intensità dell’occupazione giovanile e femminile. Dobbiamo sicuramente riqualificare il patrimonio edilizio da un punto di vista energetico, sismico e dell’accessibilità. Nello stesso tempo bisogna però potenziare e rinnovare profondamente l’insieme dei servizi di educazione, assistenza e cura, che in questa pandemia si sono rivelati come non mai decisivi per le nostre vite. In questo sforzo di ricostruzione dobbiamo essere capaci di utilizzare al meglio tutte le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, assicurando come affermato in precedenza il loro potenziale di maggiore inclusione sociale. La modifica più importante riguarda però il nostro “software”, le intelligenze individuali e collettive: non dobbiamo farci guidare dalla nostalgia per il passato, che presentava aspetti non più sostenibili e che hanno contribuito al dramma pandemico; dobbiamo invece cogliere l’occasione del cambiamento rimbalzando in avanti, nella direzione dello sviluppo sostenibile che l’Agenda 2030 approvata nel 2015 dalle Nazioni Unite aveva indicato con lungimiranza.
Pubblicato sulla rivista “Pandora” www.pandorarivista.it il 16 gennaio e ripreso con autorizzazione dell’autore.
Statistico e demografo, ha lavorato per il Comune di Bologna, dirigendo dal 1994 al 2016 l’Area Programmazione, controlli e statistica. Dal 2017 collabora con ASviS e Fondazione Unipolis sui temi dello sviluppo sostenibile e dell’attuazione in sede locale dell’Agenda 2030. Autore di “Bologna oltre il Pil. Lo sviluppo sostenibile in Emilia-Romagna e nella città metropolitana” (il Mulino 2019).