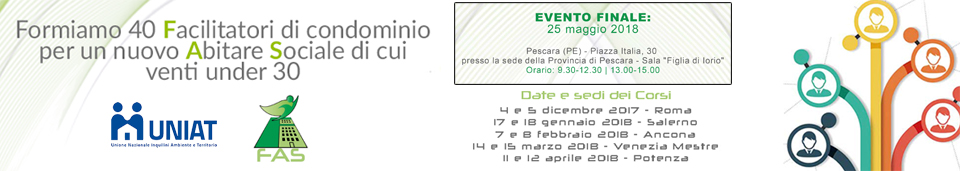- Giovedì, Aprile 10, 2025
- Stay Connected
Widgetized Section
Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone
Il buddhismo è critico? Amina Crisma intervista Matteo Cestari
di AMINA CRISMA
(in collaborazione con www.inchiestaonline.it)

*
Dharma today, il recente convegno internazionale sul buddhismo al cui proposito Amina Crisma ha intervistato per Inchiesta Giangiorgio Pasqualotto e gli organizzatori Chiara Mascarello e Francesco Tormen (www.inchiestaonline.it 24 febbraio e 3 marzo) le ha offerto l’occasione per questa conversazione con Matteo Cestari, docente di Studi culturali e Religioni e filosofie dell’Asia orientale all’Università di Torino.
- Prima di iniziare la nostra conversazione, vorrei innanzitutto rendere omaggio alla memoria di un grande studioso del buddhismo prematuramente scomparso due anni fa, il 29 aprile 2020, Stefano Zacchetti. La sua morte ci ha privati non solo di un ricercatore di straordinario talento, ma anche di un generoso amico. Potresti aiutarmi a tratteggiarne il ricordo?
Ho di Stefano un ricordo molto vivo e molto caro, che rende il pensiero della sua scomparsa ancora più difficile. Ho avuto l’onore di conoscerlo già all’università a Venezia: eravamo compagni di molti corsi, abbiamo fatto insieme l’esame finale di dottorato, le nostre famiglie si conoscevano. Era un amico. Ma era anche un grande studioso, uno dei pochissimi che riusciva a gestire mondi culturali e linguistici tanto diversi, come l’India e la Cina, tenuti insieme dal passaggio unico dei testi buddhisti dall’India alla Cina. Stefano, pur essendo un grande filologo, non si limitava al solo aspetto filologico, ma rifletteva sul peso che la cultura indiana aveva su quella cinese e ne vedeva le ramificazioni linguistiche e filosofiche. La perdita per il mondo degli studi buddhisti è stata enorme e non facilmente rimpiazzabile.
- Il recente convegno Dharma today a cui hai partecipato come relatore ci ha offerto, mi pare, molti contributi importanti per una rappresentazione approfondita e articolata del buddhismo, o per dir meglio, dei buddhismi, come sarebbe forse preferibile dire, per tenere conto adeguato di una irriducibile pluralità che spesso non è colta nelle rappresentazioni da noi invalse. Potresti dirci, in sintesi, quali ti sembrano gli spunti di riflessione salienti emersi dal dibattito in tale direzione?
Si è tratta di un convegno molto articolato. Hanno partecipato numerosi studiosi italiani e stranieri, con un’accesa partecipazione da parte del pubblico, anche online. Questa esperienza, la prima del genere in Italia, è stata un’ottima occasione per far dialogare fra loro studiosi di buddhismi con competenze anche molto diverse (da filologi a storici delle religioni, da filosofi ad antropologi, senza dimenticare i neuroscienziati e gli psicologi e tutti con competenze culturali e geografiche differenziate). Si è discusso molto della storia del buddhismo e del suo possibile spazio culturale in futuro. Ma ci sono stati anche vari momenti di rapporto con il pubblico, rappresentato da membri dell’UBI e da persone semplicemente interessate agli argomenti. Gli organizzatori hanno impostato i lavori con un format che evitasse l’auto-celebrazione o la retorica di rappresentanza e che puntasse invece a domande “vere”. Queste domande sono state orientate su alcuni temi-chiave, come ad esempio: che rapporto può esserci fra buddhismo e ricerca scientifica, soprattutto rispetto ai contemplative studies? Le varie forme di buddhismo possono (e se sì, come) facilitare la risoluzione di almeno alcuni problemi culturali, sociali, etici, politici e ambientali che affliggono il nostro presente? Che risposte si è dato e si sta dando il mondo buddhista nel suo rapporto con il mondo contemporaneo? L’ampiezza e la profondità di queste domande hanno permesso interpretazioni molto variegate su questi temi. Che il confronto non si sia limitato al solo mondo accademico, grazie alla partecipazione attiva del pubblico, è stato uno stimolo anche per gli accademici ad uscire dallo specialismo della loro professione.
- Nelle percezioni da noi correnti, il buddhismo in toto è spesso ricondotto a un’icona (invariabilmente irenica e pacifista) nell’ambito di una schematica opposizione Oriente/Occidente; vari interventi del convegno, mi pare, hanno invitato a rivisitare questo schema dualistico astratto, per dar spazio sia alla rappresentazione concreta delle complesse dinamiche e delle tensioni che sembrano attraversare le tradizioni buddhiste (non meno di tutte le altre grandi tradizioni dell’umanità), sia a una considerazione attenta delle peculiarità degli sviluppi del buddhismo a livello globale e nella cultura occidentale: che ne dici?
Certamente parte del problema si trova nelle rappresentazioni con cui il buddhismo è stato veicolato in passato e in parte continua ancora a esserlo, per questioni anche molto diverse, a volte anche commerciali. Ad esempio, per l’autore di una serie di libri sul buddhismo o sulla “sapienza orientale”, non sfidare la mentalità dei suoi lettori di riferimento significa poter contare su un pubblico affezionato, che comprerà più facilmente quel libro. La cultura è spesso determinata da queste logiche commerciali e il buddhismo è stato spesso reificato, ad esempio in un metodo di auto-aiuto, soggetto alle regole e alle logiche del mercato. Nel caso specifico che hai ricordato, un’idea genericamente e astrattamente pacifista del buddhismo, che diventa una specie di pregiudizio positivo, è più un problema che un’opportunità, anche se di fatto è abbastanza diffusa e all’inizio sembra facilitarne la recezione. Nei fatti, è facile finire con l’ignorare le ambiguità che i buddhisti hanno manifestato nel corso della storia, in modi simili a pressoché ogni altra tradizione dell’umanità. Da più parti durante il convegno si sono ad esempio ricordati i casi di monaci che hanno sostenuto regimi totalitari, come nel Giappone del secolo scorso fra le due guerre mondiali, o in un contesto contemporaneo le figure di quei monaci che incitano all’odio interreligioso o interculturale. Il pregiudizio di pensare che il buddhismo sia intrinsecamente pacifista nasce forse da una speranza inconfessata, che rappresenta però un pericolo in sé: quello di pensare che esistano “porti sicuri” del pensiero, luoghi in cui la violenza sia di per sé esclusa. A volte si pensa inconsciamente che sia possibile escogitare un ragionamento talmente perfetto da metterci al riparo da qualsiasi pulsione aggressiva. Purtroppo, sistemi di pensiero o di comportamento del genere non esistono ed essere, anche inconsciamente, convinti della loro esistenza ci fa abbassare la guardia rispetto alle derive violente. Nulla ci può mettere automaticamente al riparo da un uso violento del pensiero: anche il sistema di pensiero più critico e consapevole si può trasformare in un appiglio per un attaccamento. A ben vedere, il presupposto del porto sicuro dà per scontato che ciò che dobbiamo trovare sia un oggetto perfetto di pensiero, un prodotto reificato del nostro sforzo mentale. Questo oggetto mentale ci consentirebbe, pensiamo, di risolvere molti problemi, forse perfino la radice dei problemi. Ma questa è un’illusione, perché il vero problema (e quindi la soluzione, peraltro provvisoria) non si può trovare a livello di oggetti mentali reificati, in un sistema, una formula, un’ortodossia, un credo, ma nell’attività della mente. È l’atteggiamento mentale che ci porta ad attribuire un’importanza quasi magica alle costruzioni mentali, con cui pensiamo di poter sistemare tutto. Certo, all’inizio alcune di queste elaborazioni possono aiutarci ad aprire gli occhi, ma molto facilmente possono anche diventare strutture per ingabbiare la realtà. In alcune sue forme, il buddhismo combatte proprio questo tipo di tendenze, ma non può considerarsi al riparo dal diventare a sua volta fonte di ulteriori costruzioni reificate, di altri feticci mentali. Ed è a quel punto che un’apertura a diverse discipline e linguaggi (ad esempio, la storia) può essere utile per accorgersi dei pericoli. Il lavoro intellettuale è un’occasione per diventare coscienti della forza di questi feticci mentali. Essere coscienti del rischio intrinseco nelle teorie di forzare la realtà in senso dogmatico ed essenzialista può essere un’opportunità per praticare una disciplina critica (la visione è una delle pratiche fondamentali del Nobile Ottuplice Sentiero) che permette (purtroppo, senza mai certezza) di sfuggire alle costruzioni che diventano fonte di attaccamento. In questo, trovo un’oggettiva convergenza con l’esperienza filosofica tardo-antica, evidenziata in modi diversi da Pierre Hadot e Michel Foucault.
- In questo genere di riflessioni, la filologia penso sia indispensabile, e a mio avviso può di certo offrire validi strumenti di consapevolezza per evitare di ridurre a inerti stereotipi esperienze spirituali potenzialmente feconde; ma non corre essa stessa il rischio, talora, di trasformarsi a sua volta in un atteggiamento dogmatico, ossia in una forma di feticismo? In altri termini, se è certo utile, e anzi direi indispensabile, per difendersi dalle utilizzazioni corrive, commerciali, consumiste e narcisistiche delle “spiritualità orientali”, qualora la si estremizzi non può forse rischiare a sua volta di precludersi la comprensione di fenomeni profondi, quali ad esempio le autentiche esigenze di spiritualità della beat generation?
Sono d’accordo. E come la filologia, penso anche alla filosofia, alla storia, alla sociologia, all’antropologia. Ciascuna di queste discipline ha oggetti di indagine propri e può rappresentare grandi opportunità per sviluppare una coscienza acuta dei problemi a cui una ricerca intellettuale impegnata è chiamata a rispondere. Ma c’è sempre il rischio opposto: quello di sterilizzare le esigenze più profonde della ricerca spirituale con una critica a sua volta reificata e finalizzata a se stessa. Questo accade quando non è chiaro che il problema principale sta nella disposizione mentale con cui si attua una critica, più che nel contenuto del pensiero in sé. Questo è il punto davvero problematico al di là delle singole costruzioni mentali, siano esse forme religiose o studi accademici. Questa intuizione fondamentale, a mio parere, è uno dei maggiori punti di interesse di quell’insieme assai vasto di testi buddhisti chiamati della “perfezione della sapienza”, ripresi da Nāgārjuna e dai suoi continuatori nella corrente Madhyamaka. La vacuità (śūnyatā in sanscrito, kong in cinese e kū in giapponese) come concetto filosofico che emerge da queste fonti può essere colta appieno solo in relazione con la necessità etica e insieme epistemica di evitare l’attaccamento. In questo senso, la vacuità può rappresentare una medicina, ma questo non ne elimina il rischio di un uso feticistico. A volte infatti nella storia anche recente la vacuità è diventata una bandiera attorno a cui raggruppare interessi e identità culturali o religiose. Ad esempio, alcuni filosofi giapponesi moderni hanno potuto sostenere che in opposizione all’Occidente come luogo dell’Essere, l’Oriente era il luogo del Nulla, laddove questo “Nulla” era una ripresa moderna dell’idea buddhista di vacuità. Contro il rischio di queste vere e proprie perversioni ontologico-culturali, oggi è necessario insistere sulle implicazioni insieme epistemiche ed etiche della vacuità. Le straordinarie riflessioni della scuola Madhyamaka dovrebbero diventare parte di un’etica (rigorosamente autopromossa) dello studio e della ricerca: anche gli studiosi sono esseri umani e come tali devono porsi il problema dei rischi che la loro opera ceda a forme di feticismo categoriale, che trasforma gli strumenti di indagine e le procedure usate nella loro professione in strumenti da usare nella guerra delle idee. Tutti gli strumenti intellettuali (dottrina buddhista compresa) sono come dei farmaci: vanno usati con criterio e in modo pragmatico, calcolando il rapporto fra costi e benefici, perché hanno lo scopo di liberare l’essere umano dall’attaccamento, ma possono provocare effetti collaterali. Non sono assoluti, non sono una panacea e, come ci ricorda la parola greca (phàrmakon) da cui arriva la loro etimologia, a seconda delle loro condizioni di uso, possono essere medicina o veleno, come ricorda anche il Platone di Derrida. Non a caso, svariati testi buddhisti ricordano che la vacuità non è adatta a chi è portato a vedere il mondo in modo negativo e pessimistico, perché lo spingerebbe a peggiorare il suo male. In generale, se si ipotizza un’etica del conoscere e del guardare per tutti i ricercatori anche non buddhisti, è di enorme interesse un’etica della vacuità, ossia la consapevolezza che ogni teoria è un’illusione, ossia una distorsione della realtà che rischia di sclerotizzarsi in un’ideologia. Questa consapevolezza non dovrebbe essere solo generica, ma puntuale e andrebbe di volta in volta riferita alle specifiche condizioni e problematiche delle discipline e dei temi trattati.
- L’insegnamento del Buddha può essere interpretato come istanza di emancipazione da ogni forma di attaccamento, ossia come radicale istanza critica? Se capisco bene, mi pare sia questa la domanda cruciale che tu poni nel tuo intervento: ce ne vuoi parlare?
Quella di vedere il messaggio buddhista come emancipazione dall’ideologia è una sfida importante per il Buddhismo contemporaneo, una sfida che può essere raccolta a partire da numerosi testi e pratiche che costellano la storia del Buddhismo. Oggi c’è un bisogno urgente di rispondere alle nuove e vecchie forme di essenzialismo, inteso come tendenza a costruire essenze, identità fisse e immutabili, che si possono esprimere sotto forma di nazionalismi e di posizioni che inneggiano a scontri fra civiltà o culture. Penso che oggi questa sia una vera emergenza intellettuale. Contro tali essenzialismi che contribuiscono ad eliminare il dissenso in vari paesi non democratici del mondo e che rischiano di trascinarci in uno stato di conflitto generalizzato, è necessario smascherare e disinnescare ogni discorso che costruisca identità ideologizzate. Da questa prospettiva, il Buddhismo può offrire una raffinata consapevolezza critica. Tuttavia, questo non è un processo semplice né automatico: il primo passo in questa direzione consiste nel confrontarsi in modo adeguato con i problemi del nostro tempo da parte del mondo buddhista. E fare questo vuol dire prendere coscienza di come finora i rapporti con la modernità siano stati sviluppati. Prendiamo l’esempio della Scuola di Kyoto di Nishida Kitarō, Tanabe Hajime e Nishitani Keiji, membri di una delle prime correnti moderne ad autodefinirsi vicina al buddhismo. La mia tesi è che in molti casi questi pensatori, soprattutto prima del 1945, abbiano interpretato in modo riduttivo la modernità, pensandola come se fosse identificabile con una sola cultura (l’occidente) e legandone il contenuto al problema dell’individualismo e del Soggetto. Con questa lettura tuttavia hanno colto solo in parte l’insieme dei problemi che la modernità fa emergere e non sono riusciti ad esprimere adeguatamente il potenziale critico della filosofia buddhista. Infatti, è certamente vero che il tema del Soggetto è fondamentale per lo sviluppo del pensiero moderno e che la modernità in Giappone come in altri paesi è stata almeno inizialmente anche un’occidentalizzazione, ma la portata dei fattori messi in gioco nella modernità è tale che ridurla a una categoria geografico-culturale è inadeguato e fuorviante, e peraltro ripete specularmente quanto gli stessi europei hanno spesso sostenuto nel loro eurocentrismo. Dopo il 1945, Nishitani Keiji correggerà la sua posizione su questo punto specifico, ammettendo che la modernità (in quanto nichilismo) sia un fattore fondamentale anche in Giappone. E tuttavia continuerà a leggere il nichilismo in termini di soggettività, di fatto ignorando o sottovalutando almeno un’altra identità che risulta imprescindibile nel mondo moderno: la nazione e i nazionalismi. Ecco, una lettura attenta della filosofia buddhista può rivelare invece quanto la coscienza della pericolosità delle identità essenzializzate (tutte le identità rigide, non solo quella del Soggetto) possa costituire un apporto fondamentale a una riflessione critica sul nostro tempo.
———————————————-
Matteo Cestari insegna Studi culturali e Religioni e filosofie dell’Asia Orientale presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino. Dopo essersi occupato a lungo di filosofia giapponese moderna, in particolare della Scuola di Kyoto, ha allargato il campo di indagine a comprendere la questione della modernità da una prospettiva di buddhismo critico. Su questo argomento è imminente la pubblicazione di un suo libro.