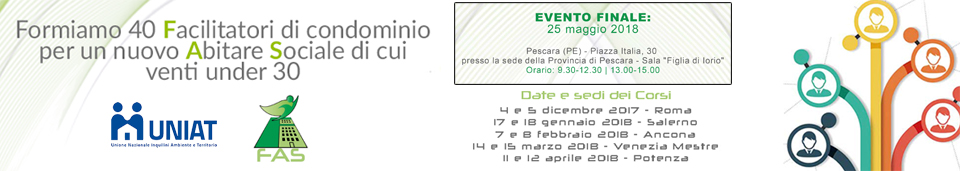Widgetized Section
Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone
“La Cina al centro”: intervista a Maurizio Scarpari di Antonio Francesco Di Lauro
(in collaborazione con www.inchiestaonline.it)

*
Al centro del tavolo siede il segretario generale, noto ai molti come il Presidente-di-tutti. È affiancato da Hu Jintao, suo predecessore, e dal premier in carica Li Keqiang. Attorno a loro si dispongono le più alte gerarchie in seno al Partito.
Ospitati dalla Grande Sala del popolo, rivolti verso il palco su cui poggia il prestigioso tavolo, ci sono per l’esattezza 2296 delegati del Partito a fare le veci degli oltre 97 milioni di iscritti.
Il XX Congresso del Partito Comunista cinese testimonia quanto di fatto dal governo nel quinquennio appena volto al termine e sebbene interessi le sorti di quasi un miliardo e mezzo di cittadini, si svolge quasi interamente a porte chiuse. La fase delle nomine è la sola nella quale è consentito ai giornalisti assistere e rappresenta il momento clou del Congresso, in cui viene rivelato il nome del nuovo segretario primus inter pares, con i 25 membri del suo Ufficio politico.
Xi Jinping è reduce di due mandati e la legge, prima del suo emendamento costituzionale escogitato ad hoc, gli impedirebbe di ricoprire nuovamente la carica di segretario generale.
Com’è di facile intuizione, a quel punto nulla potè più interporsi fra lui e il suo obiettivo.
Era l’ottobre del 2022 e il Presidente-di-tutti cominciava ufficialmente il suo terzo mandato.
L’esito di quel Congresso simboleggiava il coronamento di una linea politica divenuta sempre più autoritaria e accentratrice durata per dieci anni e, naturalmente, del suo insostituibile leader.
La vittoria di Xi Jinping non destò grande scalpore. Tuttavia a sbalordire ci pensò uno dei due uomini seduti proprio accanto a lui, Hu Jintao, protagonista di un fatto senza precedenti. Mancava poco alla proclamazione dei membri del nuovo Ufficio Politico, quando la stampa riprese in maniera tempestiva due uomini portare via di peso dalla sala l’ex numero uno cinese, visibilmente scosso e agitato per via di qualcosa di ignoto.
Era in atto un broglio elettorale, volto ad imporre la nomina dei soli dirigenti designati da Xi Jinping per l’esecutivo, a scapito delle altre correnti politiche interne. Broglio a cui l’ex segretario generale tentò vanamente di ribellarsi.
Le immagini e i video che ripresero il suo divincolarsi da chi voleva tacitarlo, davanti all’impassibilità del segretario generale e all’indifferenza del suo Partito, fecero il giro del mondo, come a denunciare una condizione radicalizzata al punto da non poter restare più celata.
L’episodio, di cui si è scritto e parlato molto, va contestualizzato in una trama densa di eventi, noti e meno noti, che connotano la realtà cinese. Nel volume La Cina al centro. Ideologia imperiale e disordine mondiale, edito da Il Mulino, la rigorosa analisi di ambizioni egemoniche mai sopite e dei tratti totalitari del regime, partecipi di continui rimandi fra il presente e il passato più antico, restituisce una lucida e schietta rappresentazione della situazione in tutta la sua complessità.
Il suo autore, Maurizio Scarpari, ha insegnato Lingua cinese classica all’Università Ca’ Foscari dal 1977 al 2011. Noto sinologo italiano, si dedica a tempo pieno allo studio della lingua, della storia e del pensiero filosofico della Cina antica e alla loro incidenza sul pensiero politico attuale.
Ripartiamo da qui. L’uscita di scena forzata di Hu Jintao dal XX Congresso del Partito è un’immagine visivamente potente, oltre che significativa, tanto da definirla nel tuo libro “un’epurazione in stile maoista”. È un paragone tutt’altro che casuale. Xi Zhongxun, padre di Xi Jinping, fu vittima di una delle destituzioni cui fai riferimento. In che momento si colloca questo evento e come avrebbe impattato sulla vita e sulla carriera politica dell’attuale leader?
Xi Jinping era figlio di un noto comandante militare comunista e pertanto visse la sua infanzia e parte della sua adolescenza in un contesto ricco di privilegi, insieme ad altri giovani, anch’essi figli di importanti combattenti rivoluzionari. In seguito allo scoppio della Rivoluzione Culturale voluta da Mao, la sua situazione personale subì un brusco mutamento. I suoi genitori caddero in disgrazia e furono condannati all’ergastolo, mentre lui e altre migliaia di giovani “principini” furono confinati in sperduti villaggi di campagna per ricevere un’educazione improntata ai valori della rivoluzione. Fu un momento particolarmente difficile della sua vita poiché non aveva alcuna dimestichezza con il mondo rurale, dove le persone della sua estrazione erano spesso viste con una certa diffidenza. Tuttavia trasse importanti benefici da quella situazione, facendosi benvolere dai contadini sino a farsi nominare responsabile della cellula di partito locale.
A queste vicende e alla loro riscrittura in chiave eroica Xi deve la sua reputazione di “imperatore contadino”. I luoghi della sua rieducazione giovanile sono divenuti oggi meta di pellegrinaggio per molti cinesi.
Nonostante non avesse un titolo di studio adeguato, riuscì comunque a iscriversi all’università, che completò nel 1979, e a conseguire un dottorato di ricerca a 22 anni di distanza dalla laurea, quando ormai aveva 48 anni e la sua carriera politica era già in pieno corso. Fattori che suscitarono dubbi e insinuazioni malevole tra i suoi detrattori.
Attraverso un lungo percorso fatto di luci e ombre, Xi Jinping seppe costruire la propria immagine di politico erudito e preparato, mai altezzoso, che seppe stare sempre vicino al popolo.
Almeno in teoria, il leader de facto della Repubblica Popolare non ha mai perso di vista il legame con il suo popolo, intercettandone l’importanza strategica fin dagli albori della sua carriera. Da dove proviene questa forte immagine di centralità del popolo cinese?
La tendenza volta a considerare il popolo l’elemento chiave del buon governo affonda le sue radici in Cina fin da prima dell’era imperiale. È un principio che viene generalmente attribuito al confucianesimo anche se, a dire il vero, si rifà a una tradizione ancor più antica, secondo la quale l’arte del buon governo viene praticata dal sovrano illuminato che ha come obiettivo primario provvedere al benessere materiale e spirituale del suo popolo. In particolare, la dottrina del popolo come fondamento della buona politica ebbe un forte impulso durante il periodo della dinastia Han, succeduta alla dinastia Qin alla fine del III secolo a.C. circa.
Fu allora che il confucianesimo assurse a ideologia dominante, coniugando in sé le due maggiori correnti interpretative dell’insegnamento di Confucio – il pensiero idealista, che predica l’innalzamento morale e spirituale della persona e del popolo teorizzato da Mencio, e quello pragmatico e autoritario teorizzato da Xunzi – con le dottrine dei teorici dello stato centralizzato e autocratico promosse dai cosiddetti “legisti” (Shang Yang e Hanfeizi principalmente) e le teorie di strategia militare (Sunzi in particolare).
Con Xi Jinping l’etica confuciana ritorna in auge con il suo idealismo e forse ancor di più con il suo lato autoritario. Tenendo conto dell’ambivalenza di significato evidenziata, oggi si può parlare di confucianesimo funzionale a una politica di tipo autocratico?
Sì, anche se la pratica, al contrario della teoria, non ha forse mai conosciuto una netta separazione delle due correnti di pensiero. Per intenderci, sono stati ritrovati e analizzati i codici appartenenti all’epoca Qin, ricordata dalla tradizione confuciana come un periodo di tirannia fondato sulla rigida applicazione dei principi “legisti” e di un articolato sistema di punizioni e ricompense. Confrontandoli con i codici di epoca Han, si è visto che le differenze non erano poi così marcate.
Le pratiche autoritarie sono state demonizzate dai confuciani e dai sovrani cinesi in favore di un presunto approccio idealista che, semplicemente, ha consentito loro di continuare, nella pratica di governo, a comportarsi velatamente da despoti. Fenomeno noto come “apertamente confuciano, segretamente legista” (yang ru yin fa) o “mascherare il legismo con il miglior confucianesimo” (rubiao yu fali).
Si creò così un modello di governo e una concezione dell’ordine internazionale nuovi, sintesi tra idealismo e autoritarismo, che diedero forma stabile allo stato autocratico di stampo legista ammorbidendone gli aspetti più aspri con il ricorso ai valori e ai principi del confucianesimo idealista classico. Un modello che venne ripreso più volte nel corso della storia imperiale cinese; credo sia ciò a cui stiamo assistendo anche oggi nella Cina di Xi Jinping.
Riportare la Cina al centro degli equilibri mondiali è il principale obiettivo politico da ben prima dell’ insediamento di Xi Jinping, sebbene Pechino sia stata abile nel mascherare le sue reali intenzioni sino ai tempi più recenti. Oggigiorno la possibilità che ciò si realizzi non appare più così remota. Di fatto ci si chiede: di fronte alla scaltrezza cinese come hanno reagito i nostri governi?
A partire dagli anni Settanta e Ottanta, in Occidente andò affermandosi la convinzione, a dir poco semplicistica, secondo cui una stretta collaborazione commerciale con la Cina avrebbe favorito la democratizzazione del Paese, o quantomeno un attenuarsi delle asperità del suo regime. Questa speranza irrealistica viene descritta nel libro come «il grande abbaglio». L’esperto di relazioni internazionali J.J. Mearsheimer afferma che il liberalismo deve necessariamente confrontarsi con il nazionalismo e il realismo politico, che in genere prevalgono su di esso.
Tuttavia ciò che spinse le grandi potenze liberali a investire ingenti somme di denaro in Cina non fu soltanto l’idea di esportare la democrazia. L’Occidente vide nel mercato cinese la possibilità di approfittare di una manodopera a bassissimo costo, incurante di una mancata tutela dei principali diritti sindacali. La Cina fu trasformata nella “fabbrica del mondo” e la sua economia si sviluppò in modo vertiginoso, più di quanto chiunque in Occidente avrebbe potuto immaginare, al prezzo di un grave aumento dell’ingiustizia sociale e di tassi di inquinamento senza precedenti.
Ad ogni modo quando nel 2001 la Cina entrò nella WTO, l’economia cinese esplose. Le superpotenze che ne avevano favorito l’ascesa, gli Stati Uniti su tutti, capirono troppo tardi di aver perso irrevocabilmente il primato su vari settori di produzione. È in parte su questo che Donald Trump fondò la sua campagna elettorale nel 2016, vale a dire puntando alla pancia di quell’America che aveva perso molti posti di lavoro per via della “sleale” concorrenza cinese. E dico sleale poiché è risaputo che le regole della WTO non siano mai state pienamente rispettate dalla Cina. Il mutuo vantaggio potenzialmente derivante dalla globalizzazione non è mai rientrato nei piani cinesi, ma lo si è capito troppo tardi.
Se “l’equo vantaggio” è ridotto al pari di una formula mal rispettata e il rapporto di partnership con la Cina è proseguito speditamente, la beffa potrebbe risiedere nella narrazione, affidata al soft power cinese.
In effetti il rafforzamento del soft power è stato in assoluto una priorità per Xi Jinping, che ha individuato nella millenaria tradizione culturale del Paese una solida base su cui edificare il “potere discorsivo internazionale”. Ma non si è limitato alla sola retorica, avendo investito diversi miliardi nella costruzione di apposite infrastrutture sparse in giro per il mondo, come gli Istituti Confucio, che hanno permesso al governo cinese di infiltrarsi in numerose università estere.
Tuttavia il soft power cinese non ha attecchito in Occidente come sperato e i tentativi volti a incentivare un’espansione di tipo culturale non sono stati sufficienti a mascherare il reale interesse del Partito, rivolto più a un’espansione egemonica.
Poi altri meccanismi di potere hanno giocato un ruolo cruciale in tale direzione, come lo sharp power, un “potere oscuro e insidioso” che si basa su un potente sistema di disinformazione, e l’hard power.
A proposito di hard power, penso alla Nuova Via della Seta (BRI): l’imponente progetto che consentirebbe la creazione di una rete commerciale, politica e sociale di dimensioni planetarie con la Cina al suo centro.
Il tema è piuttosto caldo anche qui per via della singolare posizione da noi assunta rispetto al patto intercontinentale. L’Italia è stato il primo, nonché il solo, Paese del G7 ad aderirvi. Adesso è il primo in assoluto a rinunciarvi.
La Nuova Via della Seta simboleggia al meglio il tentativo di creazione di una «grande comunità dal destino condiviso» a trazione cinese. Sono oltre 150 i Paesi che hanno deciso di entrare a far parte della fitta rete di cooperazione, fra i quali ad esempio compare la quasi totalità degli Stati dell’intero continente africano. Ciò non sorprende particolarmente se si pensa alla BRI come a una reinterpretazione della globalizzazione, che a dispetto di quest’ultima promette di favorire la crescita di Paesi in via di sviluppo, per lungo tempo relegati ai margini del processo capitalistico. Anche in questo caso, però, la realtà dei fatti è ben diversa. I Paesi in via di sviluppo coinvolti nella grande manovra politica e commerciale hanno rischiato di peggiorare la propria condizione aderendovi. La ragione sta negli stringenti accordi stipulati con le aziende cinesi, che prevedono spesso clausole segrete che impongono, in caso di insolvenza nei pagamenti dei debiti contratti con le banche e le aziende cinesi, la cessione di materie prime, beni o infrastrutture o, persino, la sovranità, per periodi da definire, di aree strategiche per il raggiungimento degli obiettivi egemonici cinesi. Sono numerosi i Paesi che sono caduti in quella che tecnicamente viene definita “trappola del debito”. Alcuni, come lo Zambia e lo Sri Lanka, sono già andati in default.
Veniamo a noi. L’Italia ha sottoscritto il Memorandum sulla Nuova Via della Seta nel 2019. La decisione di aderire all’accordo è arrivata da una classe politica assolutamente impreparata ad affrontare una simile circostanza, che ha di fatto concesso un endorsement politico importante al governo cinese senza ottenere in cambio alcuna contropartita. Ricordo perfettamente il clima di totale disappunto da parte dell’Unione Europea e degli Stati Uniti, contrari alla stipula del Memorandum, mentre il premier Conte e il ministro Di Maio presentavano agli italiani l’accordo come un successo commerciale che avrebbe giovato alle esportazioni. In realtà i dati hanno confermato che quella firma non ha giovato alla nostra bilancia commerciale, anzi, semmai è vero l’esatto contrario. Sul piano politico ritengo sia stata un’operazione dannosa, seppur contenibile. La decisione dell’attuale governo di non rinnovare il Memorandum era doverosa.
Come dimostra la Nuova Via della Seta, Xi Jinping è fortemente intenzionato a ribaltare l’attuale ordine mondiale. Quali credi siano le maggiori sfide che la Cina dovrà affrontare per tentare di anteporsi sullo scacchiere internazionale?
La Cina si trova attualmente in grandi difficoltà, soprattutto interne. La politica zero-Covid, attuata per arginare la pandemia, si è rivelata disastrosa sotto ogni aspetto, costosissima per le casse dello Stato e dannosa per l’intera filiera produttiva e distributiva. Questi e altri problemi hanno causato tensioni, malumori e instabilità all’interno del Partito e nel Paese, tanto da far vacillare l’immagine positiva di Xi Jinping, attentamente e lungamente costruita, che pareva ormai consolidata, di leader efficiente e competente in grado di guidare la Cina della “nuova era” nel ruolo di indomabile comandante-in-capo, come la propaganda di partito l’aveva proposto nella dura battaglia contro il virus Covid-19.
In molti sostengono che il “miracolo cinese” si sia esaurito e che da questo momento in poi la Cina vivrà una lunga e difficile fase di assestamento economico e politico.
In politica estera gli obiettivi sono chiari e sono stati esplicitati pubblicamente più volte dallo stesso leader cinese: modificare gli attuali assetti internazionali in favore di un nuovo ordine globale più equo e tutto da costruire, su base multipolare, non più condizionato dalle democrazie liberali ma dalle maggiori autocrazie del pianeta come Cina, Russia e Iran. Dal peso politico, militare ed economico della Cina e dalla dipendenza che la gran parte dei Paesi antidemocratici ha, e sempre più avrà, nei confronti della Cina appare evidente che il nuovo ordine globale non potrà che essere a trazione cinese. Per ottenere questi obiettivi senza far scoppiare una guerra mondiale, si dovrà prevedere una lunga e complessa fase di transizione in cui a dominare saranno l’instabilità e il disordine, la cui conseguenza più diretta sarà l’incremento di conflitti e focolai di guerra.
Con gli Stati Uniti impegnati militarmente su più fronti, la questione di Taiwan si fa sempre più cruciale, alla luce delle continue dichiarazioni pubbliche, anche recenti, di Xi Jinping. L’intervento militare è un’opzione possibile e la reazione americana, stando alle dichiarazioni di Joe Biden, sicura. Ma il contesto geopolitico è destinato a mutare velocemente nel corso del 2024, visto il gran numero di elezioni previste, non ultime, in termini temporali ma anche di importanza, quelle americane, che potrebbero portare a scenari al momento inimmaginabili.
In un mondo polarizzato le nostre idee paiono volubili, rischiano costantemente di non conoscere più ragione e di confluire in ambigui meccanismi per cui sia facile giudicare un Paese democratico come uno antidemocratico e viceversa. Trovo significativa un’asserzione di Vittorio Emanuele Parsi che citi nel tuo libro, e che esorta a «sottolineare la natura irriducibilmente diversa dei regimi democratici rispetto a quelli autoritari per evitare di cadere in quella pericolosa omologazione che porta a mettere sullo stesso piano le ragioni dell’aggressore e dell’aggredito, quel ragionamento intellettualmente pigro ed eticamente cinico che confonde l’equilibrio di giudizio con l’equilibrio delle ragioni. […]»
Non c’è chiarezza su quali siano le priorità. Abbiamo considerato la democrazia un bene acquisito, l’abbiamo data per scontata, e abbiamo trascurato di dedicarle le attenzioni e le cure necessarie per farla funzionare al meglio, adattandola ai continui e spesso repentini cambiamenti. Per questo motivo il nostro sistema oggi vacilla e non funziona bene.
Nella dichiarazione di Parsi non viene esplicitato, ma il fondamento su cui si basa il libro dal quale ho estrapolato la citazione è tutto sommato semplice: seppur con le nostre contraddizioni, negli Stati democratici godiamo di un privilegio che gli altri non possiedono, e quel privilegio è la libertà, o meglio ancora, le libertà. Godiamo della nostra libertà personale e individuale, che forse non abbiamo protetto e curato a sufficienza, ma che esiste e ci appartiene. Ciò pare sfuggire a molte persone, sembra non essere chiaro che in ballo ci sia proprio questo. Sono questi i valori della nostra cultura e io ritengo, d’accordo con Parsi, che vengano prima di ogni altra cosa e che debbano essere difesi a ogni costo.