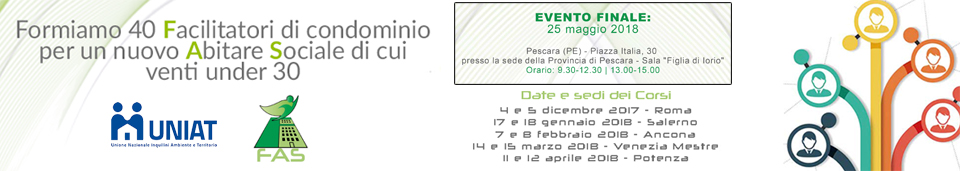Widgetized Section
Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone
Roberto Dall’Olio: “Il seme del fuoco”. Roberto Roversi, poesia come resistenza
di ROBERTO DALL’OLIO
(in collaborazione con www.inchiestaonline.it)

*
Roberto Dall’Olio
IL “SEME DEL FUOCO”: ROBERTO ROVERSI, POESIA COME RESISTENZA
“DOPO CAMPOFORMIO”
<<Scomparvero nelle piramidi di fuoco.
Quel tempo sporcò di melma le mani
dei sopravvissuti, dai gelidi cancelli
precipitarono ancora ancora
le mandrie nei macelli –
belare straziava la lama dei coltelli
in mano ai giovani carnefici.
Non è questo che voglio: ricordare.
No ritornare a quei lontani
anni, a quei tempi lontani.
I cani erano più felici degli uomini.
I miei versi sono fogli gettati
sopra la terra dei morti.
E’ oggi che dobbiamo contrastare>>.[1]
Questo passo celebre è tratto dall’opera di Roberto Roversi DOPO CAMPOFORMIO. Si possono cogliere i momenti centrali della poetica dell’intellettuale bolognese. La poesia come mezzo di contrasto nei confronti della realtà alienata, ma anche di lettura della realtà stratificata di quegli anni, dei tempi cui risalgono le poesie di Dopo Campoformio. La necessità, ma al tempo stesso la libertà di ricordare. Il contrasto tra memoria e azione, tra ricordare e contrastare, tra ieri e oggi. Il dolore che non passa né può passare della memoria dei lager :
<<mai fu così prossima la fine.
Non ha più senso toccare le pietre,
l’attesa, il turbine, la tempesta
spezzano non foglie morte ma le cime
degli alberi, la terra;
è troppo tardi.>>.[2]
La poesia come resistenza, come dovere inappuntabile di resistere ad una realtà che , ancora una volta, delude ed è pronta a deludere qualora si abbassi la guardia. Ma la poesia sta vivendo per Roversi una nuova ed estrema situazione di difficoltà, silenziata o resa inoffensiva dall’industria culturale di massa, in tempi veramente cupi, duri, schematici che non ci hanno emancipato da quegli altri tempi in cui “i cani erano più felici degli uomini”. E ancora la volontà di non gettare la memoria dei morti, le risonanze della guerra terribile che si era combattuta sul suolo d’Italia, nel Vecchio continente. Nel mondo. Furono quelli dei Cinquanta gli anni in cui il poeta raggiunse la sua piena maturità un suo stile inconfondibile e personale dentro ad una concezione alta, in senso etico, e precisa della poesia elaborata a partire, come si diceva dianzi, dalla metà degli anni Cinquanta nell’ambito di un discorso “strutturale” e strategico emerso anche all’interno della rivista “Officina”. Essa condusse: << una battaglia su due fronti: da un lato sottopone a revisione la tradizione ermetico – novecentesca e la connessa concezione dell’uomo e dell’artista, dall’altro sottolineò i limiti di “un facile impegno, incanalato in rigidi schematismi e incapace di costituire un’alternativa accettabile”(M. Marchi). Da qui il rifiuto del neorealismo e delle posizioni ideologiche che lo avevano sostenuto>>.[3]
Officina godeva di una convergenza, tra gli altri, di tre poeti di antica e liceale frequentazione: Leonetti, Pasolini e Roversi, i quali furono anche compagni di classe, appunto, al Liceo Classico Galvani di Bologna. Certamente poi la vita e le sorti personali dei tre autori li portarono in luoghi diversi, ma tra loro vi fu sempre una certa vicinanza e una sostanziale affinità elettiva. Si può sicuramente sostenere che “Dopo Campoformio” fu la risposta di Roversi, quasi il completamento, a “Le Ceneri di Gramsci” di Pasolini. Entrambe le opere venivano a confrontarsi con il clima piuttosto chiuso e conformista degli anni Cinquanta sia in Italia sia nel mondo dominati dalle rigide contrapposizioni imposte dalla Guerra Fredda, dalla tragedia di Ungheria, le violenze neofasciste in Italia, il Maccartismo negli Usa, la sporca guerra di Algeria, e, a Bologna, portando il discorso sul locale, il confronto tra Dozza e Dossetti per il ruolo di sindaco, per citare alcuni eventi centrali di quegli anni dei quali Roversi ebbe a scrivere :
<<Mai anni peggiori
di questi che noi viviamo,
né stagione più vile
coprì di rossore la fronte asciutta italiana;
cadavere fulminato
giace essa riversa sull’erba di una trazzera.
Così la sera del nostro vivere umano
quando la morte sprofonda nel fuoco della gola
e resta poca gente sola,
a vegliare con gli occhi asciutti e a ricordare…[4]>>
Trovano qui spazio l’indignazione, la rabbia, la tenerezza virile del grande poeta emiliano che non esita a paragonare il Paese ad un cadavere fulminato mentre la morte sprofonda nel fuoco della gola. La metafora eraclitea del fuoco ritorna in più sensi ed è convulsamente, quanto lucidamente, dentro l’opera del grande maestro bolognese. Il fuoco che invera e distrugge, alcuni libera altri domina, il fuoco di una crisi culturale che non si vuole dire. Il fuoco che produce un seme, la poesia che arde sulla pagina del poeta, nella vita del poeta, un fuoco che non consuma, o meglio, consuma producendo. Il fuoco che urla dentro il vetro antiproiettile di una crisi storica, morale e civile che attanaglia il Paese nostro negli anni Cinquanta e inizio dei Sessanta.
<<Non si tratta di una crisi circoscritta al piano della prassi politica o della ideologia…ma di una crisi di più vasta proporzione culturale (è il cosiddetto “marxismo critico”) che investe anche la critica letteraria e la concezione dell’arte. Ossia: attraverso un intenso dibattito – pur se limitato agli addetti ai lavori – condotto soprattutto su riviste …si coglie…la volontà di tentare metodologie nuove>>[5].
Erano questi gli anni in cui si frantumò il sodalizio tra Sartre a Camus. Il primo filosovietico per scelta, il secondo fautore di un pensiero meridiano per vocazione. Un periodo contrassegnato dalla difficile ricostruzione, certamente caldeggiata a tutti i livelli, ma difficile; un periodo indurito da una globale resa dei conti tra le due grandi potenze e le loro antitesi potentemente dispiegate sul globo. USA e URSS e il mondo diviso. Furono gli anni in cui si spense la grande voce di Brecht, essenziale e imprescindibile riferimento per il gruppo di Officina. Come non risentire nei versi sopra riportati l’eco del passo di Brecht:
“Davvero, vivo in tempi bui!
La parola innocente è stolta. Una fronte distesa
vuol dire insensibilità. Chi ride,
la notizia atroce
non l’ha saputa ancora.
Voi che sarete emersi dai gorghi
dove fummo travolti
pensate
quando parlate delle nostre debolezze
anche ai tempi bui
cui voi siete scampati.
Ma voi, quando sarà venuta l’ora
che all’uomo un aiuto sia l’uomo,
pensate a noi
con indulgenza.”[6]
La lunga citazione dal drammaturgo di Augsburg mette in risalto l’affinità con i temi roversiani e pasoliniani. In particolare l’ossessione per il buio del presente e la luce, forse, del futuro. Appunto “coloro che verranno”. Il bisogno di ricordare. Ma ricordare chi o cosa e come? Ricordare i morti, fare sì che la luce dell’esperienza maturata e sofferta li illumini. Non che la loro storia illumini noi, ma che la nostra esperienza, la nostra elaborazione del vivere illumini loro e tutto ciò che con essi rivive in noi. Si tratta di un passaggio decisivo e fondamentale per ogni civiltà. E’ il delicatissimo momento della trasmissione culturale che ai nostri autori appare a un bivio, minacciata dai tetri quanto accecanti meccanismi dell’industria culturale di massa. Minacciata dall’oblio che, per Pasolini soprattutto, noi sentiamo nel profondo delle viscere, un buio caldeggiato e profuso dal “paterno stato traditore”, un buio che dal fascismo getta le sue ombre sinistre sulla fragile democrazia del Dopoguerra, o, per Roversi, del Dopo Campoformio, il buio di anni roventi buttati nel fuoco della gola, un fuoco senza frutto parafrasando ancora una volta Canetti. E’ quel buio accecante delle ruspe che costruiscono la Roma Nuova delle borgate pasoliniane, della meglio gioventù, quella steppa dell’essere dove il lupo si mostra come l’agnello sacrificale del progresso, dove la questione ecologica già bussa alle orecchie dei più attenti. Quella dimensione del sottoproletariato dei “ragazzi di vita” per i quali non c’è spazio nella Storia, nemmeno in un ordine nuovo come quello gramsciano. La figura di Gramsci è centrale sia per Roversi che , lapalissianamente, per Pasolini.
L’importanza del pensatore sardo è naturalmente immensa, come venne definito: “un monumento umano e letterario”. Anche fondamentale all’interno del mondo marxiano per la sua capacità, derivante dal suo genio e dalla intuizione di voler tracciare una via umanistica della prassi, di alleggerire ed elasticizzare il rapporto tra struttura e sovrastruttura, tra ordine economico e dimensione culturale, comprendendo come vi sia una sofferta osmosi tra le due dimensioni, non certo una riproposizione mascherata del classico dualismo cartesiano a rovescio. Gramsci cercò con lucido furore e limpida partigianeria di ripulire l’ontologia marxiana da ogni automatismo meccanicistico derivante soprattutto dalla tradizione positivista che si era mescolata al socialismo degli anni epici tra Otto e Novecento. <<…la struttura e le superstrutture formano un “blocco storico”>>[7]. Scriveva Gramsci nei Quaderni. Renato Zangheri ricordo faceva notare che Gramsci respingeva ogni rapporto deterministico tra struttura e soprastruttura, tra di esse non vi è un nesso semplice di causa ed effetto. C’è al contrario, una reciprocità necessaria, “reciprocità che è appunto il processo dialettico reale”.[8] In una simile impostazione quale ruolo assume l’arte? Quale il ruolo dell’artista, dell’intellettuale? Gramsci non intende l’arte, la poesia, quale pura arte di rispecchiamento, cosa che invece farà Lukacs nella sua Estetica concependo l’arte in senso ortodosso in chiave marxista come fotografia del mondo vero, non di quello apparente e illusorio dei romanzi borghesi. Gramsci vuole andare oltre. Negli anni durissimi del carcere matura l’idea, centrale nel suo pensiero, che l’arte porti con sì una matrice liberatoria e rivoluzionaria, che possa trascinare con sé popoli e genti, che possa cambiare un’anima se e quando non sia espressione di un’anima sola, di quella classica dell’intellettuale italiano, quanto orientata verso le masse. Occorre per Gramsci registrare che il mondo moderno è una noce spaccata dalla crisi che è nella sua stessa matrice. Ecco come Gramsci la legge:
<<L’aspetto della crisi moderna che viene lamentato come “ondata di materialismo” è collegato con ciò che si chiama “crisi d’autorità”. Se la classe dominante ha perduto il consenso, cioè non è più “dirigente”, ma unicamente “dominante” …ciò appunto significa che le grandi masse si sono staccate dalle ideologie tradizionali, non credono più a ciò in cui prima credevano, etc…>>.[9]
In questo disincanto delle masse l’arte, l’artista, l’intellettuale hanno avuto un ruolo funzionale. Ovvero? Quella di contribuire alla formazione di una coscienza sociale delle masse. La coscienza si forma dalla memoria di ciò che è stato per arrivare alla coscienza appunto di ciò che è e potrebbe in futuro diventare. Questa è la luce volta vero il passato, ma per un altro presente, E per farlo occorre nell’era contemporanea essere, l’intellettuale, costruttore di una via “nazionale” della Letteratura, non una funzione del potere universale – cattolico, ma di quello particolare e protestante, di formare o contribuire a farlo una coscienza nazionale. In questo l’Italia ha mancato. Il ruolo dei suoi intellettuali, seppure in alcuni non rari casi, giganti dello spirito umano, è stato quello di rafforzare con le loro opere encomiastiche, i poteri locali e frammentati, è stato quello di avere una funzione universale e non nazionale, cattolica e non protestante, trascurando il loro tempo. Essi hanno preferito dipingere la Donna piuttosto che le donne, l’Uomo piuttosto che gli uomini, la Vita piuttosto che le vite, la Morte piuttosto che le morti e così via. L’intellettuale per Gramsci, o meglio l’intellettuale nuovo, “organico”, non può essere ciò. Anzi ha il preciso compito di essere il contrario. Non è un oltreuomo o un superuomo ennesima versione dell’individuo eccezionale che da Platone in poi ha ossessionato la cultura dell’occidente. E’ forse, alla Lenin, l’avanguardia della rivoluzione culturale, colui o colei o coloro che sapranno mettere in risalto le contraddizioni dell’esistere e della prassi in costante divenire, movimento e trasformazione, sapendo che tra cultura alta e cultura popolare esiste ancora un solco e un muro. Guai ai muri guai ai solchi. Sapendo che il proletariato e le masse sono impedite o quasi all’accesso al mondo culturale “alto” e lo subiscono. Ne devono diventare protagonisti/e per una vera concezione umanistica della prassi.
<<Mi pare che il Rinascimento sia la fase culminate moderna della “funzione internazionale degli intellettuali italiani”, e che perciò esso non abbia avuto rispondenza nella coscienza nazionale che è stata dominata e continua ad essere dominata dalla Controriforma…E’ in fondo lo stesso fenomeno generale del trasformismo…scarsa aderenza delle classi al popolo…i giovani si avvicinano al popolo ; nelle crisi di svolta questi giovani ritornano alla loro classe ( così è avvenuto per i sindacalisti – nazionalisti e per i fascisti)>>.[10]
Così Pasolini:
“L’intelligenza non avrà mai peso, mai
nel giudizio di questa pubblica opinione.
Neppure sul sangue dei lager, tu otterrai
da uno dei milioni d’anime della nostra nazione,
un giudizio netto, interamente indignato:
irreale è ogni idea, irreale ogni passione, (…)
Io muoio, ed anche questo mi nuoce.” [11]
[…]
Straordinaria quanto attivante e ruggente, fragile e feconda debolezza, nudità cristica di Pasolini nel delineare un “carattere” degli Italiani, nello spreco, così profetico, della loro intelligenza. Nell’incapacità puerile e strutturale insieme di non addivenire mai ad un giudizio netto, nemmeno scrive il poeta, “sul sangue dei lager”. Nemmeno lì. Mai. Sempre e solo l’individuale saggezza che a nulla porta se non alla furbizia del qui ed ora, all’individualismo più sciocco e banale, all’indifferenza che ferisce tacendo.
Pasolini e Roversi si trovano dunque a misurarsi con la lezione di Gramsci in una situazione internazionale, come si diceva, segnata dai tristi fatti di Ungheria, dalla denuncia dei crimini di Stalin, dal maccartismo e dalla situazione del ritorno in auge del fascismo in Italia come denuncerà lo stesso Pasolini ne le ceneri di Gramsci. . Ma si devono misurare anche con le reticenze del PCI, le posizioni togliattiane e del partito comunista italiano. Con il superamento, soprattutto in Pasolini, del bipolarimo Est- Ovest, con la sua apertura verso il mondo altro, l’Africa in primis; e in Roversi con il suo interesse per la filosofia analitica, la dimensione del superamento dell’informale. In ogni caso resta centrale la questione del passato. Di coloro che diedero la vita per un altro mondo possibile. Dei morti, appunto. Per salvare la memoria e il suo grande dolore occorre una luce particolare. Solo così si potranno salvare i morti e non morire due volte. La luce risponde alla domanda del come ricordare e risponde alla feroce quanto inerme domanda di Pasolini ne “Le Ceneri di Gramsci”:
“lo scandalo del contraddirmi, dell’essere
con te e contro di te, con te nel cuore,
in luce, contro te nelle buie viscere;
…Ma io, con il cuore cosciente
di chi soltanto nella storia ha vita,
potrò mai più con pura passione operare
se so che la nostra storia è finita?“[12]
Centrale è qui, manco a dirlo, il rapporto con il pensiero e la figura di Gramsci. Pasolini si sente attraversato dallo scandalo della contraddizione. Afferma di essere con Gramsci nel cuore, ovvero dal punto di vista del sentimento, ma anche dell’esprit pascaliano de finesse. Cuore come pensiero, come affetto e legame, anche come ideologia nel senso pieno e vero del termine. Ma al tempo stesso nelle viscere, dentro la passione, Pasolini si scopre contro di lui. Poiché nel pensiero politico del grande rivoluzionario sardo non c’è posto per il sottoproletariato urbano italico o di qualsiasi altra città d’Europa, ma nemmeno per quel mondo extraeuropeo che la sporca guerra di Algeria stava mostrando con estrema spietatezza e verità. Per i “dannati della terra” citando Fanon non c’è posto nell’ideologia anche di Gramsci. Pasolini si sente vicino a loro, ha anticipato il grande tema, il grande problema della globalizzazione. Il problema della globalizzazione e della televisione, dei meccanismi della comunicazione di massa. I problemi connessi con la democrazia e tali ambiti. Tutto appare a Pasolini superato eppure resta quell’eterna vita che scopre nel finire dei giorni in quella Roma magistralmente descritta nei versi de Le ceneri di Gramsci. Pasolini sente di essere attraversato da un’altra contraddizione, quella tra storia e vita. Una contraddizione quasi dal sapore nietzscheano, tra vitalismo disperato e senso della tradizione, valore e valori estremi del passato. Pasolini stesso si dichiara figlio inchiodato alla tradizione. Solo in essa riposa e risiede il suo amore. Da questo punto di vista il laico Roversi è meno disperato, meno straziato del cattolico Pasolini. Roversi ha fatto la Resistenza, Pasolini ha subito la Resistenza. Morì infatti in un agguato fratricida durante la guerra di Liberazione Guido Pasolini il fratello maggiore di Pier Paolo. Roversi è ferocemente indignato, usa l’indignazione come chiave interpretativa di tutto l’essere andando oltre al chiaro disamore pavesiano. Anche Roversi è impegnato a modificare il ruolo dell’intellettuale, dell’artista, del poeta. E’ impegnato a pensare tale attività in una dimensione nuova, più intrecciata e “compromessa” alla e con la prassi. Ritengo che vi siano certe connessioni tra l’opera di Roversi in questi anni e quella della generazione degli arrabbiati in Gran Bretagna sempre negli anni Cinquanta. In particolare con “Ricorda con rabbia”, l’opera simbolo della generazione degli arrabbiati, di Osborne. Ma anche relazioni con Harold Pinter e il suo pacifismo attivo e arrabbiato.
<<GUERRA
guerra, guerra, guerra
il mostro giallo
la divoratrice di anime
e corpi.”
(Traduzione di Christian Raimo).[13]
La rabbia è una condizione fondamentale della poesia di Roversi. Lo è anche per un altro cofondatore di Officina e in quegli anni compagno di strada di Roversi, Francesco Leonetti, il quale poi sceglierà l’incrocio con la neoavanguardia del Gruppo ’63. Segue qui un passo da una lirica (1959) del poeta cosentino.
<<e si geme, si tace…
Immerso lasciami
in questo nulla,
tu non chiamarmi, non strapparmi il sonno;
il sonno che completa il giorno, offrendo
alla sconfitta
che soffriamo, silenzio.>>[14]
Qui la rabbia è dentro una dialettica positiva tra l’io e il pianeta, simile a quella di Roversi e della generazione degli arrabbiati inglesi. Ma quella rabbia roversiana ha un suo specifico timbro. Essa è, anche, dovuta a un tradimento. Per l’ex giacobino protagonista de Dopo Campoformio, è la rabbia dell’Italia svenduta, della rivoluzione tradita, del Risorgimento incompiuto, della Resistenza annacquata sporcata con la continuità palese tra repubblica e regime fascista almeno nelle persone con un ruolo importante nello stato e nella funzione pubblica appunto. La mancanza di una resa dei conti con il passato tormenta l’uomo e il poeta Roversi. Si pensi alla tragedia del Vajont, simbolo dell’incuria e della cieca dedizione al progresso.
E’ l’Italia delle cose eterne come diceva il grande Schifano, l’Italia che non riesce a congedarsi dal suo congedo parafrasando Adorno, non fa passare il suo passato. Che, freudianamente, ritorna e rituona. Fa male. Le scoperte contraddizioni del rapporto di sfruttamento tra il Nord e il Sud del paese, i disastri ambientali già in atto, la disattenzione criminale per l’ambiente e verso l’ambiente, le grandi opere “sviluppiste”, il silenzio dell’arte e della letteratura, il basso volo della politica. Sono alcuni dei grandi temi gramsciani.
Da questo punto di vista il rapporto con il pensiero gramsciano è da parte del poeta bolognese più lineare rispetto a quello del suo amico Pier Paolo Pasolini. Gramsci ha capito, secondo Roversi, alla perfezione quali sono le malattie dell’ Italia: il ruolo deleterio degli intellettuali, il trasformismo, “l’eternità” del problema Nord/Sud che sarà anche un problema mondiale e in questo Roversi e Pasolini convergono, oltre alla mancanza di una resa dei conti con il passato nero del fascismo , della dittatura nazifascista. Ma è anche una rabbia per la perdita di senso dell’identità e dei valori della civiltà contadina senza che la città degli anni Sessanta possa offrire un’alternativa seria e “progressiva”, anzi Roversi rivede riaffiorare potentemente la perdurante antitesi città / campagna basso continuo della storia d’Italia e d’Europa. Inoltre rabbia per lo sfruttamento deliberato e sconsiderato della natura, il prefigurarsi della questione ecologica così potente nei versi di pianura padana che qui si propongono:
<<il Po nasce da una costola
del Monviso incoronato dai venti.
II bigio monte sassoso
scarse vene possiede, ha un arido cuore,
ma sotto un’ombra sperduta
da meandri oscuri a canali
di misero contrabbando.
Dal silenzio e nell’oro
con un gemito a tutti sconosciuto
balza ogni giorno con testa di toro
e tocca le gazzelle ciminiere,
le baracche, le grotte,
i valloni delle tristi periferie
impalliditi all’ombra di alte
eriche quiete.
salutano il gelo delle fonti,
le nebbie, gli schianti
dei rami calpestati, lo sgomento
della brughiera nella galaverna.
Fra queste schiere, opposte
acque furenti, il grande fiume va:
nate dai laghi, sciabordanti tese
o sporche di melma, coi relitti
precipiti dai colli d’appennino,
nel silenzio di terre desolate
dove la gente italiana stenta.
Mela spaccata, la pianura
da monte a mare e preda del fiume
che ronfa nella spenta
bellezza della notte,
…le donne cariche di estati
imprecano ai vecchi tremolanti
nel sole, a vivere ostinati.
Scema la terra, l’acqua arriccia il pelo
in un brivido pieno di sterpaglia
mentre nubi s’ammassano al riparo
di cancellate e di torri;
1 carrelli sospesi ai fili lucidi
gocciano miele.>>[15].
La rabbia si diceva per la Resistenza tradita, ma anche l’amore per quella vicenda di grande riscatto etico dell’Italia:
<<Ricordate
ricordateci
noi che la libertà
l’abbiamo inseguita
camminando sul fuoco
noi falciati
sotto cieli violenti di guerra
Ricordateci
ricordate
braci accese sono le vostre vite
per la luce dei vostri pensieri
e per nuove speranze>>
Ecco la luce! A cosa serve la luce. Ricordare, ovvero la luce dei pensieri, per nuove speranze. Dentro una visione aperta e libera della vita per la quale uomini e donne come Roversi hanno combattuto, ma anche il richiamo a noi posteri, a coloro che sono venuti dopo di non dimenticare perché come scrisse Benjamin: <<Il dono di riattizzare nel passato la scintilla della speranza è presente solo in quello storico che è compenetrato dall’idea che neppure i morti saranno al sicuro da nemico, se vince. E questo nemico non ha smesso di vincere>>.[16]
E’ quel nemico che brechtianamente si trova ancora alla nostra testa. E’ il nemico che inquina la speranza, che le toglie il vento sotto le suole parafrasando Hoelderlin. Quel principio speranza così profondamente blochiano e benjaminiano. Messianico ma senza certezza di una meta. Roversi è con loro, si potrebbe definire, come lo stesso Piero Sraffa si autodefinì, “un comunista senza partito”. Consapevole che non esiste più un soggetto politico che possa incarnare la speranza e il suo inverarsi, ma che tale soggetto o meglio, tale pluralità di soggetti, vada continuamente cercata. Immer wieder di husserliana memoria. Il nemico è l’indifferenza e il sistema degli indifferenti, la logica dell’indifferenza e la pax commerciale che Roversi denuncerà più volte e magistralmente ne “La bomba di Hiroshima”. La falsa pace della guerra fredda, il nucleare che paventa l’autodistruttività umana, la distruzione dell’umanesimo più avanzato, la distruzione della natura, la mercificazione della vita sotto l’egida del capitalismo. Ed ecco ancora la limpida, accentuata, virile, sofferta voce di Roberto Roversi:
… poi è arrivato aprile
<<uno prendeva il fucile
saliva sulla montagna
e la montagna era lì che aspettava
un altro prendeva il fucile
andava per la pianura
anche la pianura aspettava
e non aveva pietà
nella città era fuoco
terribile rosso il tramonto
il fuoco bruciava le case
e non aveva pietà
giovani cadevano morti
fra l’erba senza colore
pendevano morti dai rami
spezzati come poveri cani
i mesi gli anni passavano
i giorni non davano tregua
un mitra stretto nel pugno
pianura montagna città
poi è arrivato un aprile
sangue di sole e di rose
come un vulcano che esplode
ha gridato libertà.>>[17]
Quello che importa, soprattutto per Roversi, credo, debba essere il fatto che la Resistenza non sia da individuare solo in quel frangente storico ben delimitato del Novecento italiano, ma sia una sorta di categoria dello spirito, che abbia la Resistenza una dimensione etica, una stoffa etica da indossare sempre nei momenti in cui si è chiamati alla responsabilità. In questo si riscontrano affinità con la grande opera di Alfonso Gatto dedicata alla Resistenza, La storia delle vittime, del 1966, con commossa dedica a Vittorini e con sottotitolo “Poesie della Resistenza”:
<<L’alba è già scesa sui capelli biondi
dei ragazzi che avanzano in cielo>>
e commemorando Eugenio Curiel:
<<da morto ci indicava
la grande strada della primavera>>.
<<…ne La storia delle vittime il principio “resistenziale”, si dilaterà più che mai, in un comporsi degli episodi vissuti dal poeta in prima persona con altri eventi. Qualcuno enorme, come l’esplosione atomica su Hiroshima, che moltiplicò a dismisura il numero delle “vittime”.[18].
Il valore unificante della Resistenza sta nella sua unicità, nel suo potere di riscatto morale, nel suo essere una conditio sine qua non della vita nazionale e repubblicana, nel divenire un cartello che indica la via, la luce di nuove speranze tratta dal fuoco di quegli anni terribili. Per questo ho preso a prestito il titolo da una parafrasi canettiana, il germe del fuoco, allo scopo di riassumere in un’immagine mobile la forma informale della poesia di Roversi, della sua opera.
In merito alla Resistenza alla quale Roversi prese parte, possiamo dire che a vent’anni, nel ’43, partecipò alla lotta di Liberazione in Piemonte e il marchio del fuoco rimase sempre, in senso ovviamente figurato, nella sua poesia. Egli fu un grandissimo intellettuale antifascista, per il quale l’antifascismo, radicato nella nostra Costituzione, è stato fondativo di tutta la sua opera e del suo essere un vero maestro. L’antifascismo di Roversi, che si coglie nell’estrema ricerca della libertà, nell’adesione all’ideale del socialismo, nella passione per la giustizia sociale, nella denuncia delle storture di una società spietata e consumista, nella critica di una politica non più all’altezza del suo compito, è stato la bussola che ha diretto la sua navigazione nel mare aperto della vita. Di Roversi ha scritto mirabilmente Franco Fortini, a proposito di “Dopo Campoformio”:
<<Apro qua e là questo libro, quasi esitando sulle ultime pagine dei poemetti, le più ardue, di una deliberata architettura post-informale; ritrovo versi, passi, che non si dimenticano. Se non è poesia questa. D’altronde, Roversi ha diritto ad altre parole che queste mie>>. [19]
Dal punto di vista della forma, della struttura, il Roversi in questa opera passa attraverso una matrice davvero post-informale, soprattutto nella parte finale, la più ardua, stilisticamente, dell’opera. Si tratta di un linguaggio fortemente stratificato, densissimo e bruciante, incalzante con un furore ritmico e umano che concede rare pause. Il lirismo di Roversi, che pure è tesissimo e commovente, così di stampo anche espressionista e lacerato quanto lacerante, si apre a delle dolcezze piane, con rime incastonate dentro il corpo del verso, con puntuale precisione (reminiscenza di Saba?!…) senza l’ausilio in genere di congiunzioni, con un uso limitato della punteggiatura, raro l’uso di pronomi che possano fungere da collegamento sintattico tra i versi, in quanto il loro vero tessuto è semantico. Tra segno e senso, Roversi propende per il secondo. Il non grande, apparentemente, interesse per l’aspetto formale si evince anche con la distanza esistente tra l’intellettuale bolognese, il gruppo di Officina soprattutto Pasolini, e il Gruppo ’63, la neoavanguardia, l’area anceschiana del Verri, così potentemente coinvolta in un’opera di destrutturazione del linguaggio della lirica tradizionale del primo Novecento. Obiettivi simili, ma metodi completamente diversi se non antagonisti tra Officina e il Verri. Per Roversi la questione della poesia moderna è legata ai contenuti. Non si deve tacere ciò di cui non si è mai parlato. Non interessa in primis come lo si dice, ma che cosa si dice del potente rimosso del secolo in atto e di quello prima e dei tempi ancora precedenti. Siccome di ciò è arduo parlare, è arduo scrivere, Roversi si accosta a quella architettura post informale di cui parlerà Fortini in merito, sapientemente costruita.
Fortini prosegue nell’analisi di Dopo Campoformio confermando la sua tesi che si tratta di un testo provocatoriamente post- informale con incursioni nel linguaggio parlato affidate alla voce narrativa del poema, quest’uomo vecchio e indurito dalla vita passata dentro alla scatola chiusa dello Stato della Chiesa, finzione storica che retrodata, l’attualità bruciante della critica roversiana al suo presente, ma, aggiunge il Fortini già deluso degli anni Ottanta, gli anni in cui ebbe a pubblicare i saggi ivi citati , : <<…Questa poesia di Roversi mi conferma che né per lui né per me c’è più saggezza.>>.[20]
D’altra parte donde veniva “la saggezza” se non dalla passione dell’ideologia? La passione è rimasta ma contorta, rovente, ritorta verso se stessi, incapace di trovare adeguata scarica nella Storia. Certamente non appare così evidente la perdita di senso del Pasolini de Le ceneri di Gramsci, ma appare comunque forte tale perdita. Ed essa procede col venire meno delle illusioni, quasi parafrasando il “revisionista Furet, con la presa di coscienza, “nel cuore”, che una “certa storia è finita”. Resta la personale, incrollabile fiducia nella speranza, in Roversi, lui così acclimatato in un certo sentire tedesco, quasi alla Bloch, quello del Principio Speranza beninteso, di affidarsi persino ai lacerti ella Storia. Ma quella perdita di senso, quella non più saggezza ruota attorno alla figura di Gramsci. Il vero basso continuo di questa jam session. Il nume tutelare e invero anche l’icona sorpassata, la ratio errabonda, rubando a Colli il titolo famoso dell’opera sua omonima, di una ideologia, quella socialista, in fortissima evidente crisi. Ma lo stesso Gramsci si chiuse negli ultimi suoi due anni in un misterioso e volutamente segreto silenzio conferito a Sraffa come testamento culturale, umano e letterario. Non una resa, no certamente no, ma la scavata ricerca di un’alternativa al predominio dell’industria di tutto e in tutto, l’industria totalitaria. Roversi reagì a tale senso della perdita uscendo dal mondo editoriale, dal lieto colle panoramico della poesia italiana, da quella che egli stesso definiva “una guerra per bande”, ridotta tale dal venire meno di un collante stilistico quanto ideale. Dall’emergere prepotente del narcisismo affermativo del sé al posto del noi, Anzi contro il noi, neppure l’io ma il sé. Così nascono le due grandi poesie di Dopo Campoformio, ovvero Le descrizioni in atto e L’Italia sepolta sotto la neve, quest’ultimo vero poema onnivoro degli ultimi trent’anni di poesia di Roberto Roversi.
L’amore per l’Italia e il disamore per l’Italia, la passione per la storia e la delusione verso di essa, l’amore per la Natura e il velenoso senso di stare per distruggerla attraversano tutta la poesia di Roversi.
L’ultima parola spetta credo al passo magistrale sulla bomba di Hiroshima:
“La bomba di Hiroshima
bruciò troncando le ultime parole.
L’ ossa calcinate
riverberano il cielo senza fiato.
L’erba per sempre ha il verde rovesciato,
l’albero ha il suo tronco congelato
per sempre, la natura scompare
per sempre, nell’orrore dell’uomo
dentro a un fuoco di morte
(…)
E qua è l’Italia, non si intende, tace,
si compiace di marmi, di pace
avventurosa, di orazioni ufficiali,
di preghiere che esorcizzano i mali.
Ma nel mondo le occasioni perdute
sono i sassi buttati dentro il mare;
(…)
Tutti i morti oramai dimenticati.
Il ventre della speranza è schiacciato
nella polvere da una spada antica;
anni interminabili senza amore,
inchiodano col fuoco alla fatica”.[21]
Il poeta mette il dito sulla piaga della guerra e della ben pasciuta pace, gonfia di retorica ufficiale e ufficializzata che non porta ad alcuna consapevolezza della storia e del proprio destino storico di un cittadino quanto della nazione sua e del mondo intero, della distruzione della natura in atto. . L’Italia che si accontenta e gode della sua pace apparente, attraversata da contrasti che anni dopo esploderanno in una conflittualità terroristica e sociale non affatto secondaria. Questa Italia, specchio del mondo, è ivi attaccata dal poeta, non per degradarla, abbatterla, o per malinteso pessimismo, anzi, al contrario, per “svegliarla”, col marchio del fuoco. Riecheggia qui il fuoco, riecheggia Eraclito con la sua polemica contro la polis e i “dormienti”. Ciò che è accaduto con i lager, con i gulag, con la bomba atomica può accadere di nuovo se non sapremo trovare l’antidoto morale, civile e politico infine culturale verso tale sfrenatezza autodistruttiva. Ritorna così la fatica del poeta. Ritorna la rabbia del poeta verso un tempo che non sente suo. Un tempo in cui, “inchiodato col fuoco alla fatica” non vuole smettere di agire, non vuole lasciare la barca/contesto con il suo testo. Dal quale emerge la nuda, aperta chirurgica rabbia data dal riconoscere che in definitiva, per l’Italia, e anche per molta parte dell’Europa, sono due i “Risorgimenti” traditi, quello dell’Ottocento e quello della Resistenza e dei partigiani.
…………………………………….
[1] Roberto Roversi, Dopo Campoformio, dal frontespizio, Einaudi, Torino, 1965
[2] Ibidem pag. 85
[3] Salvatore Guglielmino, Guida al Novecento, Principato Editore, Milano, 3a edizione 1978 , pag.378/1
[4] R.Roversi., op. Cit. Pag. 59
[5] S.Guglielmino, Guida al Novecento, Principato Editore, Milano, 3 edizione, 1978, pagg. 377,78/1
[6] Bertolt Brecht, “A coloro che verranno”, 1939.
[7] Antonio Gramsci, Le opere, a cura di Antonio A. Santucci, Editori Riuniti, Roma, 1997, pag. 263
[8] Antonio Gramsci, Le parole di, in Zangheri Renato, il blocco storico, in le parole di Antonio Gramsci in aa..vv, Editori Riuniti, Roma, pubblicazione con l’Unità anno 1990
[9] A..Gramsci, op. cit., pag 215
[10] A. Gramsci, op. cit., pp. 228,229
[11] Pier Paolo Pasolini, Da: “La Guinea”, Poesia in forma di rosa, in “Bestemmia”, volume primo, Garzanti, Milano 1993
[12] Pier Paolo Pasolini, Le poesie, Garzanti, Milano, 1976 ,pp. 73,74,80
[13] Harold Pinter, dal discorso sul Nobel a margine la poesia proposta
[14] Francesco Leonetti, Sopra una perduta estate, Poesie scelte 1942 – 2001, a cura di Aldo Nove, Editore No Reply s.r.l. 2008, pag. 32
[15] Roberto Roversi, Dopo Campoformio, Einaudi Torino, 1965 pp.
[16] Walter Benjamin, Sul concetto di storia, Einaudi, Torino, p. 27
[17] Roberto Roversi, A un amico molto giovane, in “dal 25 aprile in poi” a cura della Sovrintendenza scolastica di Trento a.s. 1995/6, pagg. 9-11
[18] Alfonso Gatto, Tutte le poesie, Milano Mondadori 2005, in Silvio Ramat, introduzione all’op. cit. pag. XXVI
[19] Franco Fortini, Saggi Italiani, 1, Garzanti, Milano, 1987, pag. 152
[20] Franco Fortini, op. cit. pag. 156
[21] Roberto Roversi, Dopo Campoformio, Einaudi , Torino, 1965, dalla sezione omonima