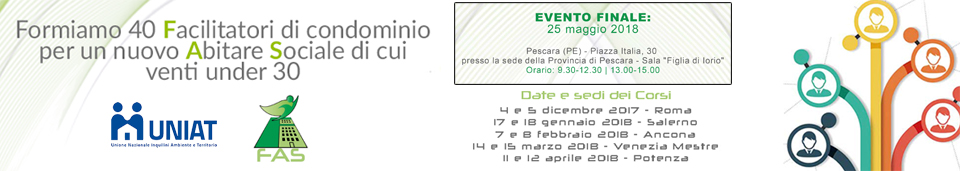Tommaso Furlan: Il Buddha tradito e la virtù esiliata

*
Il Buddha tradito e la virtù esiliata
di Tommaso Furlan
L’imperante modello emotivo-individualista che pervade le nostre vite si è impossessato anche degli insegnamenti del Buddha trascurandone la fondamentale dimensione etica. É utile proporre una breve riflessione per ritrovare il ruolo della virtù non solo come espressione incompresa del Dharma, ma anche come argine al moderno narcisismo e come manifestazione della nostra vera umanità.
Proviamo a osservare i social e quello che esprimono i media quali specchio implacabile dei nostri modi di essere e vivere. La maggior parte dei contenuti si incentra sulla capacità di emozionare, scuotere, stupire, esaltare l’ego, abbattere ogni presunto limite, soddisfare qualsiasi desiderio con facilità, immediatezza, rapidità e con l’obiettivo di dimostrarsi o anche solo apparire unici, superiori, privilegiati.
Non c’è da stupirsi perché questo modello di vita, imperante tanto in occidente quanto in oriente, fa leva su alcune caratteristiche umane: la reattività della mente, l’attaccamento, il confronto competitivo. Il problema è che al giorno d’oggi questo individualismo pervasivo è diventato l’unico modello di riferimento, ha assunto tratti narcisisti impregnati di superficiale emotività e pretende un diritto sotto forma di libertà senza limiti.
Così facendo però non si ottiene una vera felicità, ma la sua mistificazione drogata, ci si incammina lungo un sentiero dove delirio e frustrazione si solidificano in fragilità, incertezza, sofferenza, e ci si illude che il mondo emotivo tra adrenalina e lacrime sia il vero valore da perseguire.
Per secoli le emozioni, a volte chiamate passioni, sono state solo il paradigma della inaffidabilità e l’anticamera del peccato, un problema da rimuovere e ostracizzare.
Oggi, dopo il prezioso sdoganamento di matrice psicologica che ne ha dimostrato l’importanza, le emozioni sono salite sul trono del senso diventando un moltiplicatore simbolico che assegna valori e significati.
Nel sentire comune un’opera d’arte, un’esperienza, una relazione, per avere importanza deve emozionare, ma non nelle articolazioni di una preziosa intelligenza emotiva così ben spiegata da Daniel Goleman, bensì in un confuso scuotimento sempre più instabile che alla fine si sintetizza nel trionfo semplicistico del like, il “mi piace/non mi piace” consacrato nei social che appiattisce ogni sfumatura ed impedisce qualsiasi approfondimento critico.
Non è più nemmeno emozione, è emotività reattiva. Assieme all’individualismo e alla sue necessità di affermazione, crea una melassa narcisista che si appiccica ovunque fino alle più genuine esperienze spirituali.
Il consumismo materialista ha travolto molte espressioni religiose, ma non poteva spegnere quella componente di interiorità che in ognuno di noi cerca risposte e significati al di là del turbine quotidiano. La stessa parte fragile di ogni uomo da sempre si è affacciata Oltre per cercare una serenità e un senso che le cose del mondo non possono dare; oggi però quella melassa ha reso appiccicoso anche questo terreno e così sono diventati di moda i supermercati spirituali dove si entra, si compra a misura individuale o secondo l’umore quotidiano. Cosa è ricercato maggiormente? Un “prodotto spirituale” che garantisca serenità, benessere, senza toccare l’individualismo, un prodotto capace di emozionare, che non sia troppo impegnativo e che magari vada di moda per esibirlo sui social accodandosi al gregge o dimostrandosi dei privilegiati.
Così si mescolano un vago sentire di cuori commossi, mitologie salutiste, visioni ireniche nutrite di ecologismo, un’etica del sentimento senza solidarietà reale, panteismi improbabili, ingenuo pensiero positivo, corsi di crescita personale tenuti da guru influencer senza tradizione, fino alla famosa panacea invocata da tutti: l’amore universale.
Poi ritroviamo queste persone animate anche da buone intenzioni, incapaci di un gesto veramente solidale, di un impegno responsabile e continuo, di una relazione sincera; in molti fanno corsi di meditazione o di yoga come se fossero dei toccasana esteriori, ma senza pensare di dover trasformare prima di tutto le proprie abitudini mentali reattive interiori. Tutto quello che hanno comprato nel supermercato spirituale si rivela un botulino esistenziale che ha illuso il volto dell’anima gonfiando in modo innaturale incertezza, fragilità o peggio ancora rancore di fronte alla vita e agli altri.
In questo contesto l’assalto che viene fatto al Buddhismo è interessante da analizzare perché fa leva su una fraintesa interpretazione dell’invito del Buddha a una esperienza individuale, lontano dai dogmi, con una attività come la meditazione che oggettivamente offre da subito benessere, tutto molto attraente per l’ego.
Nella sua grande generosità ed efficacia il Dharma regala serenità fin dal primo approccio rispondendo alle ansie e alle fragilità del nostro tempo con un cambio di prospettiva, ma questo cambio se indica una via individuale, non la lascia prigioniera del soggettivismo, né dello psicologismo, anzi travolge l’ego che è ostacolo al cambiamento.
Quello che viene completamente, colposamente o dolosamente dimenticato è l’impegno etico che il sentiero del Buddha richiede, e da questa evidenza possiamo tornare al tema di partenza e vedere come proprio la virtù come espressione etica possa offrire una risposta proprio al narcisismo individualista.
Tutti conoscono il primo discorso del Buddha sulle quattro nobili verità. Parte dalla constatazione della nostra sofferenza che si sviluppa e si solidifica in esperienze sempre insoddisfacenti, impermanenti e poi ne individua la causa proprio nei nostri desideri e attaccamenti, fino a indicare una via d’uscita nell’ottuplice sentiero, via pratica individuale che chiede impegno, fiducia, coraggio, sforzo e non permette di essere selezionata a piacimento.
Invece accade che tutti sono interessati alla parte del sentiero detta samadhi, che parla di meditazione, calma, presenza, consapevolezza; accade che tutti vedono lontana la parte della saggezza detta panna accontentandosi del benessere psicologico; accade che tutti trascurano come un banale preambolo la parte detta sila che chiede una precisa moralità e indica come linee guida la retta parola, la retta azione, i retti mezzi di sostentamento.
Le tre parti del sentiero sono come tre gambe di uno sgabello: togliendone una tutto cade; sono un’armonia, non una scala, e alla fine c’è la liberazione che è il frutto del sentiero.
La necessità di una dimensione etica che si esprima in virtù è ribadita anche da tutti i discorsi successivi.
Nel canone Pali c’è un ampliamento delle prime linee guida, sono gli elenchi del Buddha: dieci perfezioni, cinque facoltà spirituali, sette fattori di risvaglio, cinque precetti e molto altro.
Leggendoli troviamo: fiducia, generosità, pazienza, rinuncia, saggezza, sincerità, gentilezza, risolutezza, gioia, quiete, attenzione, consapevolezza, calma concentrata, fino al vertice delle quattro dimore divine fondamentali per la mente: la gentilezza amorevole, la gioia compartecipe, la compassione, l’equanimità.
Ricollegandoci al primo discorso allora ci si deve chiedere come possa essere possibile prendersi cura della propria sofferenza se poi ne siamo causa in ragione del nostro comportamento senza etica.
Se non c’è moralità non può esserci né stabilità della mente né visione profonda, né liberazione; su questo il Buddha è chiaro.
Rileggendo gli elenchi si nota che le virtù a noi ben note sono presentate come facoltà al pari di quelle che consideriamo qualità psicologiche: il Buddha individua dei semi presenti in tutti in noi, non fa distinzioni cavillose sulla natura psicologica o etica, ma invita a coltivare i semi fondamentali per la vita e per la liberazione dalla sofferenza, e si concentra sulle intenzioni.
Coltivare le facoltà elencate poco sopra significa prima di tutto dimorare in stati mentali salutari, in intenzioni precise, e, al contrario, dimorare in stati mentali non salutari significa far crescere i semi delle emozioni distruttive come la rabbia, la paura e tutto quello che genera sofferenza, come ignoranza, attaccamento, avversione.
Possiamo definire l’etica buddhista intenzionale perché questo dimorare è un radicarsi, centrarsi, equilibrarsi e generare intenzioni andando alle “cose come sono” e quindi alla vita con un approccio virtuoso, presente e consapevole.
Se la mente dimora nella rabbia ogni approccio alle situazioni di vita sarà governato dalla rabbia, le intenzioni e le azioni daranno espressione a quella rabbia esplosiva o implosiva, e gli effetti probabilmente saranno molto dannosi per se stessi e per chi sta attorno. Se osserviamo la rabbia con presenza e gentilezza ci possiamo accorgere che è fatta di due componenti: avversione più energia. Diventa importante non reprimerla o fuggire per non accettarla, ma lavorare sulla avversione e tenere l’energia che può trasformarsi in indignazione o risolutezza virtuosa.
Se siamo radicati nella gentilezza il nostro approccio alle situazioni potrà essere più lucido, calmo, la mente sarà più intuitiva e anche se il problema oggettivo non cambia, cambia completamente il nostro approccio che potrà elaborare soluzioni non visibili ai circuiti distruttivi degli stati mentali non salutari.
É il meccanismo del karma: ogni azione produce un effetto che prima o poi raccoglieremo, non solo in negativo, ma anche nel merito.
Tutto ci riporta al ruolo dell’uomo nell’ordine delle cose non con privilegio antropocentrico, ma come collocazione responsabile fra Cielo e Terra, come insegna il pensiero cinese che coinvolgendo la natura ricuce quella apparente frattura con la cultura, con la normatività, rivelando due facce della stessa medaglia che esprimono il più profondo senso dell’essere umani.
Infatti incontriamo il grande insegnamento di Confucio, messaggio universale, senza tempo, oltre i dogmi religiosi divisivi, che pone 仁 (ren, il “senso dell’umanità”) a caposaldo del proprio magistero ribandendo la centralità della dimensione relazionale ed etica che assieme alla cultura ci caratterizza come esseri umani. Parallelamente incontriamo soprattutto nei testi di tradizione taoista l’idea della virtù come 德 (de) ovvero quella dimensione energetica, presenza naturale, esplicazione di una pienezza che ci richiama a noi stessi nella essenzialità dell’essere uomini con il nostro posto nell’ordine armonico delle cose. Simile in questo richiamo alla virtù energetica è quello che esprimeva anticamente il termine greco ἀρετή (areté), virtù riferita a tutte quelle qualità che ci fanno umani nella forza di essere noi stessi, di assolvere al nostro compito nelle situazioni di vita anche in termini eroici.
Anche il Buddha considera questo aspetto della virtù, nonostante che in pochi se ne accorgano. In quegli elenchi prima citati che arrivano direttamente dalle sue parole ricorre spesso virya, “energia”, ovvero quella facoltà virtuosa propria di ciascuno capace di sostenere lo sforzo, la risolutezza, l’azione.
Tutto ci fa capire che vivere virtuosamente da esseri umani non sembra proprio essere il restare ripiegati a guardarsi e a soddisfare la pancia, e nemmeno sembra essere il vivere una banale raccomandazione con quel retrogusto da sacrestia che ha offerto lo spazio alle critiche di Nietzsche sulla morale.
La virtù è forza per il nostro stesso bene; il Buddha in una sintesi folgorante dice: “Smetti di fare il male, coltiva il bene, purifica la mente-cuore. È questa la via del Risvegliato” (Dhammapada n. 183)
Diventa allora una scelta di campo quella di vivere virtuosamente e di impegnarci anche su un terreno etico, senza caricarci di un’ulteriore angoscia esistenziale, ma piuttosto con l’invito a guardare alla vita con fiducia.
Molti sottolineano come le diverse tradizioni spirituali convergano in numerosi aspetti della mistica, pochi sottolineano come le differenti culture possano ritrovarsi sul terreno della virtù: pur nella diversità delle credenze e delle tradizioni nessuno infatti nega l’importanza di essere solidali, generosi, di prendersi cura della sofferenza.
Essere spirituali, essere etici, virtuosi, essere pensanti significa essere umani; proprio la mancanza e il detrimento di queste dimensioni ci fa lentamente scivolare in un baratro che mai come al giorno d’oggi sfiora un punto di irreversibilità, mentre la preoccupazione nella quale siamo presi sembra essere solo quella di verifcare le notifiche sullo smartphone.
Non è in discussione il diritto e il dovere per di ciascuno di trovare realizzazione, espressione e felicità, ma è in gioco la possibilità di ottenerle anche attraverso la solidarietà, la condivisione, la responsabilità prima di tutto in pace con se stessi, perché chi è in pace con se stesso è in pace con il mondo. Come si può essere in pace con se stessi se la mente, le intenzioni, le azioni sono radicate in una dimensione distruttiva o dominate da superficialità e individualismo sfrenato ? Come si può chiedere giustizia, libertà, gentilezza se non si impara a essere giusti, gentili, a concedere libertà ?
Da dove iniziare? Possiamo sempre partire dai piccoli gesti, come diceva don Pino Puglisi, ucciso dalla mafia: “Se ognuno fa qualcosa si può fare molto”, ma inizia a farlo in te stesso/a adesso, non aspettare ancora, se sei troppo impigliato/a, incapace persino di ritrovare virya in te, prova a fermarti e a respirare. Prenditi il permesso di fermarti per essere presente e per osservare il cespuglio che ti imprigiona, e chiediti se stai vivendo o solo reagendo, se stai vivendo o se ti sei solo accodato/a a qualcuno, se stai vivendo o stai solo aspettando.
………………………..
Tommaso Furlan da anni è studioso di buddhismo, pensiero classico cinese, filosofia della mente, spiritualità interculturale. Con la pratica, con numerosi viaggi in Oriente e a contatto con maestri e monaci, ha sviluppato conoscenze e competenze nella meditazione, nelle arti del Dao, nelle medicine tradizionali. Insegna, tiene corsi, conferenze e seminari per aziende, enti pubblici e singole persone anche nella forma del coaching sportivo. Si è laureato all’Università di Padova prima in giurisprudenza con la ex Presidente del Senato prof.sa M.E. Alberti Casellati e poi in filosofia con i proff. G. Pasqualotto e A. Crisma.
Per contatti e approfondimenti : www.tommasofootball.it www.preferiscolorizzonte.it