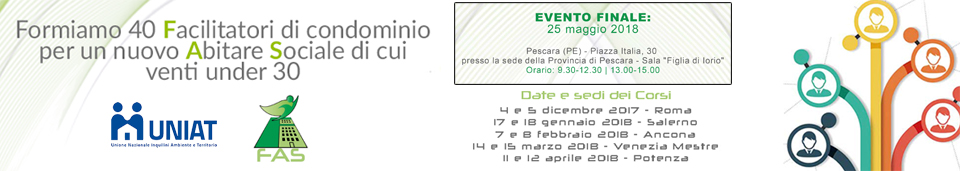(in collaborazione con www.inchiestaonline.it)
Widgetized Section
Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone
Giulio Laroni: Nell’era di Trump la sinistra riscopre l’umanismo

*
Pubblichiamo con il consenso dell’autore questo articolo di Giulio Laroni apparso sull’Avanti del 4 aprile.
Giulio Laroni
Nell’era di Trump la sinistra riscopre l’umanismo
L’egemonia delle nuove destre nel mondo sembra diventata inarrestabile. Con la sua linea di pensiero antiumanista e le sue scelte aggressivamente reazionarie, Donald Trump viene considerato da molti come l’iniziatore di una fase nuova. Al di là della sua politica sui dazi – che uno studioso autorevole come Quinn Slobodian, in una recente intervista al Domani, ha definito come un mero frutto della disperazione – la sua ideologia in generale sembra aver spazzato via ogni categoria precedente, dalla cultura woke al politicamente corretto, dalla democrazia liberale alla società aperta. In realtà, se inquadrato in un contesto più ampio, il discorso trumpiano e quello dei suoi epigoni europei non rappresentano affatto uno schema originale: sono piuttosto la forma mutata di una tendenza che comincia da lontano.
Già da venticinque anni Colin Crouch ha tematizzato il concetto di postdemocrazia, un fenomeno attraverso il quale la democrazia si è consegnata sempre più nitidamente ad interessi economici privati e si è allontanata in modo definitivo dal paradigma del bene comune, del welfare, dell’equità sociale. Ciò ne ha intaccato le fondamenta e ne ha compromesso la qualità. Nutrita di questa atmosfera, la politica mette da parte ogni impulso etico-utopico per tradursi in mera organizzazione del consenso, grazie a un uso efficace dei social media e a un gioco sottile di narrazioni e sanzioni sociali. Ecco dunque l’importanza crescente del marketing politico, il ricorso a formule mediatiche demagogiche e di facile effetto, il proliferare delle fake news. In un contesto in cui la falsa coscienza prevale, anche gli spazi per una genuina, libera discussione si fanno più stretti, e il free speech diventa per tutti un fatto scomodo. Pochi, credo, pensano ancora che le destre abbiano a cuore la libertà di espressione e non ne siano invece delle decise avversarie. Molteplici sono le evidenze: dalle amministrazioni repubblicane in Usa che tolgono i libri gender dalle scuole – rendendosi responsabili di vere e proprie forme di cancel culture – alle recenti pressioni di Jeff Bezos sul Washington Post.
A questa tendenza il mondo progressista statunitense ed europeo ha del resto contribuito non poco, abbandonando quasi del tutto – tranne alcune felici eccezioni – le lotte per dei salari più equi, per una più giusta distribuzione della ricchezza, e non da ultimo per un reale pluralismo. Interessanti sono i riflessi di tutto questo nel dibattito intellettuale ed accademico. L’antico e già forte discorso antiumanista, che nel Novecento ha avuto tanti propugnatori, negli ultimi vent’anni si è profondamente radicalizzato. Il tema dell’emancipazione dell’essere umano da ogni reificazione ha ceduto il posto a forme aggressive di identitarismo e di essenzialismo culturale, che hanno portato persino al ritorno in certi settori della sinistra di forme di biologismo razziale (giustamente denunciate da intellettuali afroamericani come Adolph Reed Jr. e Cedric Johnson) nel nome della razzializzazione. ll pensiero intersezionale, già piuttosto fragile sul piano teorico (a differenza delle ben più complesse elaborazioni francofortesi) si è spesso irrigidito in una pedagogia puramente simbolica e punitiva; gli studi postcoloniali hanno perso l’occasione di farsi lotta contro i nuovi imperialismi (come quello, ad esempio, di Vladimir Putin). Quanto agli studi di genere, non di rado le voci del femminismo libertario e antiautoritario sono state marginalizzate, escluse, tacitate (si pensi ad esempio a Nadine Strossen). I temi dell’ecologismo, che in realtà avrebbero una profonda attinenza con il riscatto dell’umano, sono stati tenuti frequentemente slegati da un’analisi di classe e sono stati presto adottati dal grande capitalismo. L’antispecismo, infine, ha a sua volta posto la questione dei diritti delle specie non umane in un modo spesso ambiguo e aporetico. In generale, comunque, si è fatto sempre più raro un discorso sulla lotta contro la razionalità del dominio – per usare una categoria francofortese – nel nome della libertà e della solidarietà planetaria tra gli esseri umani. In qualche modo sono dunque mancati gli strumenti teorici per rispondere all’avanzata di un sovranismo che fa dell’autoritarismo e della mortificazione dell’Altro le proprie bandiere; anzi, si potrebbe dire che è anche da una generale messa in questione dell’umano che è stata partorita l’ondata sovranista.
Negli ultimissimi anni, tuttavia, qualcosa fa pensare che a sinistra stia lentamente facendosi strada una tendenza nuova. Sia negli Stati Uniti che in Europa, infatti, alcune iniziative suggeriscono un rinnovato interesse per l’umanismo dopo la lunga ubriacatura postmoderna.
Nell’ambito della prassi politica, si è assistito negli Stati Uniti a un ritorno in grande stile di Bernie Sanders, l’esempio forse più coerente di un socialismo umanista in grado di contrapporsi al trumpismo; lo stesso Sanders che, nella campagna per le primarie del 2020, ebbe tra i suoi sostenitori proprio pensatori come Adolph Reed Jr. o Cedric Johnson, che proponevano una piattaforma alternativa a quella dell’identitarismo.
Anche nel mondo accademico si registrano alcuni rassicuranti segnali. Oliver Kozlarek, studioso tedesco sempre interessante, ha pubblicato lo scorso anno per Lexington un volume dal titolo “The Critical Humanism of the Frankfurt School as Social Critique”, che legge la Scuola di Francoforte come una forma di umanismo radicale in grado di rispondere ai nuovi fascismi della società contemporanea, attraverso una complementarità tra l’umanismo dialettico di Adorno e quello normativo di Erich Fromm, ma anche con riferimenti a Horkheimer e Marcuse. Una lettura che mette apertamente in discussione altre interpretazioni, anche opposte, della teoria critica.
Anche in Italia sono usciti negli ultimi anni alcuni testi significativi. Sempre l’anno scorso l’Università per Stranieri di Siena, nell’ambito del progetto di ricerca “Asian community and Europe”, ha pubblicato uno stimolante saggio dal titolo “Umanità: una nozione esclusivamente occidentale? Ripensare oggi i diritti umani con risorse della Cina antica”. L’autrice del saggio, la sinologa Amina Crisma, propone di accostarsi all’umanismo in un modo non colonialista né occidentalocentrico, e ritrova nel pensiero confuciano preziosi strumenti in tal senso. Il discorso di Confucio, in particolare nella lettura di Mencio, rivela un possibile tratto da cui far partire questa nozione di umanità: non più i valori dell’uomo bianco da estendere arbitrariamente al resto del mondo, ma un’attitudine transculturale all’empatia e alla cura, che trova espressione nel concetto cinese di “ren”.
Seguendo un percorso diverso ma parallelo, nel 2023 Lucio Cortella ha scritto per Laterza “L’Ethos del riconoscimento”, un saggio che parte da Hegel per sostenere una sorta di naturale inclinazione umana al riconoscimento dell’Altro, che ha origini insieme innate e storiche. Cortella, esponente della teoria italiana del riconoscimento, si distanzia in alcuni punti dalle formulazioni di Axel Honneth, sia per il suo uso della Fenomenologia dello Spirito come fonte privilegiata (laddove Honneth si concentra sulla Filosofia dello spirito jenese), sia per la sua indagine su autori nuovi, come lo psicologo evoluzionista Michael Tomasello, che hanno mostrato sperimentalmente come uno dei tratti salienti dell’homo sapiens sia proprio l’impulso a riconoscere l’Altro da sé, con buona pace di certo darwinismo sociale.
Sia Crisma che Cortella insistono su un punto: la relazione non deriva dal soggetto, ma gli preesiste. La relazionalità è dunque al centro di tutto.
Anche sul fronte del convegni non sono mancate le sorprese. Lo scorso 26 marzo all’Università di Bologna si è tenuta una giornata dedicata a Vittorio Capecchi, celebre sociologo italiano e fondatore della storica rivista “Inchiesta”, da sempre concentrata su un marxismo aperto, libero e interdisciplinare. Umanista critico, Capecchi era una figura estremamente all’avanguardia nel panorama della sinistra italiana. Come ha sottolineato Amina Crisma, che di Capecchi è stata la moglie, per lui il senso dell’umanità era “vita vissuta, prassi, modo di essere prima che di pensare”, e la sua regola – che risuona di particolari significati nell’era del trumpismo – era “il coraggio della speranza in tempi bui”.
Al convegno, che ha riunito alcuni degli esponenti più acuti dell’intellettualità italiana – oltre a Crisma, Franca Bimbi, Donata Meneghelli, Massimo Buscema e molti altri – e del sindacato – come il socialista Roberto Alvisi, Mario Agostinelli, Angiolo Tavanti – è emerso il ritratto di un pensatore che ha immaginato una sinistra diversa, alternativa al marxismo ortodosso ma anche a certe forme di identitarismo oggi di moda; che ha offerto illuminanti chiavi di lettura per accostarsi ai temi dell’equità sociale, del femminismo, della disabilità senza quei tratti pedagogici e borghesi di un certo accademismo odierno.
Alla fine dello scorso anno, poi, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli ha proposto due seminari di particolare rilevanza. Il più recente, tenuto dal prof. Marco Russo dell’Università di Salerno, si intitolava “Humanitas. Genealogia e avvenire di una parola chiave” e passava in rassegna il lungo percorso del paradigma dell’humanitas nella filosofia del Novecento, fino al fuoco di fila delle critiche più recenti. Accanto alla necessità di non ricadere nell’eurocentrismo o nell’occidentalocentrismo, Russo ha anche sottolineato le contraddizioni di alcune delle forme contemporanee di pensiero postumano, postcoloniale, antispecista, sostenendo che al momento in nessuno di questi ambiti sia emerso un paradigma in grado di sostituire in modo convincente quello dell’humanitas. L’altro convegno, a ottobre, era dedicato alla Lettera sull’umanismo di Heidegger, testo centrale per molto antiumanismo del Novecento. Relatore è stato Paolo Vinci, uno dei più raffinati esponenti della teoria critica italiana, del quale sono importantissimi anche i lavori sul tema del riconoscimento.
Tutto questo testimonia un inaspettato, crescente interesse per un concetto che in molteplici occasioni era stato dato per superato. È come se l’exploit del mondo reazionario stesse suscitando in risposta un ritorno al tema della critica dell’ideologia e dell’emancipazione dell’umano. Queste elaborazioni potrebbero essere una strada possibile per formulare una risposta teorica al sovranismo e per demistificare le narrazioni delle nuove destre. Vedremo cosa accadrà. Ricordando la lezione di Capecchi: il coraggio della speranza in tempi bui.
Giulio Laroni
Tratto da https://www.avantionline.it/nellera-di-trump-la-sinistra-riscopre-lumanismo/
Giulio Laroni
Critico cinematografico, documentarista, ha scritto per vari quotidiani e riviste, tra cui Il Riformista, L’Avanti!, L’Unità. È autore di un libro-intervista a Roger Corman, “Il cinema secondo Corman” (Ed. Biblion, 2016, con la prefazione di Goffredo Fofi). Ha scritto anche di politica ed è stato curatore di un’antologia di scritti di Riccardo Lombardi (Ed. Biblion, 2009, con la prefazione di Nerio Nesi).